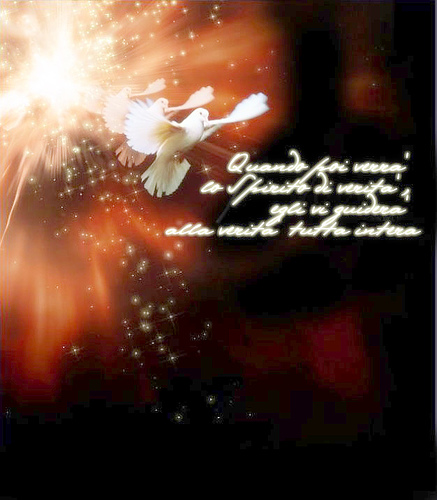
In Preparazione:
"VITA ANGELICA SULLA TERRA" di Don Giuseppe Tomaselli
LA PREGHIERA GIORNO DOPO GIORNO
di Anthony Bloom
- opera integrale -

Nella premessa a Vivere nella chiesa ci era parso importante sottolineare l’ecclesialità dell’agire del Metropolita Anthony Bloom, quasi un trait d’union delle molteplici forme assunte dal suo servizio alla chiesa ortodossa russa e ai tanti lettori dei suoi scritti spirituali. Una visione della chiesa come “madre di tutti degli uomini”, capace di farlo amare da molti cristiani non ortodossi, e da tantissimi non credenti, per anni fedeli ascoltatori delle sue parole di speranza; ma, ed è ciò che ci ha spinto a presentare al pubblico questo lavoro, un’ecclesialità fondata su un profondo spirito di preghiera.
Anthony Bloom ha scritto soprattutto su quest’ultimo tema, e quasi tutti i suoi libri sono stati tradotti in moltissime lingue, compreso l’italiano.
Perché allora procedere a una nuova raccolta di suoi scritti sulla preghiera? Almeno per due ragioni.
La prima è che ben pochi autori mostrano come Anthony Bloom una semplicità, coniugata a una notevole profondità spirituale. E la semplicità di chi possiede una visione lucida della realtà che vuole descrivere, ma è soprattutto la semplicità di cuore che cresce e si invera a partire da una profonda vita di preghiera. Dalle righe degli scritti del nostro autore emerge con forza l’indicibile esperienza di un profondo rapporto con il Signore.
Così presi per mano, siamo condotti, passo dopo passo, giorno dopo giorno, alla scoperta di un possibile itinerario di preghiera.
Come descrive Bloom stesso quando parla della propria conversione, l’esperienza di fede è indissociabile dalla percezione di una presenza. Tutta la vita “spirituale “, allora, diventa approfondimento del rapporto con questa presenza, che ben presto ci viene svelata come presenza personale. E come ogni incontro, la preghiera comporta due libertà, una capacità di attendere e di attendersi. Come ogni incontro che sia destinato a sfociare in un’amicizia essa comporta una fedeltà, un superamento degli entusiasmi iniziali, una capacità matura di rapportarsi con un altro destinato a rimanere tale. Questo Altro con cui avviene l’incontro nella preghiera, è un partner con tutte queste caratteristiche; ma non solo. Dio è creatore, ed è anche giudice: il rapporto non può essere simmetrico. E tuttavia, per vincere questa asimmetria, Dio si mostra misericordioso. Tutto allora è compreso nella sua misericordia, anche i suoi silenzi, quando ritarda un poco a farsi vivo presso di noi, che pure lo cerchiamo, per evitarci un giudizio inevitabile.
Ai cristiani è data, a parere di Bloom, una misura dello spazio che ci separa da Dio: la Scrittura; essa può attrarci, darci gioia, ferirci, turbarci; il rapporto con la Parola è inevitabile per purificare l’immagine che ci facciamo del Dio a cui ci rivolgiamo. Guidati dallo Spirito, “misurati” dalla Parola, siamo accompagnati a percepire sempre più la presenza dalla quale eravamo partiti, fino a farla diventare la musica, l’armonia di fondo che pervade tutto il nostro agire. La vera umiltà, allora diviene il far sì che questa presenza, che pure ci pone in discussione e ci fa prendere atto del nostro peccato, diventi talmente centrale nella nostra vita da farci diventare dimentichi di noi stessi. Senza illusione di poter possedere Dio, che è e resta un mistero, ma un mistero che attira i nostri cuori affinché contemplino la sua luce ineffabile.
C’è un’altra ragione, però, non meno importante, che ci ha spinti a presentare questa raccolta. Essa è stata pensata e realizzata da un uomo che ha dato e dà tuttora molto al dialogo ecumenico.
Abbiamo conosciuto Hugh Wybrew in occasione del Colloquio ecumenico di Chevetogne del 1994, e siamo rimasti subito affascinati dalla profonda semplicità e dalla capacità di lettura delle diverse tradizioni cristiane che egli ha mostrato in tutti i suoi scritti e che testimonia nella vita, anche attraverso la partecipazione alla Fellawship af St. Alban and St. Sergius, gruppo di dialogo fra anglicani-ortodossi del quale è attualmente vicepresidente. È raro trovare qualcuno capace di cogliere il filo rosso che lega tradizioni differenti dalla propria; ancor più raro è trovare uomini in grado di trasmettere agli altri i frutti della propria ricerca spirituale.
Per me pregare significa mettersi in rapporto. lo non ero credente; un bel giorno, scoprii Dio ed egli mi apparve improvvisamente come valore supremo e pienezza di vita, ma al tempo stesso come persona. Credo che la preghiera non possa dire assolutamente nulla a chi non ritiene di avere un tu al quale indirizzare la propria lode. Non si può insegnare a pregare a una persona che non avverte la presenza del Dio vivente; si può insegnarle a far finta di credere ma non sarà certo la finzione a costituire quell’atteggiamento spontaneo che è la vera preghiera.
Perciò, come premessa a questo libro sulla preghiera, quel che desidero trasmettere è la mia ferma convinzione che Dio sia una realtà personale con la quale è possibile entrare in relazione. In un secondo tempo chiederò al lettore di trattare Dio come un vicino di casa, come una persona, e di stimare questa conoscenza allo stesso modo in cui si considera il rapporto con un fratello o un amico. Questo, per me, è essenziale.
Una delle ragioni per le quali sia il culto comunitario che la preghiera privata sembrano essere così privi di calore o così convenzionali sta nel fatto che la nostra azione di lode, che ha luogo in un cuore che comunica con Dio, il più delle volte è assente. Ogni espressione, verbale o gestuale, può essere d’aiuto, ma si tratta pur sempre di espressioni di ciò che è essenziale, vale a dire un profondo silenzio di comunione.
L’evangelo ci insegna che il regno di Dio si trova prima di tutto in noi. Se non siamo capaci di trovare dentro di noi il regno, se non riusciamo a incontrare Dio interiormente, nelle profondità stesse del nostro essere, le probabilità che abbiamo di incontrarlo al di fuori sono estremamente remote. Quando Gagarin fece ritorno dallo spazio e pronunciò la famosa frase: “Non ho visto Dio da nessuna parte in cielo” uno dei nostri preti a Mosca osservò: “Se non l’hai visto sulla terra, non lo vedrai mai in cielo”.
Questo vale anche per quello di cui sto parlando. Se non riusciamo a entrare in contatto con Dio sotto la nostra pelle, se così si può dire, allora le possibilità di riconoscerlo, perfino se lo si incontrasse faccia a faccia, si riducono notevolmente.
Giovanni Crisostomo diceva: “Cerca la porta del tuo cuore, scoprirai che essa è la porta che conduce al regno di Dio”. Dobbiamo volgere il nostro sguardo verso l’interno, non verso l’esterno. Ma all’interno in un modo estremamente particolare. Non sto dicendo che bisogna diventare introspettivi. Non dico che si debba entrare nell’intimo come si fa in psicanalisi o in psicologia. Non si tratta di compiere un viaggio nella propria interiorità, ma di incamminarsi attraverso il nostro io, per approdare dal livello più profondo dell’io al luogo dove egli dimora, quel punto dove l’io e Dio si incontrano.
La preghiera è ricerca di Dio, incontro con Dio, e andare oltre quest’incontro nella comunione. E dunque un’attività, uno stato e anche una situazione; e si tratta di situarsi sia rispetto a Dio che riguardo al creato.
Essa sorge dalla presa d’atto che il mondo in cui viviamo non è semplicemente bidimensionale, imbrigliato in categorie come tempo e spazio, un piatto mondo nel quale si può incontrare solo la superficie delle cose, una superficie opaca che racchiude il vuoto.
La preghiera nasce dalla scoperta che il mondo possiede profondità, che non siamo circondati unicamente da realtà visibili, ma siamo immersi e penetrati dall’invisibile.
E questo mondo invisibile è al tempo stesso la presenza di Dio, realtà suprema e sublime, e la nostra verità più profonda.
L’incontro è centrale nella preghiera. È la categoria basilare della rivelazione, perché la rivelazione stessa è incontro con un Dio che ci offre una visione nuova del mondo. Ogni cosa è incontro, nella Scrittura come nella vita. Incontro personale e universale, unico ed esemplare.
C’è sempre un duplice aspetto in questo: incontro con Dio e in lui con tutto il creato, incontro con l’uomo nelle sue profondità radicate nella volontà creatrice di Dio, tesa al compimento, quando Dio sarà tutto in tutti.
Questo incontro è personale perché ciascuno di noi deve fame personalmente l’esperienza: non è possibile viverlo per interposta persona. Ci appartiene, ma al tempo stesso possiede un significato universale perché va oltre il nostro io superficiale e limitato.
Un tale incontro è unico perché per Dio, così come per ciascuno di noi (se veramente apriamo gli occhi), ogni persona è unica e insostituibile. Ogni creatura conosce Dio a modo suo. Ciascuno di noi conosce Dio in un modo che nessuno potrà intuire se non saremo noi stessi a descriverlo. Contemporaneamente, però, essendo la natura umana universale, ogni incontro diviene esemplare. È una rivelazione fatta a tutti di ciò che ognuno conosce in modo personale.
Un incontro è vero solo quando sono vere le persone che si incontrano. Da questo punto di vista, finiamo costantemente col contraffare l’incontro. Non solo in noi, ma nell’immagine stessa che abbiamo di Dio, ci è assai difficile essere autentici. Per tutto il giorno assumiamo una dopo l’altra una serie di “personalità sociali”, a volte irriconoscibili per chi ci sta innanzi o perfino ai nostri stessi occhi.
Quando viene l’ora della preghiera e desideriamo presentarci a Dio, ci sentiamo spesso smarriti, perché non sappiamo quale di queste personalità sociali sia la verità della nostra persona; non siamo più capaci di distinguere la nostra autentica identità. Le diverse persone che presentiamo a Dio, una dopo l’altra, non sono noi stessi. C’è del nostro in ciascuna di esse, ma la persona nella sua globalità rimane assente.
Ecco perché la preghiera, che pure sarebbe in grado di salire con forza dal cuore di una persona autentica, non trova la sua strada in mezzo al nugolo di marionette che offriamo a Dio. Ognuna di queste dice una parola che è vera nella sua parzialità, ma non esprime le altre personalità parziali che abbiamo assunto durante il giorno. Ritrovare la nostra unità, l’identità fondamentale, diventa oltremodo importante. Se ciò non accade, non possiamo incontrare il Signore nella verità.
Il Dio che incontriamo dev’essere vero tanto quanto lo siamo noi che andiamo alla sua ricerca. Ma Dio non è sempre vero? Non è forse sempre uguale a se stesso, immutabile? Certo che lo è!
Ma non è solo Dio in sé a essere coinvolto nelle nostre preghiere. È anche l’immagine che ci formiamo di lui, poiché il nostro atteggiamento dipende non solo da ciò che egli è in se stesso, ma anche da quello che noi crediamo che lui sia.
Se abbiamo immagini alterate di Dio, il nostro atteggiamento verso di lui e la nostra preghiera risulteranno adulterate di conseguenza. E importante imparare per tutto il corso della nostra vita, giorno dopo giorno, a conoscere Dio come egli è veramente.
Quando leggiamo con onestà le Scritture dobbiamo riconoscere che certi brani ci dicono ben poco. Siamo disposti ad acconsentire con Dio perché non abbiamo ragioni per essere in disaccordo con lui. Possiamo approvare questo o quel comando o quell’atto divino perché non ci tocca personalmente, non cogliamo ancora le domande che esso pone alla nostra persona.
Altri passi francamente non ci piacciono affatto. Se ne avessimo il coraggio, diremmo “No!” al Signore. Dovremmo prendere l’abitudine di annotare con cura questi brani. Sono la misura della distanza che ci separa da Dio, nonché della distanza fra ciò che siamo ora e quel che potremmo essere potenzialmente.
L’evangelo, infatti, non è un succedersi di comandi esteriori, ma un’intera galleria di quadri interiori. E ogni volta che diciamo di no all’evangelo, ci rifiutiamo di essere persone nel senso più pieno del termine.
Vi sono dei passi dell’evangelo che fanno ardere i nostri cuori, che illuminano la nostra intelligenza e scuotono la nostra volontà. Essi danno vita e forza a tutto il nostro essere fisico e morale. Questi brani rivelano quelle regioni del nostro intimo nelle quali Dio e la sua immagine coincidono di già; mostrano a che punto ci troviamo, anche solo fugacemente, per un attimo, nella via che conduce a quel che siamo chiamati a essere.
Dovremmo prendere nota con cura di questi passi, con attenzione ancora maggiore rispetto a quella prestata ai brani di cui parlavamo poc’anzi. Sono i punti in cui l’immagine di Dio è già realizzata in noi uomini decaduti a causa del peccato. Da questi inizi possiamo lottare per continuare a trasformarci nella persona che sentiamo di voler e dover essere. Dobbiamo sempre restare fedeli a queste rivelazioni.
Almeno in questo, la nostra fedeltà non deve venire mai meno.
Se facciamo quanto ho appena detto, i brani di questo genere aumentano di numero, gli appelli che l’evangelo ci rivolge si fanno più ricchi e circoscritti, le nebbie a poco a poco si diradano e possiamo scorgere l’immagine della persona che dovremmo essere. Allora, possiamo cominciare a presentarci a Dio nella verità.
Abbiamo tante occasioni per dedicarci ad abbondanti riflessioni; in un sacco di situazioni nella vita di tutti i giorni ci troviamo senza nulla da fare, eccetto aspettare; se siamo disciplinati - e questo fa parte della nostra educazione spirituale saremo capaci di ritrovare rapidamente la concentrazione per fissare l’attenzione repentinamente sull’oggetto dei nostri pensieri, del nostro meditare. Dobbiamo imparare a farlo obbligando i nostri pensieri ad aderire a un punto focale ben preciso, lasciando cadere ogni altra cosa.
Agli inizi, pensieri indesiderati irromperanno nella mente, ma se li allontaniamo con costanza, ogni volta che si presentano, alla fine ci lasceranno in pace. E solo quando grazie all’allenamento, all’esercizio, all’abitudine, si è divenuti capaci di concentrarsi profondamente e prontamente, che si può continuare per tutta la vita a vivere in uno stato di raccoglimento, noncuranti di quel che si sta facendo.
Spesso consideriamo al più, un paio di punti per poi passare al successivo. E un atteggiamento errato: abbiamo visto infatti che ci vuole un lungo tempo per ottenere il raccoglimento, per divenire come quelle persone che i padri chiamano “vigilanti”, uomini capaci di prestare attenzione a un’idea così bene e talmente a lungo che nulla di essa viene perso per strada.
Tutti gli spirituali del passato e del tempo presente ci diranno: prendi un testo, ritorna su di esso ora dopo ora, giorno dopo giorno, fino a esaurire tutte le sue risorse per l’intelletto e la tua affettività; grazie alla lettura attenta e al costante ritornare su quel testo, sei pervenuto a un nuovo atteggiamento.
Spesso la meditazione non consiste in null’altro che nell’esaminare il testo, girando e rigirando le parole che Dio ci rivolge in modo da diventare del tutto familiari con esse, talmente imbevuti della loro essenza da essere ormai una cosa sola con quelle parole. In questo cammino, anche se non riteniamo di aver scoperto nessuna particolare ricchezza intellettuale, in realtà siamo cambiati.
Meditare è un’attività del pensiero, mentre la preghiera è rifiuto di qualsiasi pensiero. Secondo quanto insegnano i padri dell’oriente, perfino i pensieri più spirituali e le considerazioni teologiche più profonde e sublimi, se compiute nel corso dell’orazione, devono essere ritenute alla stregua di una tentazione, e perciò soppresse; perché, come dicono i padri, è da stupidi pensare a Dio e dimenticare che ci troviamo in sua presenza.
Tutte le guide spirituali dell’ortodossia ci ammoniscono di non sostituire all’incontro con Dio una riflessione su di lui. La preghiera è essenzialmente stare davanti a Dio, faccia a faccia, consapevoli di dover lottare per rimanere raccolti, assolutamente nel silenzio e attenti alla sua presenza, vale a dire serbare una mente, un cuore e una volontà indivisi al cospetto del Signore. E non è affatto facile.
Per quanto possiamo aver imparato dall’educazione ricevuta, una scorciatoia si può sempre aprire in qualsiasi momento: l’unificazione può essere raggiunta da quella persona per la quale l’amore di Dio è tutto, che ha rotto ogni legame, che si è offerta completamente a Dio; allora non c’è più lotta personale, ma solo l’opera luminosa della grazia di Dio.
Fine della meditazione non è praticare una riflessione di tipo accademico; essa non intende essere un’attività puramente intellettuale, né un mero abbozzo di pensiero privo di conseguenze. Essa vuole essere un pensare sotto la guida di Dio e “verso Dio”, e per questo dovrebbe portarci a trarre conclusioni sul nostro modo di vivere. È importante rendersi conto fin da principio che una meditazione si rivela utile quando ci pone in condizione di vivere in modo più preciso e concreto le esigenze dell’evangelo.
Qualunque cosa raccogliamo, sia un versetto, o un comando, un evento della vita di Cristo, dobbiamo anzitutto pesarne il contenuto oggettivo. È estremamente importante, perché il fine per cui si medita non è la costruzione di strutture fantastiche, quanto la comprensione di una verità.
La verità sta lì, è la verità di Dio, e la meditazione si propone di costruire un ponte fra la nostra mancanza di comprensione e la verità rivelata. È un modo per educare la nostra intelligenza, per imparare gradualmente ad assumere “il pensiero di Cristo”, come dice Paolo (1Cor 2,16).
La nostra stessa giornata è benedetta da Dio. Questo non significa forse che ogni cosa che essa contiene, ogni evento che accade nel corso di essa è volontà di Dio? Credere che le cose accadono solo per caso non è credere in Dio. E se accogliamo tutto quel che avviene e ogni persona con questo spirito, ci accorgeremo che siamo chiamati a compiere l’opera dei cristiani in ogni cosa.
Ogni incontro è in Dio e in vista di lui. Siamo inviati a tutti quelli che incontriamo nel nostro cammino, sia per dare che per ricevere, a volte senza neppure saperlo. Qualche volta sperimentiamo la meraviglia di dare quel che non possediamo, altre volte ci tocca pagare con il sangue quel che diamo agli altri.
Dobbiamo anche saper ricevere. Dobbiamo essere capaci di incontrare il prossimo, di guardarlo, di ascoltarlo, di tacere, di prestare attenzione; dobbiamo saper amare e rispondere con tutto il cuore a quel che ci viene offerto, che sia gioia o amarezza, una cosa triste o qualcosa di meraviglioso. Dovremmo essere del tutto ricettivi, come della creta nelle mani di Dio. Le cose che accadono nella nostra vita, accolte come doni di Dio ci daranno per questa ragione l’occasione di rinnovare incessantemente la nostra creatività, svolgendo l’opera che compete a un cristiano.
Se osservi con attenzione la tua vita scoprirai molto presto che ben difficilmente si vive “da dentro a fuori”; rispondiamo piuttosto all’incitamento, all’eccitazione. In altre parole, viviamo di riflesso, per reazione. Qualcosa accade e noi reagiamo, qualcuno parla e noi rispondiamo.
Quando però siamo lasciati senza stimoli per il pensiero, le parole e le nostre azioni, ci accorgiamo che in noi c’è ben poco che possa spingere all’azione, in qualsiasi direzione.
È una scoperta veramente drammatica. Siamo completamente vuoti, non agiamo a partire da quel che sta in noi, ma accettiamo come fosse nostra una vita che in realtà è alimentata dall’esterno; abbiamo fatto il callo ad avvenimenti che ci obbligano a compiere a nostra volta qualcosa d’altro. Come è raro riuscire a vivere semplicemente grazie alla profondità e alla ricchezza che pensiamo esistano dentro di noi.
Il nostro punto di partenza, se desideriamo pregare, è la certezza che siamo peccatori bisognosi di essere salvati, che siamo separati da Dio e non possiamo vivere senza di lui, e che tutto quel che possiamo offrirgli è il nostro desiderio disperato di essere resi tali da poter essere accolti da Dio, accolti nel pentimento, accolti con misericordia e amore.
Dunque fin dall’inizio la preghiera è davvero la nostra umile ascesa verso Dio, un momento nel quale ci voltiamo verso di lui, avvicinandoci con timidezza, poiché sappiamo che se lo incontriamo troppo presto, prima che la sua grazia abbia avuto il tempo di aiutarci a essere capaci di incontrarlo, allora avverrà il giudizio.
Tutto quel che possiamo fare è rivolgerei a lui con profondo rispetto, con tutta la venerazione, lo spirito di adorazione, il timore di Dio di cui siamo capaci, con tutta l’attenzione e la sincerità che possediamo, per chiedergli di fare per noi qualcosa che ci metta in condizione di poterlo incontrare faccia a faccia; non per il giudizio, non per la condanna, ma per la vita eterna.
Vorrei ribadire che l’incontro fra Dio e l’uomo è pericoloso. Non è senza motivo che la tradizione orientale zen chiama il luogo in cui si trova colui che cerchiamo “la tana della tigre”. Cercare Dio è una cosa da temerari, a meno che non si tratti di un atto di completa umiltà. Incontrare Dio comporta sempre una crisi, e in greco krisis significa giudizio. L’incontro può avvenire nello stupore e nell’umiltà. Ma può anche aver luogo nel terrore e nella condanna.
Non c’è dunque da stupirsi se i manuali di preghiera ortodossi concedono molto poco spazio alle tecniche e ai metodi, mentre interminabili sono le raccomandazioni sulle condizioni morali e spirituali che debbono assolutamente essere presenti in essa. Richiamiamo anzitutto alla memoria il comando evangelico: “Se vieni al tempio e ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia la tua offerta, torna da colui che hai offeso e riconciliati con lui, poi torna a presentare la tua offerta” (Mt 5,23-24).
Questo precetto è ripreso in modo eccellente da Simeone il Nuovo Teologo, il quale ci dice che se vogliamo pregare con un cuore libero, dobbiamo riconciliarci con Dio, con la nostra coscienza, con il prossimo, perfino con gli oggetti che ci circondano. Ciò significa che la condizione per una vita di preghiera è vivere secondo l’evangelo. Una vita che fa dei comandamenti e dei consigli donatici nell’evangelo una seconda natura.
CONVERSIONE
Si vede dunque che non possiamo partecipare profondamente alla vita di Dio se non cambiamo in modo radicale. E dunque essenziale andare a Dio perché egli ci trasformi e ci renda diversi, e questa è la ragione per la quale, tanto per cominciare, dovremmo desiderare la conversione. Conversio in latino significa svolta, mutamento nella direzione del corso degli eventi. Il greco metanoia vuol dire cambiamento della mente.
Conversione significa che invece di passare la vita a guardare in ogni direzione, dovremmo seguire una direzione unica. È abbandonare moltissime cose che riteniamo di valore solo perché sono piacevoli o ci convengono. Il primo impatto con la conversione ci porta a modificare la percezione che abbiamo dei valori: quando Dio è al centro di tutto, ogni cosa viene ricollocata e acquista un nuovo spessore. Tutto quel che è di Dio, tutto ciò che gli appartiene, è positivo e reale. Ogni cosa, al di fuori di lui è priva di valore e di significato.
Ma non basta un cambiamento della mente perché si possa parlare di conversione. Possiamo cambiare mentalità e tuttavia non spingerci oltre; ciò che deve seguire è un atto di volontà, e se la nostra volontà non entra in azione per orientarsi verso Dio, allora non c’è conversione; al massimo c’è un inizio di cambiamento, ancora latente e inattivo.
PENTIMENTO
Il pentimento non va confuso col rimorso, non consiste nel sentirsi terribilmente dispiaciuti perché le cose sono andate male in precedenza; è invece un atteggiamento attivo, positivo, che consiste nel muoversi nella direzione giusta.
Ciò è estremamente chiaro nella parabola dei due figli (Mt 21,28 ) che avevano ricevuto dal proprio padre l’ordine di recarsi a lavorare nella vigna. Il primo disse: “Andrò”, ma poi non lo fece. L’altro disse: “Non andrò”, ma poi provò vergogna e si recò a lavorare.
Questo è vero pentimento, e non dovremmo mai lasciarci prendere dall’idea che lamentarsi del proprio passato sia un modo per pentirsi.
Certo, ei vuole anche questo, ma il pentimento resta sterile e irreale. Noi tendiamo a pensare che dovrebbe sfociare in belle emozioni e spesso ci accontentiamo delle emozioni, invece di cercare cambiamenti reali e profondi.
IL DIO NOTO E IL DIO IGNOTO
Possiamo aver capito un sacco di cose riguardo a Dio, a partire dalla nostra esperienza, da quella degli altri, dagli scritti dei santi, dall’insegnamento della chiesa, dalla testimonianza delle Scritture; possiamo sapere che egli è buono, che è umile, che è un fuoco divorante, che è il nostro giudice, che è il nostro salvatore e altro ancora, ma dobbiamo ricordarci che in ogni istante egli può rivelarsi in un modo mai sperimentato in precedenza, anche all’interno di queste categorie generali.
Dobbiamo prender posto innanzi a lui con riverenza ed esser pronti a incontrare chiunque ei capiterà di incontrare, sia il Dio col quale già siamo familiari, sia un Dio che non riusciamo a riconoscere. Egli può darci la percezione di ciò che è, e questa potrebbe essere assai diversa da quel che ci aspettiamo. Noi speriamo di incontrare Gesù, dolce, compassionevole, affettuoso, e ci viene incontro un Dio che giudica, che ci condanna e non ci lascia avvicinare a lui finché restiamo così come siamo. Oppure veniamo nel pentimento, aspettandoci di essere respinti, e incontriamo compassione.
Dio, in ogni momento, è per noi in parte noto e in parte ignoto. Egli si rivela, e dunque lo conosciamo, ma non lo conosceremo mai in pienezza, rimarrà sempre il mistero divino, il cuore di un mistero che non riusciremo mai a penetrare.
IL SILENZIO DI DIO
L’incontro fra Dio e noi nell’orazione continua parte sempre dal silenzio. Dobbiamo imparare a distinguere due generi di silenzio: il silenzio di Dio e il nostro silenzio interiore. Anzitutto il silenzio di Dio, spesso più difficile da sopportare del suo rifiuto, quel silenzio assente di cui già abbiamo detto. In secondo luogo, il silenzio dell’uomo, più fecondo del nostro parlare, in una comunione più stretta con Dio di quella mediata da qualsiasi parola.
Il silenzio di Dio di fronte alla nostra preghiera può durare solo per un attimo, o può sembrare che vada avanti all’infinito. Cristo restò in silenzio di fronte alle suppliche della cananea, e questo lo condusse a raccogliere tutta la propria fede, la speranza e l’amore umano per offrirli a Dio, per far sì che egli potesse estendere i confini del suo regno al di là del popolo eletto. Il silenzio di Cristo suscitò quindi la risposta della donna, la fece crescere di qualità.
E Dio può fare lo stesso nei nostri riguardi, con silenzi di maggiore o minore durata, che chiamano a raccolta le nostre forze e la nostra fedeltà e ci conducono a un rapporto più profondo con lui rispetto a quello che si sarebbe potuto realizzare se la via fosse stata facile. Ma a volte il silenzio per noi assume il suono tetro dell’irrevocabile.
IL SILENZIO DELL’UOMO
Il silenzio di Dio è la sua assenza, ma anche il silenzio è l’assenza dell’uomo. Un incontro non acquista spessore e pienezza finché le due parti che convergono non diventano capaci di tacere l’una con l’altra. Fino a quando abbiamo bisogno di parole e azioni, di prove tangibili, non abbiamo ancora raggiunto la profondità e la pienezza che cercavamo. Non abbiamo fatto esperienza di quel silenzio che avvolge due persone che condividono una certa intimità. Va molto in profondità, assai più di quello che credevamo, il silenzio interiore in cui incontriamo Dio, e con Dio e in Dio il nostro prossimo.
In questo stato di quiete non c’è bisogno di parole per sentirsi vicini al nostro compagno, per comunicare con lui nel nostro essere più profondo, al di là di noi stessi in qualcosa che ci unisce. E quando il silenzio si fa sufficientemente profondo, possiamo iniziare a parlare dalle sue profondità, pur con prudenza e cautela per non rovinarlo con il disordine rumoroso che sta nelle nostre parole. Allora, il nostro pensiero è contemplazione.
La mente, invece di cercare di distinguere fra forme molteplici, come è abituata a fare, cerca di fame emergere di semplici e radiose dagli abissi del cuore. La mente sta compiendo il suo vero lavoro. Serve colui che esprime qualcosa di più grande di lei. Scrutiamo profondità che ci trascendono e cerchiamo di esprimere qualche frammento di quel che abbiamo trovato con timore e rispetto. Parole di questo genere, quando non rendono volgare o cerebrale quest’esperienza nel suo insieme, non rompono il silenzio, ma lo esprimono.
CONCENTRARSI SU DIO E NIENT’ALTRO
Dio deve restare sempre al centro della nostra attenzione, perché il nostro raccoglimento può essere falsificato in molti modi; quando preghiamo per qualcosa che ci preoccupa profondamente, ci sembra che tutto il nostro essere converga in un’unica preghiera e pensiamo di essere in uno stato di raccoglimento profondo, autentico, colmo di preghiera; ma non è vero: al centro dell’attenzione non c’era Dio, ma l’oggetto della nostra preghiera.
Quando siamo coinvolti emotivamente nessun pensiero alieno s’intromette, perché siamo completamente dediti all’oggetto della nostra preghiera; la nostra attenzione si dissolve repentinamente solo quando ci mettiamo a pregare per qualche altra persona o esigenza; questo indica che non era il pensiero di Dio, né l’avvertire la sua presenza a provocare la nostra concentrazione, bensì le nostre preoccupazioni umane.
Questo non vuol dire che la sollecitudine per ciò che è umano sia senza importanza, ma è indice del fatto che il pensiero di un amico può ben di più che il pensare a Dio, e questo è un fatto serio.
PREGARE NEL REGNO
Per poter pregare, dobbiamo trovarci in quella situazione che definiamo “regno di Dio”. Dobbiamo riconoscere che lui è Dio, che è re, dobbiamo arrenderci a lui. Dobbiamo quantomeno preoccuparci della sua volontà, anche se ancora non siamo in grado di compierla.
Se però non lo siamo, se trattiamo Dio come quel giovane ricco che non poteva seguire Cristo perché aveva troppe ricchezze, come possiamo incontrarlo? Il più delle volte quel che perseguiamo attraverso la preghiera, mediante quel profondo rapporto con Dio che tanto desideriamo, non è altro che un nuovo periodo di felicità; ma non siamo preparati a vendere tutti i nostri averi per comprare la perla di grande valore.
Ma come dovremmo procurarci, allora, questa perla di grande valore? È a essa che si rivolgono le nostre attese? Non avviene forse lo stesso nei rapporti umani: quando un uomo e una donna provano amore l’uno per l’altra, gli altri non hanno più la stessa importanza di prima. Per dirla con una formula concisa del tempo antico: “Quando un uomo ha una donna al suo fianco, non è più circondato da uomini e donne, ma dalla gente”. Non potrebbe essere, anzi, non dovrebbe essere così per ciò che concerne ogni nostra ricchezza quando volgiamo il nostro sguardo verso Dio?
DIO AL PRIMO POSTO
L’amore e l’amicizia non crescono se non siamo disposti a sacrificare molte cose per coltivarli, e allo stesso modo dobbiamo esser pronti a mettere da parte tante realtà per assegnare a Dio il primo posto.
“Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le tue forze e con tutta la tua mente” (Lc 10,27). Sembra che questo sia un comando semplice, eppure sono parole che contengono molto di più di quello che si percepisce a prima vista. Noi tutti sappiamo cosa significhi amare qualcuno con tutto il cuore; sappiamo il piacere, non solo di incontrare ma perfino di richiamare alla mente la persona amata, con il caldo conforto che ne consegue. E in quel modo che dovremmo cercare di amare Dio, e ogni volta che il suo Nome viene menzionato, il nostro cuore e la nostra anima dovrebbero riempirsi di un calore infinito. Dio dovrebbe essere nella nostra mente in ogni istante, ma purtroppo noi pensiamo a lui solo di rado.
Possiamo amare Dio con tutte le forze solo se ci disfiamo deliberatamente di tutto ciò che non appartiene a Dio in noi; con uno sforzo di volontà dobbiamo volgere costantemente lo sguardo verso Dio, sia nella preghiera, il che è più semplice, perché in essa già siamo posti in Dio, che nell’azione, cosa che richiede un certo allenamento, poiché nel nostro agire siamo concentrati su obiettivi materiali e dobbiamo orientarli a Dio con uno sforzo speciale.
IL MISTERO DELL’ESSERE
Qualunque cosa facciamo, quale che sia il nostro livello di conoscenza di Dio, per quanto gli siamo vicini (e ciò vale ancor più fra Dio e l’uomo che fra gli uomini), permane un mistero centrale che non è mai possibile dissipare. Nel libro dell’Apocalisse c’è un passo meraviglioso nel quale Giovanni dice che quanti entreranno nel regno riceveranno in consegna una pietra bianca nella quale è scritto un nome, e tale nome è noto soltanto a Dio e a ciascuno di essi.
Questo nome non è quello con il quale siamo etichettati e chiamati in questo mondo. Il nostro vero nome, il nostro nome eterno è plasmato con accuratezza per noi, calza perfettamente sul nostro essere. Ci definisce e ci esprime completamente. È noto solo a Dio, ed è lui a comunicarcelo. Nessun altro può conoscerlo, perché esprime il nostro legame unico con colui che ci ha creati.
Quante volte i nostri rapporti umani vanno in sfacelo perché una persona vuole rivelare se stessa al di là del possibile, oppure l’altro vuole indagare in un, territorio che è consacrato unicamente a Dio. È un desiderio vano e non può essere adempiuto. È come un bambino che cerca di risalire alle fonti di una sorgente, al punto dove ha origine il flusso d’acqua, quel punto prima del quale l’acqua non c’è. In questo modo si può solo distruggere, non si può scoprire.
PREGHIERA PIENA DI SIGNIFICATO
A meno che la preghiera che intendi offrire a Dio non sia importante e piena di significato anzitutto per te, non sarai in grado di presentarla al Signore. Se non presti attenzione alle parole che proferisci, se il tuo cuore non risponde loro, o se la tua vita non è orientata in sintonia con la preghiera, questa non sarà protesa verso Dio.
Dunque devi per prima cosa scegliere una preghiera che puoi dire con tutta la mente, con tutto il cuore e con tutta la volontà, una preghiera che non ha necessariamente bisogno di essere un modello di arte liturgica, ma che dev’essere autentica, qualcosa che non sia inadeguato a ciò che vuoi esprimere. Devi comprendere la tua preghiera, in tutta la ricchezza e la precisione che essa possiede.
Devi anche mettere tutto il tuo cuore nell’atto con cui adori, un atto con cui riconosci Dio, ti prendi cura di lui, e questo è il vero significato dell’amore, un’azione che ti coinvolge nella mente, nel cuore, un’azione totalmente adeguata a ciò che sei tu.
AL DI LÀ DEGLI UMORI
Quando assumiamo il giusto quadro mentale, quando il cuore è colmo di adorazione, di sollecitudine per gli altri, quando, come dice Luca, le nostre labbra parlano dalla pienezza del cuore (Lc 6,45), non è un problema pregare; parliamo a Dio con libertà facendo uso delle parole a noi più familiari.
Ma se dovessimo abbandonare la nostra vita di preghiera alla mercè dei nostri stati d’animo, finiremmo probabilmente per pregare di quando in quando con fervore e sinceramente, ma perderemmo per lunghi tratti qualsiasi contatto orante con Dio. Grande è la tentazione di differire la preghiera fino al momento in cui ci sentiamo vivi innanzi a Dio, e di considerare privi di sincerità qualsiasi preghiera e ogni passo in direzione di Dio compiuti in tempi nei quali la sincerità è carente. Sappiamo tutti dall’esperienza che in noi abita tutta una serie di sentimenti che non emergono in ogni momento della nostra vita; la malattia o la stanchezza possono nasconderli alla nostra consapevolezza. Anche quando amiamo profondamente, vi sono dei momenti in cui non ce ne rendiamo conto e tuttavia sappiamo che l’amore è vivo dentro di noi.
Lo stesso rimane vero riguardo a Dio; ci sono cause interne ed esterne che rendono difficile a volte la percezione del fatto che crediamo, che abbiamo in noi la speranza, che davvero amiamo Dio. In quei momenti dobbiamo agire confidando non in ciò che sentiamo, ma in quello che sappiamo.
L’IRRILEVANZA DELLE EMOZIONI
Nel nostro sforzo per cercare di pregare le emozioni sono pressoché irrilevanti; quel che dobbiamo portare a Dio è la nostra determinazione piena e ferma a essergli fedeli e a sforzarci di farlo dimorare in noi. Dobbiamo ricordare che frutto della preghiera non è questo o quello stato emotivo, ma un cambiamento profondo nell’insieme della nostra personalità.
Noi aspiriamo a esser resi degni di stare davanti a Dio e di concentrarci sulla sua presenza, essendo tutti i nostri desideri rivolti verso Dio, e aspiriamo a ricevere la potenza, la forza, tutto ciò di cui abbiamo bisogno perché la volontà di Dio si compia in noi. Che si compia in noi la sua volontà dovrebbe essere l’unico scopo della nostra preghiera, ed è anche il criterio per discernere se stiamo pregando in modo corretto. La buona preghiera non è data da una sensazione mistica o dalle nostre emozioni.
Teofane il Recluso dice: “Ti domandi: ‘Oggi ho pregato?’. Non cercare di sondare la profondità delle tue emozioni, o quanto profonda sia la tua comprensione delle cose divine; chiediti piuttosto: ‘Sto compiendo la volontà di Dio meglio di prima?’. Se è così, la preghiera ha dato i suoi frutti; se non è così, per quanta comprensione tu possa aver tratto dal tempo che hai trascorso in presenza del Signore, e quali che siano le emozioni che hai provato, la preghiera non ha dato i suoi frutti”.
VOLONTÀ E VITA CRISTIANA
La concentrazione, sia nella meditazione che nella preghiera, la si può raggiungere solo grazie a uno sforzo di volontà. La nostra vita spirituale si edifica a partire dalla fede e dalla determinazione, e qualsiasi gioia inerente a essa è un dono di Dio. Serafino di Sarov, a quanti gli domandavano cosa fa sì che alcuni rimangano peccatori senza mai progredire mentre altri diventino santi, viventi in Dio, era solito rispondere: “Null’altro che la determinazione”.
Le nostre attività devono essere determinate da un atto della volontà, il che, di solito, va in direzione opposta ai nostri desideri; questa volontà, fondata sulla fede, cozza sempre contro un’altra volontà, che viene dal nostro istinto. In noi risiedono due volontà, di cui una è quella cosciente, che si possiede in misura più o meno elevata, e che consiste nella capacità di costringere noi stessi ad agire in accordo con le nostre convinzioni. La seconda è qualcosa d’altro. Sono le voglie, le aspirazioni, i desideri di tutta la nostra natura, spesso contrari al primo tipo di volontà.
Paolo parla delle due leggi in lotta l’una con l’altra (Rm 7,23). Descrive il nuovo e l’antico Adamo che sono in noi, che si fanno guerra. Non basta puntare alla vittoria del bene contro il male; ciò che è perverso, ovvero i desideri della nostra natura decaduta, dev’essere assolutamente, anche se gradualmente, trasformato in un ardente desiderio, in sete di Dio. La lotta è dura e a tutto campo.
DISCIPLINA NELLA SEQUELA
Fare la volontà di Dio è una disciplina nel senso più nobile del termine. È anche una verifica della nostra lealtà, della fedeltà che abbiamo verso Cristo. È agendo in ogni dettaglio, in ogni momento, con tutte le nostre forze, al limite delle nostre possibilità, con la più grande integrità morale, facendo uso della nostra intelligenza, dell’immaginazione, della volontà, dei carismi e dell’esperienza che possiamo gradatamente imparare a essere strettamente e onestamente obbedienti al Signore Dio.
Se non facciamo questo la nostra sequela è illusoria e tutta la nostra vita di disciplina, quando risulta essere un insieme di regole autoimposte nelle quali ci dilettiamo e che ci rendono orgogliosi e autogratificati, non ci porta da nessuna parte, perché la spinta essenziale della nostra sequela sta nella capacità di rinnegare noi stessi, permettendo a Cristo Signore di essere la nostra mente, la nostra volontà e il nostro cuore. A meno di rinunciare a noi stessi e di accettare la sua vita al posto della nostra, a meno di ambire a ciò che Paolo descrive dicendo: “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20), non saremo mai né disciplinati né discepoli.
DISCIPLINA E GRAZIA
La disciplina spirituale è una strada, un cammino nel quale ci apriamo a Cristo, alla grazia di Dio. Questa è tutta la disciplina, tutto quel che possiamo fare. È Dio che, rispondendo al nostro sforzo ascetico, ci dà la sua grazia e porta a compimento i nostri sforzi.
Tendiamo a pensare che ciò a cui dobbiamo ambire è una vita mistica elevata e profonda. Non è a questo che dovremmo tendere. Una vita mistica è dono di Dio; in sé non è opera nostra e ancor meno l’espressione della nostra dedizione a Dio.
Ciò a cui dobbiamo mirare in risposta all’amore che Dio ha dichiarato e manifestato in Cristo, è diventare discepoli autentici offrendoci in sacrificio a Dio; da parte nostra è lo sforzo ascetico a costituire la vetta della nostra lealtà, della fedeltà e dell’amore. Dobbiamo offrire questo a Dio ed egli adempirà ogni promessa che ci ha fatto. “Figlio, dammi il tuo cuore: esaudirò ogni cosa”.
PREGHIERA E VITA
Finché continuiamo a occuparci profondamente di tutte le trivialità della vita, non possiamo sperare di pregare con tutto il cuore; queste finiranno sempre per colorare il treno dei nostri pensieri. Lo stesso vale per i nostri rapporti quotidiani con la gente, rapporti che non dovrebbero consistere soltanto nel pettegolezzo ma che dovrebbero essere basati su ciò che in ciascuno di noi è essenziale; in caso contrario, potremmo trovarci incapaci di raggiungere un livello differente quando volgiamo la nostra attenzione a Dio.
Dobbiamo estirpare ogni cosa priva di significato e volgare che dimora in noi e nei nostri rapporti con gli altri, per concentrarci su quelle cose che saremo in grado di portare con noi nell’eternità.
Non è possibile diventare un’altra persona nel momento in cui iniziamo a pregare, ma vigilando sui propri pensieri si impara gradualmente a differenziare il loro valore. E nella vita quotidiana che coltiviamo i pensieri che irrimediabilmente vengono a galla nell’ora della preghiera. La preghiera, a sua volta, muterà e arricchirà la nostra vita di tutti i giorni, divenendo il fondamento di un rapporto nuovo e reale con Dio e con quanti ci circondano.
PREGHIERA E IMPEGNO
Le parole della preghiera possiedono la caratteristica di essere sempre parole che impegnano. Non puoi proferire parole di preghiera senza intendere implicitamente: “Se dico questo, allora è quanto mi accingo a compiere, non appena si presenterà l’occasione”. Quando dici a Dio: “A qualsiasi prezzo, a qualsiasi prezzo, salvami, Signore”, devi ricordarti che devi porre in ciò tutta la tua volontà, perché un giorno Dio dirà: “Ecco il prezzo da pagare”.
Gli anziani scrivevano: “Dai il tuo sangue e Dio ti darà lo Spirito”. Questo è il prezzo da pagare. Abbandona tutto, riceverai il paradiso; abbandona la schiavitù, acquisirai la libertà. Così come la tua volontà è già coinvolta non solo nell’atto del pregare ma in ogni conseguenza della tua preghiera, allo stesso modo deve accadere per il corpo, perché un essere umano non è soltanto un’anima intrappolata provvisoriamente in un corpo. E un essere che è anima e corpo, un unico essere: l’uomo.
C’è uno sforzo fisico che si deve compiere nella preghiera, un’attenzione fisica, una maniera fisica di pregare. Il digiuno, se il cibo ti ha reso troppo pesante per la preghiera, fa parte di tale sforzo. Se fai queste cose, sarà per te come bussare a una porta.
PREGHIERA CRISTIANA
Caratteristica della preghiera cristiana è che si tratta della preghiera di Cristo, portata a suo Padre, di generazione in generazione in situazioni sempre nuove, da quanti sono, per grazia e partecipazione, la presenza di Cristo in questo mondo; è una preghiera continua e incessante a Dio, perché si compia la sua volontà, perché tutto avvenga secondo il suo disegno sapiente e pieno d’amore.
Questo significa che la nostra vita di preghiera è al tempo stesso una lotta contro tutto ciò che non è di Cristo. Prepariamo il terreno per la preghiera ogni volta che lasciamo perdere qualcosa che non appartiene a Cristo, che non è degna di lui, e solo la preghiera di chi, come Paolo, può dire “Io vivo, non io, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20) è vera preghiera cristiana.
SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ
Dato che la chiesa è un’estensione della presenza di Cristo nel tempo e nello spazio, in qualsiasi preghiera cristiana dovrebbe essere Cristo stesso che prega, sebbene questo implichi una purezza di cuore che noi non possediamo. Le orazioni della chiesa sono le preghiere di Cristo, particolarmente nella preghiera eucaristica, dove è Cristo che prega dall’inizio alla fine; ogni altra preghiera, però, nella quale chiediamo qualcosa che riguardi una situazione concreta è sempre preceduta da un “se”.
Nella maggior parte dei casi non sappiamo per cosa avrebbe pregato Cristo in una simile situazione, e per questo introduciamo il “se”, volendo significare che per quanto ci è dato di vedere, per quel che sappiamo della volontà di Dio, questo è quanto desideriamo avvenga perché si compia la sua volontà.
Ma il “se” significa anche: ripongo in queste parole il mio desiderio che avvenga la cosa migliore; per questo tu puoi mutare questa richiesta concreta in qualsiasi cosa di tuo gradimento, assumendo la mia intenzione, il desiderio che si compia la tua volontà, anche se io sono così stolto da esporre come mi piacerebbe che essa venga compiuta (Rm 8,26).
IL SILENZIO DELLA SEQUELA
La sequela inizia con il silenzio e l’ascolto. Quando ascoltiamo qualcuno, pensiamo di essere in silenzio perché non parliamo; ma le nostre menti continuano a lavorare, le nostre emozioni reagiscono, la nostra volontà si schiera pro o contro quel che stiamo ascoltando; possiamo anche spingerei oltre, in pensieri e sentimenti che ronzano nella testa e che nulla hanno a che vedere con quello che viene detto. Questo non è il silenzio di cui la sequela ha bisogno.
Il vero silenzio al quale dobbiamo tendere come punto di partenza è un riposo totale della mente, del cuore e della volontà, il silenzio totale di tutto ciò che è in noi, compreso il nostro corpo, di modo che possiamo essere pienamente consapevoli delle parole che stiamo udendo, completamente all’erta e tuttavia nella quiete più totale.
Il silenzio di cui sto parlando è il silenzio della sentinella che monta la guardia in un momento critico: vigile, immobile, con lo sguardo fisso e tuttavia attenta a ogni suono, a ogni movimento. Questo silenzio di attesa è il primo requisito della sequela, e non lo si ottiene senza un certo sforzo. Richiede da parte nostra che alleniamo l’attenzione, il corpo, la mente e le emozioni, perché ogni cosa sia mantenuta completamente e perfettamente in ordine.
UN CORPO PACIFICATO
Dobbiamo imparare ad acquisire un corpo pacificato. Quale che sia la nostra attività psicologica, il nostro corpo reagisce a essa, e il nostro stato corporeo determina in una certa misura il tipo o la qualità della nostra attività psicologica.
Teofane il Recluso, nei suoi consigli rivolti a chi desidera dedicarsi alla vita spirituale, afferma che una delle condizioni indispensabili per riuscire in essa è non permettersi mai la rilassatezza del corpo: “Siate come corde di violino, accordate secondo una nota ben precisa, senza rilassamento o tensione eccessiva, con il corpo eretto, le spalle dritte, un portamento agile della testa, le tensioni di ogni muscolo orientate verso il cuore”.
Molto è stato scritto e detto sui modi in cui il corpo può essere sfruttato per aumentare la capacità di attenzione; ma a un livello accessibile a molti, il consiglio di Teofane suona semplice, preciso e pratico. Dobbiamo imparare a rilassarci e contemporaneamente a essere pronti. Dobbiamo dominare il nostro corpo in modo che non sia d’intralcio, ma renda più facile il raccoglimento.
PREGHIERA PURIFICATA
A volte pensiamo che non siamo degni di pregare, e perfino che non ne abbiamo il diritto. È una tentazione. Ogni goccia d’acqua, da qualsiasi parte provenga, da una pozzanghera come dall’oceano, viene purificata mediante l’evaporazione; lo stesso è di ogni preghiera che sale a Dio.
Più ci sentiamo avviliti, e più abbiamo bisogno di pregare. E senz’altro quello che provò un giorno Ivan di Cronstadt quando, mentre pregava sotto lo sguardo di un demonio, questi gli borbottò: “Tu, ipocrita, come osi pregare con la tua mente sudicia, piena dei pensieri che vi ho letto?”. Egli rispose: “È proprio perché la mia mente è colma di pensieri che mi disgustano e contro i quali combatto che sto pregando Dio”.
PREGHIERA SPONTANEA
La preghiera spontanea è possibile in due situazioni: essa ha luogo in momenti nei quali avvertiamo vivamente la presenza di Dio, quando questa consapevolezza ci chiede una risposta orante, gioiosa, quando richiama tutte le forme di risposta che siamo in grado di offrire, essendo noi stessi e presentandoci al Dio vivente; oppure quando, improvvisamente, ci accorgiamo del pericolo mortale nel quale ci troviamo venendo a Dio, momenti nei quali improvvisamente sale dalle nostre profondità un grido di disperazione e di scoramento, o anche dalla sensazione che non vi sia speranza di salvezza per noi a meno che sia Dio a salvarci.
La preghiera spontanea deve sgorgare dall’anima, non possiamo semplicemente girare un rubinetto e aspettarci che esca. Non è lì perché possiamo attingerla e usarla in ogni momento. Viene dalle profondità della nostra anima, dallo stupore o dall’angoscia, ma non viene dalla situazione media nella quale non siamo né sommersi dalla presenza divina né sopraffatti dalla percezione di chi siamo e dove ci troviamo. In quei momenti di grigiore, cercare di ricorrere alla preghiera spontanea è un esercizio completamente illusorio.
PREGHIERA DI CONVINZIONE
Abbiamo bisogno di alcune forme di preghiera profondamente radicate nella convinzione, diverse dalla preghiera spontanea. Per trovare tali forme si può attingere a molte orazioni che sono a nostra disposizione. Possediamo infatti già un ricco armamentario di preghiere scritte negli spasmi della fede, dallo Spirito santo.
Abbiamo ad esempio i Salmi; possediamo un gran numero di preghiere lunghe e brevi nel tesoro liturgico di tutte le chiese, e a esse possiamo attingere. Quel che conta è imparare e conoscere un numero sufficiente di tali preghiere e avere, al momento giusto, la possibilità di trovare le parole giuste per pregare. E questione di apprendere a memoria un certo numero di passi significativi, dei Salmi come delle preghiere dei santi.
Imparate quei passi, perché nel giorno in cui sarete così demoralizzati, così profondamente disperati da non poter far emergere dalla vostra anima nessuna espressione spontanea, nessuna frase che sia vostra, scoprirete che queste parole emergono e si offrono a voi come un dono di Dio, un dono della chiesa, un dono della santità, che viene in soccorso alla nostra mancanza di forze. Allora sì che si ha bisogno delle preghiere che si sono imparate e che abbiamo reso una parte di noi.
PREGHIERA CONTINUA
Un ultimo modo per pregare è l’utilizzo, più o meno ininterrotto, di preghiere vocali che fungano da sottofondo, da bastone da passeggio, lungo tutto l’arco della giornata e per tutta la vita.
Penso a qualcosa che si riferisce in modo specifico alla tradizione ortodossa. È quella che chiamiamo la “preghiera di Gesù”, una preghiera incentrata sul nome di Gesù. “Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore”. Questa preghiera è usata non solo da monaci e monache ma anche da semplici cristiani.
È la preghiera della stabilità, perché non è un’orazione discorsiva - non ci muoviamo da un pensiero a un altro pensiero - è una preghiera che ci pone faccia a faccia con Dio mediante una professione di fede in lui, e definisce una situazione che riguarda noi stessi. È una professione di fede che, secondo il pensiero di molti asceti e mistici ortodossi, riassume in sé tutto l’evangelo.
PREGHIERA COSTANTE
È difficile pregare per un giorno intero. A volte proviamo a immaginare come potrebbe essere. Pensiamo alla vita liturgica dei monaci contemplativi oppure alla vita di preghiera di un anacoreta. Non ci capita spesso di pensare a una vita di preghiera che abbia luogo in una vita ordinaria, nella quale tutto diventi preghiera o occasione di preghiera. Ma questo è un modo facile per pregare, sebbene sia ovviamente molto esigente.
Alziamoci al mattino e offriamoci a Dio. Ci siamo risvegliati da un sonno che ci separa dalla giornata precedente. Il risveglio ci offre una nuova realtà, un giorno mai esistito prima, un tempo e uno spazio sconosciuti si spiegano davanti a noi come un campo di neve intatta. Chiediamo al Signore di benedire questa giornata, e di benedire noi in essa.
Quando abbiamo fatto questo, prendiamo sul serio la nostra richiesta, così come la risposta silenziosa che ci è stata data. Siamo benedetti da Dio, la sua benedizione sarà sempre con noi, in ogni nostra azione perché questa sia capace di accogliere tale benedizione. La perderemo solo quando volgeremo lo sguardo lontano da Dio. E Dio sarà con noi anche allora, pronto a venire in nostro aiuto, disposto a renderci la grazia che abbiamo respinto.
DOMANDA
Molte delle nostre preghiere sono preghiere di domanda, e sembra che la gente pensi alla domanda come alla forma più bassa della preghiera; più in alto c’è la gratitudine, in cima la lode.
Ma in realtà sono la gratitudine e la lode a essere espressione di un rapporto inferiore. Al nostro livello mediocre di fede è più facile cantare inni di lode o rendere grazie a Dio piuttosto che fargli fiducia in misura sufficiente da chiedergli qualcosa con fede. Anche persone che credono tiepidamente possono volgersi a ringraziare Dio quando qualcosa di piacevole capita nella loro vita; e ci sono momenti di esaltazione in cui tutti sono capaci di cantare a Dio.
Ma è ben più difficile avere una tale fede indivisa da rivolgere una domanda con tutto il cuore e con tutta la mente, nella fiducia più totale. Nessuno dovrebbe guardare con sussiego alla preghiera di domanda, perché la capacità di dire tali preghiere è una verifica dell’autenticità della nostra fede.
SFERRUZZANDO DAVANTI A DIO
Ricordo che una delle prime persone che venne a chiedermi consigli dopo che ero stato ordinato presbitero fu una vecchia signora che disse: “Padre, ho pregato quasi incessantemente per quattordici anni, e non ho mai avvertito la presenza di Dio”. Allora le dissi: “Gli ha dato una chance di proferire anche solo una parola?”. “Oh no” mi disse, “ho parlato io per tutto il tempo, non è forse questa la preghiera?”. Le dissi: “No, non penso che lo sia, e quel che le suggerisco è di mettere da parte quindici minuti ogni giorno, restando seduta a sferruzzare davanti al volto di Dio”.
E così fece. Con quale risultato? Presto venne da me e disse: “È straordinario, quando prego Dio, in altre parole quando gli parlo, non sento nulla, ma quando mi siedo nella calma, faccia a faccia con lui, allora mi sento avvolta dalla sua presenza.
Non sarai mai in grado di pregare Dio realmente e con tutto il tuo cuore se non impari a tacere e a gioire a causa del miracolo della sua presenza, o se preferisci, del tuo stare faccia a faccia con lui anche se non lo vedi.
IL SENSO DELLA PRESENZA DI DIO
Se impari a far uso di una preghiera che hai scelto nei momenti in cui puoi dedicare tutta la tua attenzione alla presenza divina e offri a Dio questa preghiera, quello che accade poco alla volta è che la consapevolezza di Dio cresce in te a tal punto che sia che tu stia in mezzo alla gente, ascoltando e parlando, sia che te ne stia solo a lavorare, questa consapevolezza è così forte che anche se sei con delle persone riuscirai ancora a pregare.
Quando piove su di noi una grande gioia, un grande dolore o un grande dispiacere, non li dimentichiamo nel corso della giornata. Ascoltiamo la gente, svolgiamo la nostra attività lavorativa, leggiamo, facciamo quel che dobbiamo fare, e il dolore per quel che abbiamo perso, o la consapevolezza della nostra gioia, della notizia esilarante, rimane incessantemente con noi. Lo stesso dovrebbe accadere con il senso della presenza di Dio.
E se il senso della presenza di Dio è così chiaro, allora si può pregare mentre si è occupati in altre faccende. Si può pregare mentre si fa un lavoro fisico, ma anche quando si sta con la gente, in ascolto o anche impegnati in qualche forma di conversazione o di relazione. Non è comunque questa la prima cosa che ci succede, e dobbiamo educare noi stessi anzitutto ad acquisire un atteggiamento di attenzione adorante e un cuore contrito, in condizioni che permettono di sviluppare questi atteggiamenti, perché è facile distrarsi, scivolando nella preghiera dalla vigilanza al sogno.
CONTEMPLAZIONE E INTERCESSIONE
Il fatto che siamo presenti in una situazione la cambia profondamente perché Dio si rende allora presente con noi, mediante la nostra fede. Ovunque siamo, a casa con la nostra famiglia, con gli amici quando sta per scoppiare una lite, al lavoro o semplicemente in metropolitana, per la strada, in treno, possiamo raccoglierei e dire: “Signore, io credo in te, vieni in mezzo a noi”.
È grazie a questo atto di fede, in una preghiera contemplativa che non ha bisogno di vedere, possiamo intercedere presso Dio che ha promesso di essere presente quando noi lo invochiamo. A volte ci mancano le parole, altre volte non sappiamo come comportarci in modo sensato, ma possiamo sempre chiedere a Dio di venire e di rendersi presente. E ci accorgeremo che muterà spesso l’atmosfera, avranno fine le liti, verrà la pace.
Questo non è un modo meno importante di intercedere, quantunque sia meno spettacolare di un grande sacrificio. In esso vediamo ancora una volta come contemplazione e azione siano inseparabili, e come l’azione cristiana sia impossibile senza la contemplazione. Vediamo pure come la contemplazione non sia allora una visione di Dio e basta, ma una visione profonda di ogni realtà che ci mette in condizione di coglierne il significato eterno. La contemplazione non è la visione di Dio e nient’altro, ma del mondo in lui.
PREGHIERA SENZA RISPOSTA
“Chiedete e vi sarà dato”(Mt 7,7). Queste parole sono una spina nel fianco per la coscienza dei cristiani, e non possono essere accolte né essere respinte. Rifiutarle vorrebbe dire un rifiuto dell’infinita gentilezza di Dio, e tuttavia non siamo ancora abbastanza cristiani da accettarle.
Sappiamo che il Padre non darà pietre a chi chiede pane (Mt 7,9), ma non pensiamo a noi stessi come a bambini che non sanno quali sono i loro veri bisogni e ciò che è bene e male per le loro vite. Tuttavia sta qui la risposta a molte preghiere inesaudite.
Possiamo trovare risposta anche nelle parole di Giovanni Crisostomo: “Non siate angosciati se non ricevete subito quanto avete domandato: Dio vuole farvi un bene maggiore attraverso la vostra perseveranza e la vostra preghiera”.
PREGHIERA DEL PERFETTO SILENZIO
Vi sono delle occasioni nelle quali non abbiamo bisogno di alcuna parola di preghiera, né delle nostre né di quelle di qualunque altra persona; allora preghiamo in perfetto silenzio. Questo silenzio è la preghiera ideale, sempre che, s’intende, sia un silenzio reale e non sia un sognare a occhi aperti.
Abbiamo ben poca esperienza di cosa significhino un silenzio profondo del corpo e dell’anima, quando una completa serenità riempie l’anima, e una pace totale penetra in tutto il corpo; quando scompare ogni tumulto e agitazione e ci troviamo davanti a Dio, completamente disponibili in un atto di adorazione. Ci possono essere delle volte in cui ci sentiamo fisicamente e mentalmente rilassati, stanchi di parlare perché abbiamo già usato tante parole; non vogliamo smuovere le acque e ci sentiamo felici in questo fragile equilibrio; siamo veramente sul confine da cui si può scivolare in un sogno a occhi aperti.
Il silenzio interiore è assenza di qualsiasi genere di movimento di pensieri o di emozioni nell’intimo, ma è un perfetto stato di veglia, di apertura a Dio. Dobbiamo custodire il silenzio quando ci è possibile, senza mai lasciare che questo degeneri in semplice appagamento. Per evitare che questo avvenga i grandi scrittori dell’ortodossia ci ammoniscono di non abbandonare mai le forme usuali dell’orazione, perché anche coloro che hanno raggiunto questo silenzio contemplativo hanno trovato necessario, ogni volta che hanno rischiato di cadere nella fiacchezza spirituale, reintrodurre parole di preghiera fino a giungere nuovamente a rinnovare il silenzio con la preghiera stessa.
COMUNIONE DI SANTI E DI PECCATORI
La chiesa non fa distinzione fra i vivi e i morti. Dio non è il Dio dei morti, ma è il Dio dei viventi. Per lui tutti gli uomini sono in vita, e così è pure per la chiesa.
In questa prospettiva escatologica possiamo vedere la morte come la grande speranza e attendere con gioia il giudizio e la venuta di Cristo. Possiamo dire con lo Spirito della chiesa: “Vieni presto, Signore Gesù” (Ap 22,20). Storia ed eternità sono una cosa sola, nell’éscathon come nell’eucaristia.
La preghiera della chiesa include non solo i membri della chiesa ma per mezzo di loro e grazie a loro il mondo intero. Essa percepisce la globalità del mondo come chiesa potenziale, quella chiesa totale per la quale spera. E nella chiesa, in questa prospettiva escatologica, tutte le cose hanno già raggiunto il compimento e contemporaneamente vanno ancora dispiegandosi nel tempo. Abbiamo un rapporto vivo con tutti i morti e tutti i viventi nella comunione dei santi e dei peccatori.
PREGHIERA PER I MORTI
Se credete che le orazioni per i vivi siano loro di aiuto, perché non pregare per i morti? La vita è una, perché Luca dice: “Egli non è il Dio dei morti ma dei vivi” (Lc 20,38). La morte non è la fine, ma una tappa nel destino dell’uomo, e questo destino non viene pietrificato nell’ora della morte.
L’amore espresso dalle nostre preghiere non è sprecato; se l’amore avesse potere sulla terra e non ne avesse dopo la morte finirebbe tragicamente per contraddire la parola della Scrittura secondo cui l’amore è forte come la morte (Ct 8,6), e l’esperienza della chiesa, secondo cui l’amore è più forte della morte, perché Cristo ha vinto la morte nel suo amore per l’umanità.
PREGHIERA AI MORTI
Non preghiamo solo per certe persone ma anche rivolti a delle persone. Preghiamo Maria e i santi. Non ci rivolgiamo a loro però per allontanare da noi il giudizio severo di Dio grazie alla loro dolcezza. Sappiamo che la loro volontà coincide con quella di Dio e questa armonia ingloba nella carità tutti i vivi e i morti. Se è vero che il nostro Dio non è il Dio dei morti ma dei viventi, non è forse naturale il nostro pregare rivolti a coloro che sono per noi esempi così luminosi?
Ciascuno di noi può trovare fra i santi una figura che lo attrae in modo particolare. Noi non operiamo tuttavia distinzioni radicali fra chi è santo e chi non lo è. Certi santi sono stati messi da parte da Dio come esempio per tutti i cristiani. Questo non significa che altri non lo siano stati. Ed è decisamente giusto che si preghi rivolgendosi ai genitori e agli amici defunti, senza che questo costituisca una bestemmia.
LA VERA UMILTÀ
L’umiltà non consiste nel cercare sempre di umiliarsi e di rinunciare alla dignità che Dio ci assegna e pretende da noi, perché siamo suoi figli e non suoi schiavi. L’umiltà come la cogliamo nei santi non nasce solamente dalla loro consapevolezza di essere dei peccatori, perché perfino un peccatore può portare a Dio un cuore spezzato e contrito, e una parola di perdono è sufficiente a cancellare tutto il male presente e passato.
L’umiltà dei santi viene dalla loro visione della gloria, della maestà, della bellezza di Dio. Non è nemmeno la percezione di un contrasto che dà origine alla loro umiltà, ma la consapevolezza che Dio è così santo, una tale rivelazione di bellezza perfetta, di un amore che colpisce in maniera tale che la sola cosa che essi possono fare al suo cospetto è prostrarsi davanti a lui in adorazione, nella gioia e nello stupore.
Quando Teresa provò la grande esperienza dell’amore straripante che Dio ha per noi, essa cadde in ginocchio, piangendo di gioia e di meraviglia; quando si alzò era una persona nuova, nella quale la presa di coscienza dell’amore di Dio lasciò “una sensazione di impagabile riconoscenza”. Questa è umiltà, non l’umiliazione.
SANTITÀ
È molto importante per la comprensione della santità capire che essa ha due poli: Dio e il mondo. La sorgente, il fulcro e il suo contenuto è Dio; ma il punto di applicazione, il luogo in cui nasce, si sviluppa e viene espressa poi in termini di salvezza cristiana, è il mondo, questo ambiguo mondo che da una parte fu creato da Dio ed è oggetto di un tale amore che il Padre ha dato per la sua salvezza il suo Figlio unigenito, e dall’altra è caduto nella schiavitù del peccato.
Questo polo della santità che riguarda il mondo ha perciò due aspetti: una visione del mondo come è stato pensato e amato da Dio, e al tempo stesso un ascetismo che ci chiede di liberarci dal mondo e di liberare il mondo dalla presa di Satana.
Questo secondo elemento, questa lotta che è la nostra vocazione, è parte integrante della santità. I padri del deserto, gli asceti delle origini, non fuggivano il mondo nel senso in cui a volte gli uomini moderni cercano di sfuggire alla sua morsa per trovare un porto sicuro in cui ripararsi; essi partivano per vincere il nemico in battaglia. Con la grazia di Dio, nella forza dello Spirito, si dedicavano al combattimento.
LA SANTITÀ DI DIO IN NOI
Tutta la santità è santità di Dio in noi: è una santità che è partecipazione e, in un certo modo, più che partecipazione, perché col partecipare a ciò che riceviamo da Dio diventiamo rivelazione di ciò che ci trascende. Luci limitate, riveliamo la luce.
Ma dovremmo ricordare anche che in questa vita nella quale ci sforziamo di raggiungere la santità, la nostra spiritualità andrebbe definita in termini molto oggettivi e puntuali. Quando leggiamo libri di spiritualità o ci dedichiamo allo studio di questa materia, vediamo che essa, esplicitamente o implicitamente, è costantemente definita come un atteggiamento, uno stato dell’anima, una condizione interiore, un tipo d’interiorità, e così via.
In realtà, se cerchiamo la definizione ultima e cerchiamo di scoprire il nucleo intimo della spiritualità, troviamo che essa non consiste negli stati dell’anima a noi familiari, ma nella presenza e nell’azione dello Spirito in noi, attraverso di noi e per mezzo di noi nel mondo. Non vi è altra santità all’infuori di quella di Dio; è come membra del corpo di Cristo che ci è possibile partecipare alla sua santità, in Cristo e nello Spirito.
LA CHIESA COME LUOGO SANTO
Quando costruiamo una chiesa o isoliamo un luogo di culto facciamo qualcosa che va ben al di là del significato immediato di quello che stiamo costruendo. Il mondo intero che Dio ha creato è divenuto luogo nel quale l’uomo ha peccato; il divisore è all’opera, un combattimento procede incessantemente; non c’è luogo sulla terra che non sia stato sporcato dal sangue, dalla sofferenza o dal peccato.
Quando scegliamo una piccola porzione di mondo, invocando il potere stesso di Dio in riti che trasmettono la sua grazia, per benedire tale porzione, quando la purifichiamo dalla presenza dello spirito del male e la separiamo affinché diventi punto di appoggio di Dio sulla terra, riconquistiamo a Dio una piccola fetta di questo mondo sconsacrato.
Possiamo dire che questo è un luogo in cui il regno di Dio si rivela e si manifesta con potenza. Quando veniamo in chiesa dovremmo essere consapevoli del fatto che stiamo entrando in terra santa, in un luogo che appartiene a Dio, e dovremmo comportarci di conseguenza.
CORPO E ANIMA
Il corpo è stato preparato per la sepoltura; esso non è un logoro pezzo di stoffa, come pare piaccia pensare a certi devoti, gettato via affinché l’anima sia libera. Un corpo è molto più di questo per un cristiano; non vi è nulla che accada all’anima a cui anche il corpo non prenda parte. Riceviamo delle impressioni da questo mondo come pure da quello divino, anche attraverso il corpo.
Ogni sacramento è dono di Dio, conferito all’anima per mezzo di azioni fisiche; le acque del battesimo, l’olio del crisma, il pane e il vino della mensa eucaristica sono tutti presi dal mondo materiale. Non possiamo compiere né il bene né il male senza operare in unione col nostro corpo.
Il corpo non esiste solamente per far sì che l’anima nasca, maturi e poi se ne vada, abbandonandolo; il corpo, dal primo all’ultimo giorno, ha cooperato con l’anima in ogni cosa ed è, assieme all’anima, l’uomo totale. Rimane segnato per sempre dall’impronta dell’anima e dalla vita che insieme hanno condiviso. Legato all’anima, il corpo è anche unito, mediante i sacramenti, allo stesso Gesù Cristo. Noi comunichiamo al suo corpo e al suo sangue, e il corpo viene quindi unito a pieno titolo al mondo divino con il quale entra in contatto.
PERDONO
Il giudizio non porterebbe a noi null’altro che terrore se non avessimo la speranza certa del perdono. E il dono stesso del perdono è contenuto implicitamente nell’amore di Dio e in quello degli uomini. Tuttavia non basta che sia garantito il perdono, dobbiamo essere pronti ad accoglierlo, ad accettarlo.
Dobbiamo acconsentire a essere perdonati con un atto di fede coraggiosa e di generosa speranza, dobbiamo dare umilmente il benvenuto al dono ricevuto, come a un miracolo che solo l’amore, amore umano e divino, può operare, restando riconoscenti in ogni tempo per la sua gratuità, il suo potere di restaurare, di guarire, la sua forza rigenerante.
Non dobbiamo mai confondere il perdonare col dimenticare, o immaginare che queste cose procedano insieme. Esse non solo non si accompagnano l’una all’altra, ma si escludono a vicenda. Cancellare il passato ha ben poco a che vedere con un perdono costruttivo, ricco d’immaginazione, pieno di frutti; la sola cosa che deve andarsene, che dev’essere cancellata dal passato, è il veleno; l’amarezza, il risentimento, l’allontanamento; ma non la memoria.
CROCE E INCARNAZIONE
Per comprendere il significato della morte redentrice di Cristo, dobbiamo cogliere il senso dell’incarnazione. Ognuno di noi è nato nel tempo, dal non-essere. Entriamo in una vita precaria e fugace, per crescere nella stabilità della vita senza fine. Chiamati dal nulla dalla Parola di Dio entriamo nel tempo, ma nel tempo possiamo trovare l’eternità, perché l’eternità non è un flusso di tempo che, non ha mai fine. L’eternità non è qualcosa. È Qualcuno. L’eternità è Dio stesso, che è possibile incontrare nel fluire effimero del tempo e attraverso quest’incontro, tramite la comunione che Dio ci offre per grazia e amore nella libertà reciproca, possiamo accedere all’eternità e condividere la vita stessa di Dio, diventare, nelle parole audaci di Pietro: “Partecipi della natura divina” (2Pt 1,4).
La nascita del Figlio di Dio è diversa dalla nostra. Egli non entra nel tempo dal nulla. La sua nascita non è l’inizio di una vita, di una vita destinata a crescere per sempre; è la limitazione di una pienezza che esisteva prima che il mondo avesse inizio. Colui che possedeva la gloria eterna con il Padre, prima di tutti i secoli, entra nel nostro mondo, nel mondo creato, nel quale l’uomo ha portato il peccato, la sofferenza, la morte. La nascita di Cristo è per lui non l’inizio della vita, bensì l’inizio della morte. Egli accetta tutto ciò che appartiene alla nostra condizione e il primo giorno della sua vita sulla terra è il primo giorno della sua ascesa verso la croce.
MORTE E RESURREZIONE
La gioia della resurrezione è qualcosa che anche noi dobbiamo apprendere dall’esperienza, ma possiamo sperimentarla soltanto se prima impariamo la tragedia della croce. Per sorgere nuovamente, dobbiamo morire. Morire al nostro egoismo che ci ostacola, morire alle nostre paure, morire a tutto ciò che rende il mondo così angusto, così freddo, così piccolo, così crudele. Morire perché le nostre anime possano vivere, possano esultare, possano scoprire dove ha origine la vita. Se facciamo questo allora la resurrezione di Cristo sarà scesa anche su di noi.
Ma senza la morte in croce non c’è resurrezione, resurrezione che è gioia, gioia di una vita ritrovata, gioia della vita che nessuno potrà mai più rapirci! La gioia di una vita sovrabbondante, che come un torrente scende dai colli portando con sé il cielo stesso riflesso nello scintillio delle acque.
La resurrezione di Cristo è una realtà storica come fu reale la sua morte in croce, ed è in quanto appartiene alla storia che noi vi crediamo. Non è solo coi nostri cuori, bensì con la totalità della nostra esperienza che conosciamo il Cristo risorto. Possiamo conoscerlo giorno dopo giorno come gli apostoli. Non il Cristo della carne, ma il Cristo che vive per sempre. Il Cristo dello spirito di cui parla Paolo, il Cristo risorto che appartiene al tempo e all’eternità perché morto una sola volta sulla croce, ora vive per sempre.
IN ADORAZIONE DEL MISTERO
Dobbiamo essere pronti a scoprire che l’ultimo passo del nostro rapporto con Dio è un atto di pura adorazione, faccia a faccia con un mistero nel quale non è possibile entrare.
Cresciamo nella conoscenza di Dio gradualmente, di anno in anno, fino alla fine della nostra vita, e continueremo a farlo lungo tutta l’eternità, senza mai giungere al punto di poter dire di sapere ormai tutto quel che è conoscibile in Dio. Questo processo di graduale svelamento di Dio ci porta in ogni momento a essere con alle spalle la nostra esperienza passata e innanzi a noi il mistero di Dio, conoscibile e ancora sconosciuto.
Quel poco che sappiamo di Dio ci rende difficile imparare di più, perché il di più non può essere aggiunto semplicemente al poco, dato che ogni incontro porta un tale mutamento di prospettiva che quel che era noto in precedenza diviene quasi non vero alla luce di quello che si apprenderà più tardi.
"Salita del Monte Carmelo" di San Giovanni della Croce

Prologo
La presente opera, composta da padre fra Giovanni della Croce, carmelitano scalzo, intende aiutare le anime a meglio disporsi spiritualmente, onde attingere più speditamente l’unione con Dio. Sia ai principianti che ai già progrediti nelle vie dello Spirito, essa propone consigli utili e dottrina solida per liberarsi da tutte le cose temporali, ma altresì per non lasciarsi irretire nei beni spirituali e permanere in quella perfetta spoliazione e libertà spirituale, indispensabili per l’unione con Dio.
ARGOMENTO
Tutta la dottrina che esporrò in questa Salita del monte Carmelo è contenuta nelle strofe che seguono. In queste viene indicato il modo per salire fino alla cima del «Monte», raffigurante quel sublime stato di perfezione che qui chiamo unione dell’anima con Dio. Ho voluto raccoglierle qui tutte insieme, sia perché saranno costante punto di riferimento nella mia esposizione, sia perché si possa comprendere e vedere nel suo complesso l’essenziale di quanto commenterò. Nel corso della spiegazione, quando l’argomento sarà utile riportare ogni singola strofa e i versi distinti. Ecco qui la poesia.
STROFE
Ivi l’anima canta la felice sorte che ebbe nel passare attraverso la notte oscura della fede per arrivare, spoglia e purificata, all’unione con l’Amato.
1. In una notte oscura,
con ansie, dal mio amor tutta infiammata,
oh, sorte fortunata!,
uscii, né fui notata,
stando la mia casa al sonno abbandonata.
2. Al buio e più sicura,
per la segreta scala, travestita,
oh, sorte fortunata!,
al buio e ben celata,
stando la mia casa al sonno abbandonata.
3. Nella gioiosa notte,
in segreto, senza esser veduta,
senza veder cosa,
né altra luce o guida avea
fuor quella che in cuor mi ardea.
4. E questa mi guidava,
più sicura del sole a mezzogiorno,
là dove mi aspettava
chi ben io conoscea,
in un luogo ove nessuno si vedea.
5. Notte che mi guidasti,
oh, notte più dell’alba compiacente!
Oh, notte che riunisti
l’Amato con l’amata,
amata nell’Amato trasformata!
6. Sul mio petto fiorito,
che intatto sol per lui tenea serbato,
là si posò addormentato
ed io lo accarezzavo,
e la chioma dei cedri ei ventilava.
7. La brezza d’alte cime,
allor che i suoi capelli discioglievo,
con la sua mano leggera
il collo mio feriva
e tutti i sensi mie in estasi rapiva.
8. Là giacqui, mi dimenticai,
il volto sull’Amato reclinai,
tutto finì e posai,
lasciando ogni pensier
tra i gigli perdersi obliato.
PROLOGO
1. Per poter spiegare e far comprendere questa notte oscura, attraverso cui l’anima deve passare per giungere alla luce divina della perfetta unione con Dio, per quanto possibile in questa vita, occorrerebbero una scienza e un’esperienza superiori alla mia. Difatti sono tante le difficoltà e così dense le tenebre, spirituali e temporali, che ordinariamente le anime fortunate sogliono attraversare per raggiungere questo sublime stato di perfezione, che non bastano né la scienza umana per comprenderle né l’esperienza per descriverle. Solo chi passa per questa prova potrà darne una valutazione, ma non parlarne.
2. Pertanto, per dire qualcosa di questa notte oscura, non mi affiderò né all’esperienza né alla scienza, perché entrambe possono venir meno e trarre in inganno, pur cercando di avvalermene per quanto possibile. Invero, durante l’esposizione di quanto, con l’aiuto di Dio, intendo dire, soprattutto delle cose più importanti e difficili a capirsi, mi avvarrò della sacra Scrittura. Se ci si lascia guidare da questa, non si potrà mai sbagliare, perché lo Spirito Santo parla in essa. Se poi incorrerò in qualche errore, non comprendendo bene ciò che la Scrittura afferma o nega, non intendo affatto discostarmi dalla corretta interpretazione e dalla dottrina della santa madre Chiesa cattolica. In tal caso mi sottometto e mi rimetto completamente non solo al suo magistero, ma altresì al giudizio di persone più competenti in materia.
3. A scrivere quest’opera mi ha spinto non la capacità di realizzare un’impresa così ardua, bensì la fiducia che ripongo nel Signore, sicuro che mi aiuterà a dire qualcosa, dato il bisogno in cui si trovano molte persone. Queste, infatti, dopo aver intrapreso il cammino della virtù, non riescono ad andare avanti perché il Signore, volendole condurre all’unione divina, le immette in questa notte oscura. A volte ciò accade perché non vogliono entrare né lasciarsi condurre in essa; altre volte, perché non se ne rendono conto, o perché mancano di guide adatte e capaci di condurle sino alla vetta. È un peccato vedere molte persone, alle quali Dio concede capacità e favori per andare avanti e che potrebbero raggiungere quel sublime stato se fossero coraggiose, fermarsi invece ai gradini più bassi del rapporto con Dio, perché non vogliono o non sanno o non vengono guidate e educate a distaccarsi da questo stadio iniziale. Se poi nostro Signore le favorisce tanto da farle passare all’unione divina nonostante questi impedimenti, esse vi pervengono molto tardi, con molta fatica e con minor merito, perché non si sono abbandonate a Dio, lasciandosi introdurre senza resistenza alcuna nell’autentico e sicuro cammino dell’unione. È vero che Dio le conduce per mano e che può farlo anche senza il loro consenso, ma esse non si lasciano condurre. Resistendo a chi le conduce, procedono lentamente e acquistano poco merito, perché non cooperano volontariamente, ragion per cui soffrono di più. Alcune persone, infatti, anziché affidarsi a Dio e farsi aiutare da lui, frappongono ostacoli con le loro azioni imprudenti e le loro opposizioni, proprio come i bambini che, quando le mamme vogliono portarli in braccio, pestano i piedi e piangono, ostinandosi a camminare da soli. In questo modo impediscono ad esse di procedere o le costringono a camminare a piccoli passi.
4. Confidando, dunque, nell’aiuto di Dio, proporrò una dottrina e degli orientamenti adatti sia ai principianti che ai proficienti, perché si lascino condurre da Dio quando vorrà farli progredire. Sappiano essi riconoscerne l’azione o almeno si lascino condurre da lui. Alcuni direttori spirituali, infatti, non possedendo dottrina ed esperienza di queste vie, anziché aiutare tali persone, le ostacolano e danneggiano, come i costruttori di Babilonia, i quali, non comprendendo le diverse lingue, offrivano e mettevano in opera, anziché un materiale adatto, uno meno conveniente e così non concludevano nulla (Gn 11,7-9). In simili circostanze, perciò, è duro e penoso per un’anima non comprendere se stessa né trovare chi la capisca. Può, infatti, accadere che Dio la conduca attraverso una sublime via di contemplazione oscura e di aridità, mentre essa crede di essersi smarrita. In tale stato di oscurità, di sofferenza, di angoscia e di tentazioni, può capitarle d’incontrare chi le dica, come gli amici di Giobbe (Gb 2,11-13), che si tratta di malinconia, di sconforto, di temperamento o di qualche segreta colpa e che per questo Dio l’ha abbandonata. Finiscono così per sentenziare che quella persona dev’essere stata molto cattiva se le capitano tali cose.
5. Vi sarà anche chi le dirà di tornare indietro, dal momento che non trova gusto né soddisfazione nelle cose di Dio, come prima. Così si raddoppiano le sofferenze di quella povera anima. Potrà, infatti, accadere che la sua sofferenza maggiore le deriverà dalla conoscenza delle proprie miserie, per mezzo della quale crederà di vedere, più chiaramente della luce del sole, di essere piena di imperfezioni e di peccati. Ma ciò dipende dal fatto che Dio, come dirò più avanti, in quella notte di contemplazione le concede tale luce di conoscenza. Se, invece, trova qualcuno che la conferma in questa sua convinzione, dicendole che è colpa sua, la pena e l’angoscia di quell’anima cresceranno a dismisura fino a superare le sofferenze della morte. Non contenti di questo, quei confessori, pensando che sia tutto frutto di peccati, spingono quelle persone a scavare nella loro vita e a fare molte confessioni generali, tormentandole continuamente. Tali guide forse non comprendono l’inutilità dei loro sforzi, mentre dovrebbero lasciare le persone nello stato di purificazione in cui Dio le vuole, consolandole e incoraggiandole a volere ciò che Dio vuole. Fin allora, infatti, per quanto esse facciano e quelli dicano, non c’è altro rimedio.
6. A Dio piacendo, parlerò più avanti di tutto questo, di come la persone deve comportarsi in simili circostanze. Indicherò, altresì, al confessore l’atteggiamento da assumere nei confronti di quest’anima, offrendogli degli indizi per discernere se si tratta di purificazione dell’anima e, in caso affermativo, se purificazione dei sensi o dello spirito, che è la notte oscura di cui si parla. Dirò, infine, come si può dedurre se in simili frangenti si tratti di malinconia o di altra imperfezione dei sensi o dello spirito. Alcune persone, infatti, oppure i loro confessori, potrebbero pensare che Dio le stia conducendo lungo questa via della notte oscura della purificazione spirituale, e invece, forse, si tratta di qualcuna delle imperfezioni suddette. Vi sono anche delle persone che credono di non avere il dono dell’orazione, mentre l’hanno ben grande, e altre ancora che pensano di averlo in abbondanza, mentre ne hanno poco meno di nulla.
7. È un peccato che vi siano persone che lavorino e si affatichino molto, ma poi tornino indietro riponendo il frutto del loro progresso in ciò che non giova, anzi ostacola; mentre altre, con calma e serenità, progrediscono molto. Altre, poi, si sentono in imbarazzo e confuse per gli stessi doni e grazie che Dio concede loro per progredire. Molte varie cose accadono in questo cammino a coloro che lo percorrono, come gioie, pene, speranze, dolori, che possono derivare sia dallo spirito di perfezione sia da quello di imperfezione. Di tutto questo, con l’aiuto di Dio, cercherò di dire qualcosa, affinché chiunque legga questo scritto possa in qualche modo conoscere la strada che sta percorrendo e quella invece che gli conviene seguire, se vuole arrivare alla vetta del «Monte».
8. Trattandosi della dottrina della notte oscura, attraverso la quale l’anima deve andare a Dio, il lettore non si meravigli di trovarla alquanto… oscura. Credo che questo potrà accadergli all’inizio della lettura. Andando avanti, però, comprenderà meglio anche il principio, perché un punto di dottrina illumina l’altro. Rileggendo, poi, una seconda volta, credo che tutto gli sembrerà più chiaro e la dottrina più sicura. Ma se qualcuno trovasse difficoltà in questa dottrina, l’attribuisca tranquillamente al mio poco sapere e all’imperfezione del mio stile; però l’argomento in sé è indubbiamente buono e molto utile. Ritengo, tuttavia, che solo pochi se ne avvantaggerebbero anche nel caso che si scrivesse di queste cose in maniera più compiuta e perfetta. Qui non illustrerò una spiritualità molto facile a praticarsi e gradita a tutti quelli che preferiscono andare a Dio attraverso esperienze dolci e piacevoli. Esporrò, al contrario, una dottrina sostanziosa e solida, adatta a tutti quelli che vogliono passare attraverso la nudità dello spirito, descritta in quest’opera.
9. Del resto, mio scopo principale non è rivolgermi a tutti, ma solo ad alcune persone della nostra santa religione del primitivo Ordine del Monte Carmelo, sia frati che monache, che mi hanno chiesto di farlo. Dio ha concesso a tutti costoro la grazia di percorrere il sentiero di questo «Monte». Poiché essi si sono già spogliati dei beni di questo mondo, capiranno meglio la dottrina della nudità dello spirito.
CAPITOLO 1
Ove si presenta la prima strofa. Si parla di due differenti notti attraverso cui passano le persone dedite alle cose dello spirito. Esse riguardano la parte inferiore e la parte superiore dell’uomo. Viene commentata la strofa:
In una notte oscura,
con ansie, dal mio amor tutta infiammata,
oh, sorte fortunata!,
uscii, né fui notata,
stando la mia casa al sonno abbandonata.
1. In questa prima strofa l’anima canta la felice e fortunata sorte che ha avuto di potersi liberare dai beni esteriori, dalle passioni e dalle imperfezioni che risiedono nella parte sensitiva dell’uomo a causa del disordine esistente nella ragione. Per comprendere ciò, occorre sapere che l’anima, per arrivare allo stato di perfezione, deve ordinariamente passare prima attraverso due forme principali di notti, che gli autori spirituali chiamano via purgativa o purificazione dell’anima. Qui le chiamo notti perché l’anima, sia nell’una che nell’altra, cammina al buio, come di notte.
2. La prima notte o purificazione riguarda la parte sensitiva della persona, di cui si parla in questa strofa; ne tratto nel libro I di quest’opera. La seconda notte riguarda la parte spirituale, di cui parla la seconda strofa; del ruolo attivo dell’anima parlerò nei libri II e III, mentre del ruolo passivo nel libro quarto.
3. Questa prima notte riguarda i principianti, nel momento in cui Dio comincia a elevarli allo stato di contemplazione, al quale prende parte anche lo spirito, come dirò a suo tempo. La seconda notte o purificazione riguarda i proficienti, nel momento in cui Dio vuole cominciare a elevarli allo stato di unione con lui. Si tratta di una purificazione molto più oscura, tenebrosa e severa della precedente, come dirò in seguito.
Spiegazione della strofa
4. Ecco, in breve, ciò che l’anima intende dire in questa strofa. Condotta da Dio e mossa soltanto dall’amore per lui, di cui era tutta infiammata, essa canta di essere uscita in una notte oscura. Tale notte consiste nella spoliazione e purificazione da tutti gli appetiti dei sensi, per ciò che concerne le realtà concrete del mondo, quelle che recano piacere alla sua carne e sono gradite alla sua volontà. Tutto ciò accade nella purificazione dei sensi. Per questo motivo l’anima afferma di essere uscita, stando la sua casa al sonno abbandonata, mentre la casa, cioè la sua parte sensitiva, era addormentata e assopite erano le sue passioni, tanto da non essere più disturbata da loro. L’anima, infatti, non si libera dalle pene e dalle anguste strettoie delle passioni fino a quando non vengano smorzate e addormentate. Tutto questo è stato per l’anima una sorte fortunata: uscire senza esser notata, cioè senza che alcuna passione della sua carne o di altro genere glielo abbia impedito. Dice ancora che è uscita di notte, mentre Dio la privava di tutti gli appetiti, il che per essa equivale alla notte.
5. È stata per l’anima una sorte fortunata l’essere posta da Dio in questa notte, da cui le è venuto tanto bene e nella quale essa non sarebbe potuta entrare, perché nessuna persona riesce da sola a liberarsi da tutti gli appetiti per giungere a Dio.
6. Questa, in sostanza, la spiegazione della strofa. Ora non mi resta che percorrere i singoli versi per descriverli uno per uno ed esporre l’argomento che mi sono prefisso. Lo stesso metodo verrà seguito nelle altre strofe, come si diceva nel Prologo: verranno prima riportate le strofe insieme alle relative spiegazioni e poi i singoli versi.
CAPITOLO 2
Ove viene spiegata la natura di questa notte oscura che l’anima afferma di aver attraversato prima dell’unione con Dio.
In una notte oscura.
1. Possiamo chiamare notte questo passaggio dell’anima verso l’unione con Dio per tre motivi. Il primo è desunto dal punto di partenza dell’anima, perché essa deve privarsi del godimento di tutte le cose temporali che possedeva, rinunciando ad esse. Tale rinuncia o privazione costituisce una vera e propria notte per tutte le passioni e i sensi dell’uomo. Il secondo è dato dal mezzo che s’impiega o dal cammino attraverso cui l’anima deve passare per giungere all’unione divina, cioè la fede, che è oscura all’intelligenza come la notte. Il terzo deriva dalla meta verso cui si tende, cioè Dio, che è certamente notte oscura per l’anima in questa vita. Queste tre notti devono passare attraverso l’anima o, per meglio dire, l’anima deve attraversare queste notti per attingere l’unione con Dio.
2. Nel libro di Tobia (6,18-22 Volg.) questi tre generi di notti sono stati raffigurati dalle tre notti che, su richiesta dell’angelo, il giovane Tobia dovette attraversare prima di unirsi con la sua sposa. Nella prima gli fu chiesto di bruciare il cuore del pesce nel fuoco, che è il simbolo del cuore affezionato e attaccato alle cose del mondo. Allo stesso modo, se si vuole cominciare ad andare verso Dio, occorre che il cuore sia consumato dall’amore divino e purificato da tutto ciò che è creatura. Mediante tale purificazione si mette in fuga il demonio, che ha potere sull’anima per via dell’attaccamento alle cose corporali e terrene.
3. L’angelo disse a Tobia che nella seconda notte sarebbe stato accolto nella compagnia dei santi patriarchi, che sono i padri della fede. Ciò vuol dire che l’anima passando attraverso la prima notte, cioè privandosi di tutti gli oggetti che stimolano i sensi, entra subito nella seconda notte, ove rimane nella solitudine della fede. Questa notte non cade sotto il dominio dei sensi, né esclude la carità, ma le altre conoscenze dell’intelletto (come dirò più avanti).
4. L’angelo disse a Tobia che la terza notte gli avrebbe ottenuto la benedizione, che significa Dio stesso. Questi, con il favore della seconda notte, rappresentata dalla fede, comincia a comunicarsi all’anima così segretamente e intimamente da generare in essa un’altra notte, perché tale comunicazione è molto più oscura delle altre, come dirò presto. Trascorsa questa terza notte, cioè realizzata la comunicazione di Dio allo spirito, che di solito avviene quando l’anima è immersa in tenebre profonde, segue immediatamente l’unione con lo Sposo, cioè con la Sapienza di Dio. Difatti anche l’angelo aveva detto a Tobia che, trascorsa la terza notte, si sarebbe unito con la sua sposa nel timore del Signore. Ciò vuol dire che, se il timore è perfetto, anche l’amore di Dio è perfetto. A questo punto si verifica la trasformazione dell’anima in Dio attraverso l’amore.
5. In definitiva, le tre fasi della notte formano una sola notte, come le tre parti della notte naturale. La prima, quella dei sensi, corrisponde al calar delle tenebre, quando non si ha più la percezione delle cose circostanti; la seconda, quella della fede, può essere paragonata alla mezzanotte, quando l’oscurità è profonda; la terza, che è Dio, corrisponde all’alba che precede la luce del giorno. Per meglio comprendere questa dottrina, parlerò separatamente di ciascuna di queste notti.
CAPITOLO 3
Ove si parla del primo motivo di questa notte, che consiste nella mortificazione degli appetiti in tutte le cose. Si spiega altresì la ragione per cui si chiama notte.
1. Per notte intendo qui quello stato nel quale gli appetiti vengono privati del gusto in tutte le cose. Come la notte naturale non è che privazione della luce, e con questa la visibilità di tutti gli oggetti, ragion per cui la vista resta al buio e senza immagini, così la mortificazione degli appetiti si può dire notte per l’anima. Infatti, essendo l’anima privata del gusto sensibile, rimane al buio e priva d’ogni cosa. La vista si attiva mediante la luce e si nutre degli oggetti che si possono vedere, ma quando scompare la luce essa non li vede più. Parimenti accade all’anima che, servendosi degli appetiti s’impossessa e si appaga di quelle cose che può godere secondo le sue capacità. Se invece questo gusto è spento, o per meglio dire, mortificato, l’anima cessa di pascersi del piacere di tutte le cose e, per quanto riguarda l’appetito, resta al buio e priva d’ogni cosa.
2. Faccio un esempio per ciascuna potenza. Se l’anima si priva del godimento di tutto ciò che può soddisfare il senso dell’udito, resta al buio e privo d’ogni cosa relativamente a questa potenza. Lo stesso si può dire per la vista, essa rimane al buio e priva d’ogni cosa anche in riferimento a questa potenza. Quando rinuncia al diletto di tutta la soavità dei profumi, che può provare attraverso il senso dell’olfatto, anche per quanto riguarda questa potenza rimane al buio e priva d’ogni cosa. Rinunciando, poi, ad assaporare ogni genere di cibi che possono soddisfare il palato, essa s’immerge nell’oscurità e diventa libera anche relativamente al gusto. Mortificando, infine, tutti i piaceri e le gioie che le possono venire dal tatto, rimane anche in questo caso al buio e priva d’ogni cosa, relativamente a questa potenza. Si può, dunque, affermare che l’anima che ha rinunciato e allontanato da sé il gusto di tutte le cose, mortificando in ciò i suoi appetiti, è come se fosse immersa nella notte, al buio, completamente vuota rispetto a tutte le cose.
3. Questo si spiega perché, come dicono i filosofi, quando Dio unisce l’anima al corpo, essa è come una tabula rasa e liscia sulla quale non è dipinto nulla; e se si escludono le conoscenze che essa va gradualmente acquisendo attraverso i sensi, nulla le viene comunicato naturalmente per altra via. Finché rimane nel corpo, quindi, assomiglia a colui che, chiuso in un carcere oscuro, conosce solo ciò che riesce a vedere attraverso le finestre di tale carcere; se non vedesse nulla da lì, non gli resterebbe altro modo per vedere. Così l’anima non conosce nulla se non ciò che le viene comunicato attraverso i sensi, che sono come le finestre del suo carcere.
4. Posso, perciò, ben affermare che l’anima rimane vuota e al buio se disprezza e rinuncia a ciò che può percepire tramite i sensi, perché, da quanto ho detto, risulta che per sua natura essa può ricevere luce solo dalle suddette fonti. Anche se non può cessare di udire, vedere, odorare, gustare e toccare, tuttavia, se rinuncia e disprezza tutto questo, essa non ci pone attenzione né si lascia ostacolare più di quanto avverrebbe se di fatto non vedesse, non udisse, ecc. Così è colui che chiude gli occhi e resta al buio, similmente al cieco che non ha la capacità di vedere. A ciò allude Davide quando dice: Pauper sum ego, et in laboribus a iuventute mea, cioè: Sono povero e infelice sin dall’infanzia (Sal 87,16). Dice di essere povero, mentre di fatto era ricco, perché non era affatto attaccato alle ricchezze; quindi era come se fosse stato realmente povero. Se, invece, fosse stato povero di fatto, senza esserlo con la volontà, non lo sarebbe stato per davvero, perché la sua anima sarebbe stata ricca e piena di desideri. Per questo motivo chiamo tale povertà interiore notte per l’anima, perché qui non parlo della semplice privazione dei beni temporali, che di per sé non spoglia l’anima se questa continua a desiderarli; ma parlo della rinuncia al piacere e al desiderio di essi, che sola ne rende l’anima libera e vuota, anche quando il possedesse realmente. Non i beni di questo mondo occupano e danneggiano l’anima – infatti non vi penetrano dentro – ma solo l’attaccamento a tali beni e il desiderio che essa ha nei loro confronti.
5. Questo primo aspetto della notte, come dirò più avanti, riguarda la parte sensitiva dell’anima. Esso è uno dei momenti, di cui ho già parlato, attraverso cui l’anima deve passare per giungere all’unione con Dio. Ora parlerò di quanto sia conveniente all’anima uscire dalla sua casa in questa notte oscura dei sensi, per avviarsi all’unione con Dio.
CAPITOLO 4
Ove si spiega quanto sia necessario all’anima attraversare realmente questa notte oscura, che consiste nella mortificazione dei sensi, al fine d’incamminarsi verso l’unione con Dio.
1. Per attingere l’unione con Dio è necessario che l’anima passi attraverso questa notte oscura, cioè attraverso la mortificazione degli appetiti e la rinuncia a tutti i piaceri derivanti dai beni sensibili, per il seguente motivo: tutte le affezioni che nutre per le creature sono tenebre fitte dinanzi a Dio. Fino a quando l’anima ne è avvolta, non potrà essere illuminata e posseduta dalla pura e semplice luce di Dio. Essa deve, dunque, per prima cosa, liberarsene, perché la luce non può stare insieme alle tenebre. San Giovanni, infatti, afferma: Tenebrae eam non comprehenderunt, cioè: Le tenebre non poterono accogliere la luce (Gv 1,5).
2. La ragione di ciò, secondo quanto insegna la filosofia, sta nel fatto che due contrari non possono coesistere in uno stesso soggetto. Ora, le tenebre, cioè l’attaccamento che si ha per le creature, e la luce, che è Dio, sono contrari e tra loro non vi è alcuna somiglianza o rapporto di sorta, come insegna Paolo rivolgendosi ai Corinzi: Quae conventio lucis ad tenebras?, cioè: Quale rapporto vi può essere tra la luce e le tenebre? (2Cor 6,14). Ne segue che la luce della divina unione non può stabilirsi in un’anima, se prima questa non si libera da tutte le sue affezioni.
3. Per provare meglio quanto ho detto, occorre ricordare che l’affezione e l’attaccamento che l’anima nutre per le creature la rendono simile a queste, e quanto più grande è l’affezione tanto più essa è resa uguale e simile, perché l’amore crea somiglianza tra chi ama e l’oggetto amato. Per questo motivo Davide, parlando di quelli che riponevano il loro affetto negli idoli, disse: Similis illis fiant qui faciunt ea, et omnes qui confidunt in eis, cioè: Sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida (Sal 113,8). Chi ama, quindi, la creatura, si pone al livello della creatura e, in qualche modo, anche più in basso, perché l’amore non solo rende uguali, ma assoggetta l’amante all’oggetto amato. Così, quando l’anima ama qualcosa al di fuori di Dio, si rende incapace della pure unione con Dio e della trasformazione in lui. La bassezza delle creature è, infatti, distante dalla grandezza del Creatore molto più che le tenebre dalla luce. Tutte le cose della terra e del cielo, paragonate a Dio, sono un nulla, secondo quanto afferma Geremia: Aspexi terram, et ecce vacua erat et nihil; et caelos, et non erat lux in eis: Guardai la terra, ed ecco solitudine e vuoto; i cieli, e non v’era luce (Ger 4,23). Quando il profeta dice di aver veduto la terra vuota, vuol far capire che tutte le creature della terra e la stessa terra sono un nulla; quando dice di aver guardato i cieli e di averli visti senza luce, vuol dire che tutte le fonti di luce del cielo, paragonate a Dio, sono pura tenebra. Di conseguenza si può affermare che, se tutte le cose create sono un nulla e l’affezione che l’anima nutre per esse è meno di nulla, esse costituiscono un ostacolo e non permettono la nostra trasformazione in Dio. Difatti le tenebre sono nulla e meno di nulla perché sono una privazione della luce. Pertanto, come chi è avvolto dalle tenebre non può accogliere la luce, così non può accogliere Dio l’anima che ripone la sua affezione nelle cose create; finché non se ne sarà distaccata, non potrà possederlo quaggiù per trasformazione pura d’amore, né lassù mediante la visione beatifica. Per maggior chiarezza parlerò di ciò più diffusamente.
4. Tutte le cose create, paragonate all’infinito essere di Dio, sono un nulla. Perciò anche l’anima che ripone in esse il suo affetto, di fronte a Dio è nulla e meno di nulla, perché, come ho detto, l’amore non solo crea uguaglianza e somiglianza, ma colloca colui che ama al di sotto dell’oggetto amato. In nessun modo, quindi, quest’anima potrà unirsi all’essere infinito di Dio, poiché il non essere non può stare assieme all’essere. Offro alcune esemplificazioni per maggior concretezza. Tutta la bellezza delle creature, paragonata a quella infinita di Dio, è infima bruttezza, come afferma Salomone nel libro dei Proverbi: Fallax gratia, et vana est pulchritudo: Fallace è la grazia e vana la bellezza (Pro 31,30). Così, l’anima, che è attaccata alla bellezza di qualsiasi creatura, è estremamente brutta dinanzi a Dio. Pertanto quest’anima che è brutta non potrà trasformarsi nella bellezza divina, dal momento che la bruttezza non può stare assieme alla bellezza. Ogni grazia e gentilezza delle creature, a confronto con quelle di Dio, sono estrema villania e rozzezza. Perciò l’anima che si affezione alle grazie e alle gentilezze delle creature è estremamente grossolana e scortese; non potrà, quindi, essere capace della grazia e delle bellezza infinita di Dio, perché chi è senza grazia è infinitamente distante da Colui che è la stessa grazia. Ogni bontà delle creature di questo mondo, paragonata a quella infinita di Dio, potrebbe essere chiamata malizia. Solo Dio, infatti, è buono (Lc 18,19). L’anima, quindi, che ripone il suo affetti nei beni di questo mondo, è sommamente cattiva di fronte a Dio. Pertanto, come la malizia non può contenere la bontà, così quell’anima non potrà unirsi a Dio somma bontà. Tutta la sapienza del mondo e la scienza degli uomini, paragonate alla sapienza infinita di Dio, sono pura e somma ignoranza, come scrive san Paolo ai Corinzi: Sapientia huius mundi stultitia est apud Deum: La sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio (1Cor 3,19).
5. Perciò ogni persona che si appoggiasse sulla propria scienza e capacità per giungere all’unione con Dio, sarebbe sommamente ignorante di fronte a Dio, dalla cui sapienza resterà molto distante. L’ignoranza, infatti, non sa cosa sia la sapienza, come afferma san Paolo, dal momento che tale sapienza è stoltezza agli occhi di Dio. Difatti coloro che si ritengono sapienti sono molto ignoranti davanti a Dio. Di essi dice così l’Apostolo, scrivendo ai Romani: Dicentes enim se esse sapientes stulti facti sunt, cioè: Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti (Rm 1,22). Soltanto coloro che si fanno piccoli e ignoranti possiedono la sapienza divina. Messo da parte il loro sapere, servono Dio con amore. Tale genere di sapienza insegna lo stesso Paolo quando scrive ai Corinzi: Si quis videtur inter vos sapiens esse in hoc saeculo, stultus fiat ut sit sapiens; sapientia enim huius mundi stultitia est apud Deum, cioè: Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente; perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio (1Cor 3,18-19). L’anima, quindi, per arrivare a possedere la sapienza di Dio, deve passare attraverso il non sapere e non attraverso il sapere.
6. Ogni genere di dominio e di libertà del mondo, paragonati con la libertà e il dominio dello spirito di Dio, sono somma soggezione, angoscia e schiavitù. Perciò l’anima che si attacca agli onori o ad altre cose del genere e che cerca libertà per le sue affezioni, è da Dio considerata e trattata non come figlia, ma come persona infima, prigioniera delle sue passioni. In realtà non ha voluto seguire i dettami del Signore che c’insegna così: chi vuol essere il più grande si faccia il più piccolo e chi vuole essere piccolo sarà fatto grande (cfr. Lc 22,26). L’anima, quindi non potrà pervenire alla vera libertà di spirito, raggiungibile nell’unione divina, perché la schiavitù è assolutamente incompatibile con la libertà; quest’ultima, a sua volta, non può abitare in un cuore libero, come quello del figlio. Per questo motivo Sara chiese a suo marito Abramo di cacciare via la schiava insieme a suo figlio, affermando che questi non poteva essere erede insieme al figlio della donna libera (Gn 21,10).
7. Tutti i piaceri e le dolcezze che la volontà prova nei beni creati, paragonati con quelli di Dio, sono soltanto pena, tormento e amarezza. Chi, dunque, ripone in essi il proprio affetto, è ritenuto degno di massima pena, di tormento e di amarezza dinanzi a Dio. In questo modo, egli non potrà pervenire alle gioie dell’unione con Dio. Tutte le ricchezze e la gloria del creato, messe a confronto con la ricchezza che è Dio, sono povertà e miseria estrema. L’anima che le ama e le possiede è estremamente povera e miserabile di fronte a Dio. Per questo motivo non potrà pervenire al vero stato di ricchezza e di gloria, che consiste nella trasformazione in Dio, perché la sua miseria e la sua povertà distano infinitamente da Colui che è sommamente ricco e glorioso.
8. La Sapienza divina, dolendosi, perciò, di queste persone che si abbrutiscono, si fanno spregevoli, miserabili e poveri per amore di ciò che nel mondo ritengono bello e ricco, nel libro dei Proverbi li apostrofa dicendo: O viri, ad vos clamito, et vox mea ad filios hominum. Intelligite parvuli astutiam, et insipientes animadvertite. Audite, quia de rebus magnis locutura sum. E più avanti aggiunge: Mecum sunt divitiae et gloria, opes superbae et iustitia. Melior est fructus meus auro et lapide pretioso, et genimina mea argento electo. In viis iustitiae ambulo, in medio semitarum iudicii, ut ditem diligentes me, et thesauros eorum repleam. Il che vuol dire: A voi, uomini, io mi rivolgo, ai figli dell’uomo è diretta la mia voce. Imparate, inesperti, la prudenza, e voi, stolti, fatevi assennati. Ascoltate, perché dirò cose elevate… Presso di me c’è ricchezza e onore, sicuro benessere ed equità. Il mio frutto vale più dell’oro, dell’oro fino, il provento (e le mie generazioni, ossia ciò che voi generate per mezzo mio nelle vostre anime) più dell’argento scelto. Io cammino sulla via della giustizia e per i sentieri dell’equità, per dotare di beni quanti mi amano e riempire i loro forzieri (Pro 8,4-6.18-21). Con tali parole la Sapienza divina si rivolge a tutti quelli che ripongono il loro cuore e l’affetto in qualunque bene creato, come ho già detto. Li chiama piccoli, inesperti, perché si rendono simili a ciò che amano, che è poca cosa. Per questo li avverte di essere prudenti e di prendere in considerazione le grandi cose di cui essa parla, e non le cose piccole come sono loro. Continua col dire che le grandi ricchezze e la gloria che essi amano si trovano non dove essi pensano, ma con e nella sapienza, ove abitano, altresì, le vere ricchezze e la giustizia. E se i tesori di questo mondo a loro sembrano superiori a qualunque altro bene, essa li invita a considerare che sono migliori i suoi tesori, perché il frutto che troveranno in questi ultimi sarà migliore dell’oro e delle pietre preziose. Aggiunge, infine, che quanto essa genera nelle anime è di gran lunga superiore all’argento puro che essi amano, cose che rappresentano ogni genere di affetto che si può nutrire in questa vita.
CAPITOLO 5
Ove si continua a parlare dello stesso argomento, dimostrando con prove e immagini della sacra Scrittura quanto sia necessario all’anima andare a Dio attraverso questa notte oscura della mortificazione delle passioni.
1. Da quanto è stato detto, si può avere un’idea della distanza esistente tra i beni creati in sé e ciò che Dio è in sé. Parimenti si può comprendere quanto le anime che si attaccano a qualcuno di tali beni siano anch’esse lontane da Dio, poiché l’amore, ripeto, crea uguaglianza e somiglianza. Al fine di evidenziare tale distanza, sant’Agostino rivolgendosi a Dio, afferma nei Soliloqui: Me misero! Quando la mia pochezza e la mia imperfezione potranno incontrarsi con la tua rettitudine? Tu sei veramente buono e io cattivo; tu pio, io empio; tu santo, io miserabile; tu giusto, io ingiusto; tu luce, io cieco; tu vita, io morte; tu medicina, io malato; tu verità somma, io tutto vanità. Ecco quanto affermava quel santo.
2. È, dunque, estrema ignoranza da parte dell’anima credersi capace di giungere a questo sublime stato di unione con Dio, senza essersi prima distaccata dalla cupidigia dei beni naturali e soprannaturali che le possono essere di ostacolo, come dirò più avanti; vi è, infatti, una distanza infinita fra questi beni e ciò che viene concesso in questo stato di pura trasformazione in Dio. Ecco perché nostro Signore c’insegna questa via di rinuncia, quando dice per mezzo di san Luca: Qui non renuntiat omnibus quae possidet, non potest meus esse discipulus, cioè: Chi non rinunzia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo (Lc 14,33). Verità chiara, questa, perché la dottrina che il Figlio di Dio è venuto a insegnare è il disprezzo di tutti i beni creati, per poter accogliere in sé il puro spirito di Dio. In realtà, finché l’anima non se ne libererà, non potrà accogliere questo spirito di Dio e raggiungere la pura trasformazione in lui.
3. Di tale verità abbiamo un’immagine nel libro dell’Esodo (16,3-4), dove si legge che Dio non diede ai figli d’Israele il cibo celeste, cioè la manna, finché non venne a mancare loro la farina che avevano portato dall’Egitto. Questo ci fa capire che l’anima deve prima rinunciare a tutti i beni creati se vuole attingere l’unione divina, perché questo cibo degli angeli non è adatto al palato di chi vuol gustare quello degli uomini. Perciò l’anima che cerca altri gusti estranei e se ne pasce, non soltanto non è in grado di assaporare lo spirito di Dio, ma rattrista molto la Maestà divina, poiché pretende l’alimento spirituale senza accontentarsi di Dio solo, ma vuole, al tempo stesso, mescolarvi la cupidigia e l’affezione per altre cose. Ciò è quanto c’insegna lo stesso libro della sacra Scrittura, ove si dice che gli ebrei, non contenti di quel cibo così semplice, desiderarono e chiesero la carne (Es 16,8-13). Dio si adirò moltissimo perché essi volevano gustare allo stesso tempo un cibo così volgare e rozzo e uno così nobile e semplice, che tuttavia aveva in sé il sapore e la sostanza di tutti i cibi (cfr. Sap 16,20-21). Perciò, mentre ancora avevano il boccone tra i denti, come dice Davide, ira Dei descendit super eos (Sal 77,30-31): su loro scese l’ira di Dio, scagliando fuoco dal cielo e incenerendone molte migliaia. Dio, infatti, riteneva indegni di ricevere il pane del cielo coloro che avevano voglia di un altro cibo.
4. Oh, se le persone spirituali sapessero di quanti beni e di quale abbondanza di favori spirituali li priva la cecità causata dal loro attaccamento a cose di nessun valore e come troverebbero in questo cibo semplice dello spirito il sapere di tutti i beni, se si astenessero dal gustarli! Ma essi non lo provano per lo stesso motivo per cui gli ebrei non sentivano il gusto di tutti i cibi contenuto nella manna; ciò avveniva perché essi non desideravano soltanto quella. In tal modo non vi sperimentavano tutto il gusto e la forza che avrebbero potuto trovarvi, non perché la manna non li avesse, ma perché essi cercavano qualcos’altro. Così pure, chi vuole amare qualcos’altro insieme a Dio, è come se stimasse poco Dio, mettendo sulla stessa bilancia Dio e ciò che è infinitamente distante da lui.
5. Del resto si sa per esperienza che quando la volontà si affeziona a una cosa, la stima più di ogni altra; e anche se quest’«altra» è migliore, non le piace quanto la prima. Se, poi, vuole godere dell’una e dell’altra, necessariamente recherà oltraggio alla più degna, perché mette ingiustamente entrambe sullo stesso piano. Ora, non essendoci alcuna cosa che possa essere uguagliata a Dio, l’anima che, insieme a lui, ama o si attacca a qualche creatura, gli reca grave offesa. Se dunque è così, cosa accadrebbe se l’anima amasse qualcosa più di Dio?
6. A tale verità alludeva Dio quando comandò a Mosè di salire sul monte, ove gli doveva parlare. Non soltanto gli ordinò di salirvi da solo, lasciando nella valle i figli d’Israele, ma gli vietò altresì di far pascolare le bestie davanti a questo monte: Nullus ascendat tecum, nec videat quispiam per totum montem, boves quoque et oves non pascano e contra (Es 34,3). Per mezzo di tale ordine Dio voleva significare che l’anima che deve salire il «Monte della perfezione» per comunicare con lui, non solo deve rinunciare e lasciare in basso tutte le cose create, ma non deve nemmeno permettere che gli appetiti, rappresentati dalle bestie, pascolino davanti a questo «Monte», nel godimento di cose che non sono Dio. È in lui che tutti i desideri sono appagati, quando si raggiunge lo stato di perfezione. È, dunque, necessario che il cammino ascensionale verso Dio si traduca in una continua cura per far cessare l’attività degli appetiti e mortificarli. Così, l’anima tanto più speditamente giungerà alla meta, quanto più si sarà affrettata a praticare questo distacco. Fino a quando l’anima non l’avrà conseguito, non raggiungerà la meta, sebbene pratichi molte altre virtù; e queste le può acquistare in modo perfetto solo se è vuota, nuda e purificata da ogni appetito. Anche di questa verità abbiamo un’immagine molto viva nel libro della Genesi. Ivi si legge che il patriarca Giacobbe volle salire sul monte Betel per edificare un altare a Dio e offrirgli un sacrificio. Per prima cosa impose alla sua gente tre condizioni: la prima, che gettassero via tutti gli dei stranieri; la seconda, che si purificassero; la terza, che cambiassero gli abiti: Abiicite deos alienos qui in medio vestri sunt, et mundamini ac mutate vestimenta (Gn 35,1-2).
7. Queste tre condizioni ci permettono di comprendere ciò che ogni anima, che vuole salire questo «Monte», deve compiere per fare di sé un altare sul quale offrire a Dio un sacrificio di amore puro, di lode e di profonda adorazione. Prima di salire sulla cima di tale «Monte», essa deve adempiere perfettamente le condizioni analoghe a quelle riferite sopra. La prima consiste nel respingere tutti gli dei stranieri, cioè tutti gli affetti e gli attaccamenti estranei a Dio. La seconda consiste nel purificarsi, per mezzo della notte oscura dei sensi di cui sto parlando, dalle scorie lasciate in essa dagli appetiti suddetti, mortificandoli e pentendosene abitualmente. La terza condizione, infine, necessaria per giungere a questo «Monte» sublime, consiste nel cambiare gli abiti. Una volta adempiute le prime due condizioni, sarà Dio stesso a sostituirli con abiti nuovi. Egli, infatti, infonderà nell’anima un nuovo modo di conoscere e di amare Dio com’è in se stesso, facendole accantonare il modo di conoscere dell’uomo vecchio, dopo aver liberato la volontà da tutti gli antichi affetti e seduzioni umane. Egli, inoltre, stabilirà l’anima in nuove conoscenze, perché ormai sono state bandite le altre conoscenze e i ricordi del passato. Metterà fine a tutto ciò che appartiene all’uomo vecchio, cioè le sue capacità naturali, e la rivestirà, secondo le sue potenze, di nuove attitudini soprannaturali. Così il modo di operare dell’anima non sarà più umano, ma divino. Ecco ciò che si raggiunge nello stato di unione. Ivi l’anima serve solo da altare, dove Dio viene adorato in pura lode e amore e dove egli abita solo. Per questo motivo Dio aveva ingiunto che l’altare sul quale dovevano essergli offerti i sacrifici fosse vuoto all’interno (cfr. Es 27,8). Egli voleva far capire all’anima che la vuole libera da tutte le cose create, per essere degno altare di sua Maestà. Egli non permetteva mai che su quell’altare bruciasse un fuoco illegittimo né che vi mancasse quello sacro (cfr. Lv 6,12-13). Perciò, quando Nadab e Abiu, figli del sommo sacerdote Aronne, offrirono un fuoco illegittimo, il Signore, irritato, li colpì a morte proprio lì, davanti all’altare (cfr. Lv 10,1-2). Da tutto ciò possiamo comprendere che l’anima, per essere un altare degno di Dio, non deve trovarsi priva dell’amore di Dio, né tanto meno deve permettere che a questo si mescoli un amore profano.
8. Dio non tollera che qualche altra cosa abiti con lui nello stesso luogo. Ecco come si spiega ciò che si legge nel primo libro di Samuele. I filistei avevano collocato l’arca dell’alleanza nel tempio dov’era il loro idolo; ora, ogni mattina quest’idolo si trovava rovesciato a terra e alla fine venne trovato in frantumi (cfr. 1Sam 5,2-5). L’unico desiderio che Dio ammette e vuole, laddove egli dimora, è quello di osservare la sua legge in ogni particolare e di prendere su di sé la croce di Cristo. Per questo motivo nella sacra Scrittura si legge che Dio ordinava di mettere nell’arca, dove si conservava la manna, solo il libro della Legge e il bastone di Mosè (cfr. Dt 31,26), immagine della croce. Difatti l’anima che non desidera altro che osservare perfettamente la legge del Signore e portare la croce di Cristo, sarà l’arca vera, quella che racchiude in sé la vera manna, cioè Dio, quando avrà impressi in sé perfettamente questa legge e questo legno, senza affezione per nessun’altra cosa.
CAPITOLO 6
Ove si parla dei due principali danni, uno privativo e l’altro positivo, causati all’anima dagli appetiti.
1. A questo punto sembra utile fornire un’esposizione più chiara e dettagliata di quanto detto prima. Ho mostrato come i nostri appetiti provochino nell’anima due danni principali. Il primo lo priva dello spirito di Dio; l’altro la stanca, la tormenta, la oscura, la sporca, l’indebolisce e la ferisce, proprio come afferma Geremia: Duo mala fecit populus meus: dereliquerunt fontem aquae vivae, et foderunt sibi cisternas dissipatas, quae continere non valent aquas, cioè: Il mio popolo ha commesso due iniquità: essi hanno abbandonato me, sorgente di acqua viva, per scavarsi cisterne, cisterne screpolate che non tengono l’acqua (Ger 2,13). Questi due mali, privativo e positivo, sono provocati da qualsiasi atto disordinato dell’appetito. Parlando, in primo luogo, di quello privativo, è chiaro che, per lo stesso motivo per cui l’anima si affeziona a qualsiasi bene creato, quanto più quell’appetito è radicato in essa, tanto meno è capace di unirsi a Dio. Infatti, come dicono i filosofi e come ho già riferito nel capitolo 4, due contrari non possono coesistere in uno stesso soggetto. Ora, l’amore per Dio e quello per le creature sono contrari; quindi non possono coesistere in una stessa volontà l’affetto per le cose create e quello per Dio. Cosa ha a che vedere, infatti, la creatura con il Creatore, il sensibile con lo spirituale, il visibile con l’invisibile, il temporale con l’eterno, il cibo celestiale, puro e spirituale, con il nutrimento grossolano dei sensi, lo spogliamento del Cristo con l’attaccamento alle cose?
2. Pertanto, come nell’ordine naturale delle cose non si può introdurre una forma senza aver prima espulso dal soggetto la forma contraria, preesistente, la cui presenza è d’impedimento all’altra, perché ad essa opposta, così l’anima, finché è soggetta alle attrattive del senso, non può accogliere il puro spirito di Dio. Per questo il Salvatore ha detto per bocca di san Matteo: Non est bonum sumere panem filiorum et mittere canibus, cioè: Non è bene prendere il pane dei figli per darlo ai cani (Mt 7,6). Con queste affermazioni il Signore paragona ai figli di Dio coloro che, negando l’attaccamento alle cose create, si dispongono ad accogliere in purezza lo spirito di Dio; ai cani, invece, paragona quelli che vogliono trovare nutrimento nelle cose create attraverso i loro appetiti. Ai figli, infatti, è concesso mangiare alla mensa e allo stesso piatto del Padre, cioè nutrirsi del suo spirito; mentre ai cani sono lasciate le briciole che cadono dalla tavola.
3. A tale riguardo occorre notare che tutte le cose create sono briciole che cadono dalla mensa di Dio. A buon diritto, dunque, sono chiamati cani coloro che si pascono delle cose create; per questo viene tolto loro il pane dei figli, perché non vogliono elevarsi al di sopra di esse, vere briciole, fino alla mensa dello spirito increato del Padre. Proprio per questo vagano sempre affamati come cani, perché le briciole servono più a stimolare gli appetiti che a sedare la fame. Di costoro Davide afferma: Famem patientur ut canes, et circuibunt civitatem. Si vero non fuerint saturati, et murmurabunt: Ringhiano come cani, per la città si aggirano, vagando in cerca di cibo; latrano, se non possono saziarsi (Sal 58,15-16). Questa, infatti, è la caratteristica di chi è dominato dagli appetiti: è sempre scontento e inquieto, come un famelico. Ora, che relazione c’è tra la fame causata da tutte le cose create e la sazietà prodotta dallo spirito di Dio? Ma questa sazietà increata non può entrare nell’anima se prima non viene cacciata via l’altra; come ho detto, infatti, non possono coesistere due contrari nello stesso soggetto, in questo caso la fame e la sazietà.
4. Da quanto detto si può notare come Dio fa più, per così dire, per purificare e liberare un’anima da queste opposizioni che per crearla dal nulla. Queste sregolatezze degli affetti e degli appetiti contrari contrastano e resistono a Dio più che il nulla, che non oppone resistenza. Avendone già parlato a lungo più sopra, basti questo circa il primo danno principale prodotto nell’anima dagli appetiti, che consiste nel resistere allo spirito di Dio.
5. Ora parlerò del secondo danno che tali appetiti causano nell’anima. Esso si manifesta sotto svariate forme, perché gli appetiti stancano l’anima, la tormentano, la oscurano, la sporcano e la indeboliscono. Parlerò dettagliatamente di questi cinque effetti.
6. Quanto alla prima forma, è chiaro che gli appetiti stancano e affaticano l’anima. Assomigliano a bambini inquieti e scontenti, che chiedono sempre qualcosa alla mamma e non si contentano mai. Peraltro, come si stanca colui che scava, spinto dalla cupidigia di un tesoro, così si stanca e si affatica l’anima per conseguire ciò che le chiedono gli appetiti. E anche se ottiene quel che vuole, alla fine si stanca sempre, perché non è mai soddisfatta. In fondo, quelle che scava, sono cisterne screpolate che non tengono l’acqua per spegnere la sete (Ger 2,13). A tale riguardo così si esprime Isaia: Lassus adhuc sitit, et anima eius vacua est: Langue ancora per sete e si sente vuoto (Is 29,8), che significa: il suo appetito è insoddisfatto, perciò l’anima che ha appetiti si stanca e si affatica. È come il malato con la febbre: non sta bene finché questa non sparisce, ad ogni istante gli cresce la sete. Si legge, infatti, nel libro di Giobbe: Cum satiatus fuerit, arctabitur, aestuabit, et omnis dolor irruet super eum, che vuol dire: Quando l’anima avrà appagato i suoi appetiti, nel colmo della sua abbondanza si ritroverà più oppressa e appesantita, dentro di essa crescerà l’arsura dell’appetito e così ogni sorta di sciagura le piomberà addosso (Gb 20,22). L’anima si stanca e si affatica a causa dei suoi appetiti, perché è ferita, mossa e turbata da essi, come i flutti sotto l’azione dei venti. Al pari di quelli, l’anima è turbata senza trovare da nessuna parte o in qualche cosa un momento di riposo. Di tali anime così afferma Isaia: Cor impii quasi mare fervens: Il cuore del malvagio è come il mare che agitato ribolle (Is 57,20); e cattivo è chi non vince gli appetiti. L’anima che vuole appagare i suoi appetiti si stanca e si affatica. Somiglia a colui che, avendo fame, apre la bocca per saziarsi di vento, ma invece di saziarsi rimane con più voglia, perché il vento non è il suo cibo. A questo proposito dice Geremia: In desiderio animae suae attraxit ventum amoris sui, cioè: Nell’ardore del suo desiderio aspira l’aria (Ger 2,24). E subito dopo, per spiegare l’arsura in cui si trova quell’anima, le offre questo consiglio: Prohibe pedem tuum a nuditate, et guttur tuum a siti, che significa: Bada che il tuo piede, cioè il tuo pensiero, non resti scalzo e la tua gola non si inaridisca (Ger 2,25), ossia preserva la tua volontà dal soddisfare gli appetiti, che generano una più profonda aridità. Come si sente esausto e crolla l’innamorato che vede andare in fumo i suoi progetti proprio nel giorno in cui sperava di realizzarli, così si stanca e si affatica l’anima che cede ai suoi appetiti e li soddisfa, perché le procurano un vuoto maggiore e una fame più acuta. Come si dice comunemente, l’appetito è come il fuoco: cresce se gli si aggiunge legna, ma è destinato a spegnersi appena l’ha consumata.
7. Ora, la condizione degli appetiti è ancora peggiore. Il fuoco, infatti, si spegne quando si esaurisce la legna, mentre gli appetiti non perdono l’intensità raggiunta quando sono stati soddisfatti, sebbene sia venuto meno il loro oggetto; invece di diminuire, come il fuoco quando si è consumata la legna, restano sfiniti dalla fatica perché la cupidigia è cresciuta e diminuito il cibo. A tale proposito afferma Isaia: Declinabit ad dexteram, et esuriet; et comedet ad sinistram, et non saturabitur: Dilania a destra, ma è ancora affamato; mangia a sinistra, ma senza saziarsi (Is 9,19). Coloro, infatti, che non mortificano i loro appetiti, proprio quando si voltano vedono la sazietà, non a loro concessa, dello spirito di soavità di coloro che sono alla destra di Dio; quando, poi, corrono a sinistra, cioè si lasciano andare al piacere di qualche cosa creata, non si saziano affatto, perché mettono da parte l’unica cosa che può saziare e si nutrono di ciò che accresce la loro fame. È chiaro, dunque, che gli appetiti stancano e affaticano l’anima.
CAPITOLO 7
Ove si mostra come l’anima sia tormentata dagli appetiti. Lo si prova anche con paragoni e l’autorità della sacra Scrittura.
1. Vi è una seconda forma di male positivo che gli appetiti provocano nell’anima. Questi la tormentano e l’affliggono, come tormentato è il condannato al supplizio della corda, legato a qualche sostegno, che non trova riposo finché non viene liberato. A tale riguardo afferma Davide: Funes peccatorum circumplexi sunt me: Le funi dei peccati, che sono i miei appetiti, mi hanno stretto da ogni parte (Sal 118,61). Come è tormentato e afflitto chi si distende nudo su spine e aculei, così è tormentata e afflitta l’anima quando si lascia andare ai suoi appetiti. Questi, infatti, come spine, la feriscono, la pungono, si attaccano ad essa e la torturano. Di essi Davide dice ancora: Circumdederunt me sicut apes, et exarserunt sicut ignis in spinis: Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine (Sal 117,12). Negli appetiti, infatti, che sono le spine, divampa il fuoco dell’angoscia e del tormento. Come l’agricoltore, spinto dalla cupidigia della messe, pungola e tormenta il bue aggiogato all’aratro, così la concupiscenza affligge l’anima sotto il pungolo dell’appetito per ottenere ciò che vuole. Di ciò abbiamo un esempio molto evidente in quel desiderio che aveva Dalila di sapere in che cosa consistesse la forza di Sansone. La sacra Scrittura dice che lo stancava e lo tormentava tanto da indebolirlo fin quasi alla morte: Defecit anima eius, et ad mortem usque lassata est (Gdc 16,16).
2. Quanto più forte è l’appetito, tanto più grande è il tormento per l’anima, cosicché l’uno è proporzionato all’altro; più numerosi sono gli appetiti, più numerosi sono i suoi tormenti. Nell’anima, infatti, si realizza, già in questa vita, ciò che l’Apocalisse dice di Babilonia: Quantum glorificavit se, et in deliciis fuit, tantum date illi tormentum et luctum, cioè: Tutto ciò che ha speso per la sua gloria e il suo lusso, restituiteglielo in tanto tormento e afflizione (Ap 18,7). È proprio vero che come è tormentato e afflitto chi cade nelle mani del suo nemico, così è tormentata e afflitta l’anima che si lascia trasportare dai suoi appetiti. Di tale realtà abbiamo un’immagine nel libro dei Giudici (16,21). Ivi si legge che il robusto Sansone, prima forte, libero e giudice di Israele, una volta caduto nelle mani dei suoi nemici perse la forza, fu accecato e costretto a girare una macina. Così lo tormentarono e lo fecero soffrire molto. Tale è la sorte dell’anima quando questi nemici, gli appetiti, sono vivi e vittoriosi su di essa; incominciano prima a indebolirla e ad accecarla; poi, come dirò più avanti, l’affliggono e la tormentano, legandola alla macina della concupiscenza; i legami che la tengono avvinta sono i suoi stessi appetiti.
3. Ora, Dio ha pietà delle anime che con tanta fatica e a loro spese cercano di placare la sete e la fame dei loro appetiti nelle cose create. Ad esse dice per bocca di Isaia: Omnes sitientes, venite ad aquas; et qui non habetis argentum, properate, emite et comedite: venite, emite absque argento vinum et lac. Quare appenditis argentum non in panibus, et laborem vestrum non in saturitate? (Is 55,1-2), come a dire: O voi tutti assetati di appetiti, venite all’acqua; chi non ha il denaro della propria volontà e dei propri appetiti, venga ugualmente, comprate da me e mangiate: comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte, cioè la pace e le dolcezze spirituali, senza il denaro della propria volontà e senza darmi in cambio interesse né alcun lavoro, come fate per i vostri appetiti. Perché offrite il denaro della vostra volontà per ciò che non è pane, che non appartiene cioè allo spirito divino? Perché mettete il lavoro dei vostri appetiti in ciò che non può saziare? Venite, ascoltatemi e mangerete il bene che desiderate, e l’anima vostra si rallegrerà nell’abbondanza.
4. Quest’abbondanza significa la liberazione da tutti i piaceri per le cose create, perché queste tormentano l’anima, mentre lo spirito di Dio la vivifica. Quest’invito ci rivolge il Signore in san Matteo: Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos, et invenietis requiem animabus vestris (11,28-29), come a dire: Voi tutti che siete tormentati, afflitti e oppressi dal peso delle vostre preoccupazioni e dei vostri appetiti, liberatevene, venite a me, e io vi ristorerò, e troverete per le vostre anime il riposo che i vostri appetiti vi tolgono. Questi sono certamente un carico pesante, come dice Davide: Sicut onus grave gravatae sunt super me: Come un grave peso mi opprimono (Sal 37,5).
CAPITOLO 8
Ove si mostra come gli appetiti oscurano e accecano l’anima.
1. Vi è una terza forma di danno causato dagli appetiti all’anima: l’accecano e annebbiano la ragione. Come i vapori oscurano l’aria e non lasciano filtrare il sole che splende; come lo specchio appannato non può riprodurre limpidamente il volto; o come l’acqua fangosa non lascia vedere la faccia che in essa si specchia, così l’anima prigioniera degli appetiti ha l’intelletto annebbiato: non lascia che il sole della ragione naturale né quello soprannaturale della Sapienza di Dio la investano e la illuminino completamente. Così dice Davide a tale proposito: Comprehenderunt me iniquitates meae, et non potui, ut viderem: Le mie colpe mi opprimono e non posso più vedere (Sal 39,13).
2. Nello stesso tempo in cui si offusca l’intelletto, s’intorpidisce anche la sensibilità e la memoria diventa rozza, in una parola s’introduce il disordine nel modo naturale di operare dell’anima. Poiché queste potenze, nelle loro operazioni, dipendono dall’intelletto, quando questo è impedito, esse risultano necessariamente disordinate e sconvolte. Davide, infatti, così si esprime: Anima mea turbata est valde: L’anima mia è tutta sconvolta (Sal 6,4), ossia le sue potenze sono nel disordine. Difatti, come ho detto, l’intelletto non ha la capacità di accogliere l’illuminazione della sapienza di Dio, come l’aria cupa non può ricevere la luce del sole. Anche la volontà non è in grado di amare Dio con puro amore, come lo specchio appannato dall’alito non può riflettere nitido il volto cha ha di fronte; meno ancora la memoria offuscata dalle tenebre degli appetiti è in grado di riflettere in sé, con chiarezza, l’immagine di Dio, come l’acqua torbida non può mostrare nitidamente il volto di colui che vi si specchia.
3. Gli appetiti, inoltre, accecano e ottenebrano l’anima perché, in quanto tali, sono ciechi; per parte loro, infatti, non comprendono nulla: devono essere guidati sempre dalla ragione. Così, ogni volta che l’anima si lascia guidare dai suoi appetiti, diventa cieca; assomiglia a colui che vede e si fa guidare da un non vedente, il che equivale a essere entrambi ciechi. Di conseguenza risulta vero quanto il Signore dice nel vangelo di Matteo: Si caecus caeco ducatum praestet, ambo in foveam cadunt: Quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadono in un fosso (Mt 15,14). Giovano poco gli occhi alla farfalletta che, abbagliata dal desiderio della bellezza della luce, si lascia attrarre dalla fiamma. Possiamo ancora aggiungere che chi si nutre degli appetiti è come il pesce abbagliato, al quale la luce funge piuttosto da tenebra che non gli permette di vedere le insidie tesegli dai pescatori. Fa capire molto bene tutto questo Davide rivolgendosi così a un tal genere di persone: Supercecidit ignis, et non viderunt solem (Sal 57,9 Volg.), cioè cadde su di loro il fuoco che riscalda con il suo calore e abbaglia con la sua luce. Tutto questo causano gli appetiti nell’anima, accendendo la concupiscenza e abbagliando l’intelletto in modo da non fargli vedere la luce. L’abbagliamento, infatti, è dovuto al fatto che quando si presenta agli occhi una luce diversa, la vista viene così catturata da questa tanto da non vedere più l’altra. Così è dei nostri appetiti: si accostano talmente all’anima da insediarvisi; essa incappa in questa prima luce e se ne nutre in modo da non vedere chiaramente quella della sua ragione, né la vedrà finché non si sottrarrà all’accecamento degli appetiti.
4. Per questo motivo non si può non deplorare profondamente l’ignoranza di alcune persone che si danno a molte penitenze straordinarie e a molti altri esercizi volontari, convinte che basti questo per arrivare all’unione con la Sapienza divina, mentre poi non si preoccupano affatto di mortificare accuratamente i loro appetiti. Se invece procurassero di impiegare la metà di quegli sforzi in questo lavoro, farebbero più progressi in un mese che non con tutti gli altri esercizi in molti anni. Come, infatti, è necessario lavorare la terra perché porti frutti, altrimenti produrrebbe solo erbacce, così è necessaria la mortificazione degli appetiti perché l’anima progredisca. Altrimenti oso dire che, per progredire nella perfezione e nella conoscenza di Dio e di se stessa, non le giova mai quanto farà, come non produce il seme sparso sulla terra incolta. Di conseguenza l’anima resterà nelle tenebre e nella rozzezza fin quando non avrà smorzato gli appetiti. Questi sono per l’anima come la cateratta o la pagliuzza negli occhi: impediscono di vedere finché non vengono tolte.
5. Davide, per mostrare la cecità degli appetiti, quanto essi impediscano all’anima di vedere la luce della verità e quanto irritino Dio, si esprime in questi termini: Priusquam intelligerent spinae vestrae rhamnum: sicut viventes, sic in ira absorbet eos (Sal 57,10 Volg.), come a dire: Prima che le vostre spine, cioè i vostri appetiti, si sentan fatte un roveto, così (Dio) nel suo sdegno li divorerà quasi ancora vivi. Quando gli appetiti dell’anima sono ancora vivi e impediscono di comprendere Dio, vengono da lui distrutti in questa vita o nell’altra, con il castigo e la correzione, che avverrà attraverso la purificazione. Dice che li consumerà nella sua ira, perché ciò che si soffre nella mortificazione degli appetiti è punizione per i danni causati all’anima.
6. Oh, se gli uomini conoscessero tutto il bene della luce divina di cui questa cecità causata dagli affetti e dagli appetiti li priva! Se sapessero in quanti mali e in quanti danni cadono ogni giorno, per non volerli mortificare! Non devono fidarsi della loro buona intelligenza o di altri doni ricevuti da Dio, convinti che qualche affetto o appetito non possa accecare od oscurare e farli cadere a poco a poco in basso. Chi avrebbe detto, infatti, che un uomo tanto saggio e ricco di doni di Dio come Salomone sarebbe arrivato, ormai vecchio, a tanta cecità e debolezza di volontà da erigere altari a numerosi dei e ad adorarli lui stesso (1Re 11,4-8)? Per indurlo a tanto, bastò la passione per le donne e l’incuria nel mortificare gli appetiti e i piaceri del cuore. Egli stesso dice di sé nell’Ecclesiaste di non aver negato nulla al suo cuore (Qo 2,10). È fuori dubbio che in principio agisse con prudenza, ma si lasciò trascinare dai suoi appetiti, perché non li mortificava affatto, al punto che questi a poco a poco lo accecarono e oscurarono la sua intelligenza, fino a soffocare del tutto quella grande luce di sapienza che Dio gli aveva concesso; e così, ormai vecchio, abbandonò Dio.
7. Ora, se gli appetiti poterono tanto in un uomo che conosceva a fondo la distanza vigente tra il bene e il male, cosa non potranno fare contro la nostra ignoranza se non li mortifichiamo? Ebbene, come disse Dio a Giona parlando dei niniviti, noi non conosciamo la differenza tra la sinistra e la destra (Gio 4,11), e ad ogni istante confondiamo il male con il bene e il bene con il male: ecco cosa siamo capaci di fare da soli! Cosa avverrà, allora, se alla tenebra naturale si aggiungerà l’appetito? Accadrà ciò che dice Isaia: Palpavimus sicut caeci parietem, et quasi absque oculis attrectavimus: impegimus meridie, quasi in tenebris (Is 59,10). Il profeta parla di coloro che amano seguire i loro appetiti ed è come se dicesse: Tastiamo come ciechi la parete, come privi di occhi camminiamo a tastoni; inciampiamo a mezzogiorno come al crepuscolo. Chi è accecato dall’appetito, anche se posto nella piena luce della verità e del suo dovere, non vede nulla, perché è come se fosse nelle tenebre.
CAPITOLO 9
Ove si tratta del modo con cui gli appetiti sporcano l’anima. Lo si prova con paragoni e l’autorità della sacra Scrittura.
1. La quarta forma di danno che gli appetiti recano all’anima consiste nello sporcarla e macchiarla, così come dice l’Ecclesiastico: Qui tetigerit picem, inquinabitur, ab ea: Chi maneggia la pece si sporca (13,1). Ora, chi si compiace di qualche cosa creata è come se toccasse la pece. Occorre notare che il Saggio paragona le cose create alla pece, perché tra l’eccellenza dell’anima e quanto di meglio c’è in tali cose intercorre una differenza maggiore di quella esistente tra il diamante puro o l’oro fino e la pece. Se si versasse della pece bollente sull’oro o su un diamante, essi ne verrebbero subito sporcati e unti, a seconda del calore più o meno elevato della pece. Lo stesso avviene per l’anima che arde di bramosia per qualche cosa creata: ne contrae la sporcizia e le macchie. Per di più, tra l’anima e le altre creature corporee c’è più differenza di quanta ve ne sia tra un liquido cristallino e il fango più denso. Se quel liquido venisse mescolato al fango si insudicerebbe; così si sporca l’anima che si accosta alle cose create, perché rende se stessa simile a dette cose. Come i segni di fuliggine deturpano un volto molto bello e perfetto, così gli appetiti disordinati sporcano e deturpano l’anima che ne è prigioniera, anche se per natura è bellissima e immagine perfetta di Dio.
2. Per questo Geremia, piangendo il danno e la bruttezza che simili attaccamenti disordinati provocano nell’anima, prima ne esalta la bellezza e poi ne deplora la bruttezza con queste parole: Candidiores sunt nazaraei eius nive, nitidiores lacte, rubicundiores ebore antiquo, saphiro pulchriores. Denigrata est super carbones facies eorum, et non sunt cogniti in plateis: I suoi nazareni, cioè i capelli dell’anima, erano più splendenti della neve, più candidi del latte; avevano il corpo più roseo dei coralli, era zaffiro la loro figura. Ora il loro aspetto s’è fatto più scuro della fuliggine, non si riconoscono più per le strade (Lam 4,7-8). Per capelli intendiamo qui gli affetti e i pensieri dell’anima; se restano nell’ordine stabilito da Dio, cioè in Dio stesso, sono più candidi della neve, più bianchi del latte, più lucidi dell’avorio e più splendenti dello zaffiro. Con queste quattro cose s’intende ogni forma di bellezza e di eccellenza delle cose terrene. Geremia dice che se le operazioni dell’anima – corrispondenti ai nazarei o capelli – sono disordinate e rivolte a un fine opposto alla legge di Dio, cioè utilizzate nelle cose create, la faccia dell’anima, per così dire, diventa più nera del carbone.
3. Tutto questo male, e anche di più, è causato contro la bellezza dell’anima dagli appetiti disordinati per le cose di questo mondo. Se volessimo parlare espressamente dell’aspetto brutto e sporco al quale gli appetiti riducono l’anima, non troveremmo un luogo, per quanto pieno di ragnatele e di vermi, né un cadavere con tutta la sua deformità, né qualsiasi altra cosa immonda e sporca che si possa immaginare in questa vita, con cui paragonarla. L’anima disordinata, infatti, sebbene per natura sia perfetta come Dio l’ha creata, tuttavia in quanto essere razionale è divenuta brutta, abominevole, sporca, priva di luce, piena di tutte le imperfezioni di cui sto parlando e altre ancora. Un solo appetito disordinato, infatti, come dirò più avanti, sebbene non costituisca materia di peccato mortale, è sufficiente per rendere l’anima tanto schiava, sudicia e brutta che in nessun modo può unirsi a Dio, finché non si purifichi di quell’appetito. Quale sarà, allora, la bruttezza di quella che è tutta disordinata, immersa nelle sue passioni e schiava dei suoi appetiti? Quanto sarà lontana da Dio e dalla sua purezza?
4. Le parole non potrebbero spiegare né tanto meno la ragione comprendere le varie specie d’impurità che i diversi appetiti provocano nell’anima. Se lo si potesse esprimere e farlo comprendere, si rimarrebbe sorpresi e toccati da grande compassione nel constatare come ogni appetito, a seconda della sua qualità e del suo grado d’intensità, lasci la sua impronta e la sua patina d’immondezza e bruttezza nell’anima. Vedremmo anche come gli appetiti, in un disordine sostanzialmente unico, contengano in sé innumerevoli specie di sozzure, maggiori o minori secondo la propria natura. Come l’anima del giusto in un’unica perfezione, cioè nella rettitudine, possiede innumerevoli e ricchissimi doni e molte virtù, diverse e belle ognuna a suo modo, a seconda delle diverse affezioni che la portano a Dio; così l’anima disordinata, trascinata dalle diverse inclinazioni per le cose create, contiene in sé una deplorevole varietà di sozzure e di bassezze che le derivano dai suddetti appetiti.
5. Questa varietà di appetiti è ben raffigurata nel libro di Ezechiele (8,10-16), dove si legge che Dio gli mostrò, dipinti sulle pareti interne del tempio, ogni sorta di rettili che strisciano sulla terra e ogni genere abominevole di animali immondi. Dio disse, allora, a Ezechiele: Hai visto, figlio dell’uomo? Vedrai abomini peggiori di questi, che ciascuno compie nella stanza recondita del proprio idolo. Poi Dio ordinò al profeta d’inoltrarsi sempre più per vedere nefandezze ancora peggiori. Il profeta racconta di aver visto donne sedute che piangevano Adone, il dio dei loro amori. Quando Dio gli ordinò di andare oltre per vedere abominazioni ancora più grandi delle precedenti, vide venticinque anziani con le spalle rivolte al tempio.
6. Le diverse specie animali schifosi e immondi, ritratte nel primo recesso del tempio, raffigurano i pensieri e i concetti che l’intelletto elabora sulle cose vili della terra e su tutte le cose create; queste, così come sono, s’imprimono nel tempio dell’anima, quando se ne ingombra l’intelletto, che è la prima facoltà dello spirito. Le donne che si trovavano più all’interno, nel secondo locale, ove piangevano il dio Adone, simboleggiano gli appetiti, che hanno sede nella seconda potenza dell’anima, cioè nella volontà. Essi stanno piangendo, per così dire, perché bramano ciò a cui la volontà è affezionata, cioè i rettili già rappresentati nell’intelletto. Gli uomini che si trovavano nel terzo locale del tempio, sono le immagini e le rappresentazioni delle cose create, che la terza potenza dell’anima, cioè la memoria, conserva e rimugina dentro di sé. Tali rappresentazioni volgono le spalle al tempio; ciò vuol dire che l’anima, quando con le sue tre potenze si porta totalmente e perfettamente verso qualche essere creato, rivolge le spalle al tempio di Dio, cioè alla sua retta ragione, che non ammette in sé alcuna cosa creata.
7. Quanto è stato detto fin qui è sufficiente per darci un’idea del disordine causato nell’anima dai suoi appetiti. Se, infatti, dovessi trattare nei particolari della bruttezza, pur minore, provocata nell’anima dalle imperfezioni e le loro varietà; o di quella, più grande della precedente, causata dai peccati veniali in tutta la loro varietà; o, infine, di quella prodotta dagli appetiti del peccato mortale, in tutta la loro varietà, che rendono l’anima completamente orrida, non finirei più. Neanche un’intelligenza angelica sarebbe in grado di comprendere la varietà e la moltitudine di queste tre cose. Mi limito a dire, a conferma del mio argomento, che qualsiasi appetito, anche se ha per oggetto la più piccola imperfezione, macchia e sporca l’anima.
CAPITOLO 10
Ove si mostra come gli appetiti intiepidiscano e indeboliscano l’anima nell’esercizio della virtù.
1. La quinta forma di danno provocato dagli appetiti nell’anima consiste nel renderla tiepida e debole a tal punto che non ha più la forza di seguire la virtù e di perseverare in essa. Nel caso, infatti, in cui la forza degli appetiti si divide verso più oggetti, risulta più debole che se fosse concentrata su un oggetto unico; più essa si divide, più s’indebolisce nei riguardi di ogni oggetto. Per questo i filosofi dicono che la virtù unita ha più forza di quella che è divisa. Pertanto, se l’appetito della volontà si disperde verso qualcosa al di fuori della virtù, è chiaro che diverrà più fiacca per praticare la stessa virtù. L’anima che disperde la sua volontà dietro a inezie è come l’acqua che, trovando un varco per scorrere a valle, non cresce verso l’alto, e di conseguenza non serve a nulla. Per questo il patriarca Giacobbe paragonò il figlio Ruben all’acqua versata, perché, nel commettere un certo peccato, aveva lasciato libero corso ai suoi appetiti: Ti sei versato come l’acqua e non crescerai (Gn 49,4), come se volesse dirgli: poiché ti sei disperso come l’acqua, seguendo i tuoi appetiti, non crescerai nella virtù. Come l’acqua bollente, se non viene coperta, facilmente perde il suo calore, o come le specie aromatiche, se lasciate all’aria, perdono a poco a poco la fragranza e la forza del loro profumo, così l’anima non concentrata nell’unico desiderio di Dio perde l’ardore e il vigore della virtù. Aveva ben compreso questa verità Davide, quando, rivolgendosi a Dio, disse: Fortitudinem meam ad te custodiam: Custodirò la mia forza per te (Sal 58,10), cioè raccogliendo solo su di te la forza dei miei appetiti.
2. Gli appetiti indeboliscono la forza dell’anima, perché sono per essa come i polloni che crescono attorno all’albero e gli sottraggono vigore, impedendogli di portare molto frutto. Di queste anime il Signore dice: Vae praegnantibus et nutrientibus in illis diebus!, cioè: Guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni! (Mt 24,19), alludendo alla gestazione e al nutrimento degli appetiti. Se questi non verranno mortificati, sottrarranno continuamente forza all’anima e cresceranno per la sua rovina, come i polloni attorno all’albero. Per questo il Signore ci raccomanda: Siate pronti, con la cintura ai fianchi (Lc 12, 35), cioè mortificate gli appetiti. Questi, infatti, sono come le sanguisughe che succhiano continuamente il sangue delle vene. Così li chiama l’Ecclesiastico quando dice: Sanguisughe sono le figlie, cioè gli appetiti; dicono sempre: Dammi, dammi (Pro 30,15).
3. È chiaro, quindi, che gli appetiti non procurano alcun bene all’anima, anzi le tolgono quello che ha. Se non sono mortificati, non si fermano finché non compiono in essa ciò che fanno i figli della vipera: mentre crescono nel suo ventre la mordono e la uccidono, restando essi vivi a prezzo della sua morte. Gli appetiti non mortificati arrivano a tanto: uccidono la vita di Dio nell’anima, perché questa non li ha uccisi per prima. Perciò l’Ecclesiastico dice: Aufer a me, Domine, ventris concupiscentias et concubitus concupiscentiae ne apprehendant me: Togli da me le intemperanze del ventre e i desideri della libidine non abbiano potere su di me (Sir 23,6); infatti quel che vive nell’anima sono gli appetiti.
4. Anche se non arrivano a tanto, è tuttavia cosa degna di compassione il considerare lo stato in cui gli appetiti riducono l’anima e quanto la rendono insopportabile a se stessa, insensibile verso il prossimo, tarda e pigra nelle cose di Dio. Non esiste, infatti, umore cattivo che renda al malato il camminare così pesante difficoltoso o il mangiare così disgustoso, quanto l’appetito delle cose create appesantisce e rattrista l’anima nell’esercizio della virtù. Abitualmente, il motivo per cui molte anime non hanno zelo e costanza nell’acquistare la virtù è che coltivano appetiti e affetti non puri nei riguardi di Dio.
CAPITOLO 11
Ove si prova quanto sia necessario all’anima, per raggiungere l’unione divina, liberarsi da tutti gli appetiti, anche se minimi.
1. Mi sembra che da tempo il lettore desideri chiedermi se per giungere a questo sublime stato di perfezione sia prima necessario aver mortificato completamente tutti gli appetiti, piccoli e grandi, o se basti mortificarne alcuni trascurandone altri, almeno quelli che sembrano meno pericolosi. Sembra, infatti, un’impresa molto difficile e ardua che l’anima possa arrivare a tanta purezza e nudità da escludere ogni desiderio e affezione per qualche cosa.
2. Rispondo premettendo che non tutti gli appetiti sono ugualmente nocivi e ostacolanti il progresso dell’anima. Mi riferisco agli appetiti volontari, perché quelli naturali impediscono poco o nulla l’unione con Dio, purché non sia dato loro il consenso o non vadano oltre i limiti di moti spontanei. Chiamo naturali e spontanei quei moti ai quali la volontà, illuminata dalla ragione, non partecipa né prima né dopo gli atti. Eliminarli o mortificarli totalmente in questa vita è impossibile. Anche se non sono del tutto mortificati, non impediscono all’anima di giungere all’unione divina. Possono, infatti, essere ben presenti nella natura umana e ciò nonostante l’anima, nella sua sfera razionale, può esserne completamente libera. Anzi potrà accadere che talvolta l’anima sia con la volontà assorta in profonda orazione di quiete, mentre essi si manifestano nella parte sensitiva dell’uomo, alla quale, però, non partecipa la sfera razionale, che è in preghiera. L’anima, invece, che vuol pervenire all’unione perfetta con Dio, deve eliminare e disfarsi di tutti gli appetiti volontari, anche se piccoli, sia di quelli più gravi che conducono al peccato mortale, sia di quelli meno gravi che spingono al peccato veniale, sia di quelli meno gravi ancora che portano alle imperfezioni. Questo perché lo stato di tale unione consiste nel trasformare la volontà dell’anima in quella di Dio, in modo tale che in essa non vi sia nulla di contrario al volere di Dio, ma tutto, in tutti i suoi atti, sia voluto unicamente da Dio.
3. Per questo motivo affermo che in tale stato le due volontà, quella divina e quella umana, s’identificano, sono insieme volontà di Dio e dell’anima. Pertanto, se quest’anima desiderasse qualcosa d’imperfetto che Dio non può volere, verrebbe meno quell’unione di volontà, perché essa vorrebbe ciò che Dio non vuole. È chiaro, quindi, che per giungere a unirsi perfettamente con Dio, per mezzo dell’amore e della volontà, l’anima deve liberarsi anzitutto di ogni appetito volontario, per piccolo che sia. Occorre, cioè, che la volontà non acconsenta avvertitamene e consapevolmente a imperfezione alcuna e giunga ad avere la forza e la libertà di poterlo fare, qualora se ne accorga. Dico consapevolmente, perché se l’anima non avverte l’appetito, non lo riconosce o non è in suo potere, allora potrà cadere in imperfezioni, in peccati veniali e negli appetiti naturali di cui ho già parlato. Di queste mancanze involontarie e non avvertite sta scritto: Il giusto cade sette volte al giorno e si rialza (Pro 24,16). Quanto agli appetiti volontari, che sono peccati veniali deliberati, ne basta, ripeto, uno solo, anche se minimo, non mortificato per impedire l’unione divina. Mi riferisco qui all’abitudine non mortificata e non a qualche atto proveniente da passioni diverse, che non reca gran danno quando le abitudini sono mortificate. L’anima, però, deve liberarsi altresì da questi atti sporadici, perché anch’essi derivano da abitudini imperfette. Le abitudini imperfette volontarie, se non vengono mai vinte, non solo impediscono l’unione, ma a lungo andare anche il progresso nella perfezione.
4. Queste imperfezioni abituali sono l’abitudine diffusa di parlare molto, un tenue attaccamento a qualcosa che non ci si decide mai a superare, come, per esempio, a una persona, a un vestito, a un libro, alla cella, a un determinato cibo o a piccole chiacchiere e soddisfazioni, per il piacere di gustare le cose, di sapere, di ascoltare o cose simili. Ciascuna di queste imperfezioni, a cui l’anima si è attaccata, facendone l’abitudine, ne danneggiano la crescita e il progresso nella virtù molto più che se cadesse ogni giorno in molte altre imperfezioni e peccati veniali non derivanti da un’abitudine cattiva. Finché dura quest’abitudine, infatti, è impossibile che l’anima possa progredire nella perfezione, anche se commettesse imperfezioni di poco conto. Poco importa che un uccello sia legato a un filo sottile o grosso; anche se sottile, finché sarà legato, è come se fosse grosso, perché non gli consentirà di volare. È vero che è più facile spezzare il filo sottile; ma anche se facile, finché non lo spezza, non vola. Così accade all’anima che è attaccata a qualcosa: anche se possiede molte virtù, non arriverà mai alla libertà dell’unione divina. L’appetito o l’attaccamento dell’anima ha le stesse proprietà della remora che, pur essendo un pesce molto piccolo, se riesce ad attaccarsi alla nave, la tiene frenata al punto da impedirle di navigare e di arrivare al porto. È una pena vedere alcune anime che, come navi cariche di tesori, sono ricche di opere buone, di esercizi di pietà, di virtù e di doni divini, ma non progrediscono né arrivano al porto della perfezione, perché non hanno il coraggio di disfarsi di un piccolo gusto, di un attaccamento o di un’affezione, che è la stessa cosa. Basterebbe che con un volo ardito spezzassero quel filo di attaccamento e si liberassero dalla remora dell’appetito.
5. È molto deplorevole che, avendole Dio aiutate a spezzare legami più grossi relativi ad affezioni che conducevano al peccato e alla vanità, queste anime, per non staccarsi da un’inezia che Dio chiede di vincere per amor suo, non riescano a raggiungere un bene così grande. Eppure si tratta solo di un filo o di un capello. Il peggio è che, a causa di quell’affetto, non solo non progrediscono, ma tornano indietro, perdendo ciò che in tanto tempo e a prezzo di grande fatica avevano guadagnato. Si sa, infatti, che in questo cammino non andare avanti equivale a tornare indietro e non guadagnare è come perdere. Questo è quanto ha voluto insegnarci il Signore, quando dice: Chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde (Mt 12,30). Chi non ha cura di riparare anche la più piccola screpolatura del vaso, perderà tutto il liquido in esso contenuto. Ce lo ha insegnato bene l’Ecclesiastico, quando afferma: Chi disprezza il poco, cadrà presto (Sir 19,1); e ancora: Con una scintilla di fuoco si riempie il braciere (Sir 11,32). Basta un’imperfezione per chiamarne un’altra e altre ancora; quasi mai si vedrà un’anima negligente nel vincere un appetito disordinato, la quale non ne abbia molti altri derivanti dalla stessa negligenza e imperfezione che dimostra in tale appetito. Così facendo, andrà di male in peggio. Ho visto molte persone, alle quali Dio aveva fatto la grazia di avanzare molto nel distacco e nella libertà, perdere a poco a poco lo spirito e il gusto di Dio, la santa solitudine, la gioia e l’assiduità nelle pratiche di pietà, fino a perdere tutto, soltanto perché avevano incominciato a lasciarsi vincere da un piccolo attaccamento, un’affezione, una conversazione o un’amicizia, sotto il pretesto di bene. Tutto questo perché non troncarono fin dall’inizio quel gusto o appetito sensibile, non custodendo così il loro cuore per Dio solo.
6. In questo cammino è necessario andare sempre avanti per poter raggiungere la meta, cioè estirpare continuamente i propri appetiti e mai fomentarli; finché non ci si decide a eliminarli tutti, non si raggiungerà il traguardo. Come il legno non si trasforma in fuoco se gli manca un solo grado di calore richiesto, così l’anima non si trasformerà in Dio a causa di una sola imperfezione, anche se più piccola di un appetito volontario. Come dirò più avanti nella notte della fede, l’anima ha una sola volontà. Se essa la ingombra o l’applica con l’affetto per qualcosa, non rimane libera, integra, sola e pura, elementi indispensabili per attingere la trasformazione in Dio.
7. A tale proposito ci viene detto nel libro dei Giudici: l’angelo venne dai figli di Israele e, dopo averli rimproverati perché non avevano sterminato la nazione nemica, anzi si erano alleati con alcuni di loro, annunziò che Dio li avrebbe lasciati in mezzo a loro come nemici, perché fossero occasione d’inciampo e di perdizione (Gdc 2,2-3). Con alcune anime Dio ha fatto proprio così: le ha tolte dal mondo, ha ucciso i giganti dei loro peccati e sterminato la moltitudine dei loro nemici, cioè le occasioni pericolose che avevano nel mondo, facendole entrare con maggior libertà in questa terra promessa dell’unione divina. Malgrado ciò, esse stringono amicizia e alleanza con il popolo minuto delle imperfezioni che non riescono mai a mortificare completamente. Per questo il Signore, adirato, le lascia sempre più in preda ai loro appetiti.
8. Anche nel libro di Giosuè abbiamo una figura di quanto sto dicendo. Quando gli ebrei stavano per impadronirsi della terra promessa, Dio ordinò loro di distruggere la città di Gerico in modo da non lasciare in vita alcun essere che vi abitava, dall’uomo alla donna, dal giovane al vecchio, compresi gli animali; ingiunse, altresì, di non prendere né tanto meno desiderare il bottino catturato (Gs 6,17-21). Questo ci permette di capire che, per entrare nell’unione divina, tutto ciò che vive nell’anima, poco o molto che sia, piccolo o grande, deve morire; anzi l’anima deve liberarsi dal desiderio di tutto questo, distaccandosene al punto di essere completamente estranea a tutto ciò. Anche san Paolo, nella lettera ai Corinzi, c’insegna tale verità: Questo vi dico, fratelli: il tempo ormai si è fatto breve; d’ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l’avessero; coloro che piangono come se non piangessero e quelli che godono come se non godessero; quelli che comprano come se non possedessero; quelli che usano del mondo come se non ne usassero appieno (1Cor 7,29-31). Ecco quanto ci dice l’Apostolo, insegnandoci come dobbiamo tener distaccata l’anima da tutte le cose, per andare a Dio.
CAPITOLO 12
Ove si risponde a un’altra domanda, dicendo quali sono gli appetiti sufficienti a provocare nell’anima i suddetti danni.
1. Potrei dilungarmi molto su questa materia della notte dei sensi, analizzando ancora altri danni che causano gli appetiti, non solamente sotto gli aspetti già considerati, ma altresì sotto molti altri. Tuttavia, per lo scopo che mi sono prefisso, basta quanto è stato detto. Mi sembra, infatti, d’aver spiegato sufficientemente perché la mortificazione degli appetiti si chiami notte e quanto sia opportuno entrare in essa per andare a Dio. Per concludere questa parte, rimane solo da risolvere qualche dubbio che potrebbe sorgere nella mente del lettore su ciò che ho detto, prima di affrontare il modo di entrare in questa notte.
2. Anzitutto ci si potrebbe chiedere se basti un qualsiasi appetito a produrre e causare nell’anima i due mali sopracitati, cioè quello privativo, che priva l’anima della grazia di Dio, e quello positivo, che provoca in essa i cinque danni principali, dei quali, appunto, ho parlato. In secondo luogo ci si potrebbe chiedere se sia sufficiente qualsiasi appetito, per quanto piccolo e di qualsiasi genere, a causare tutti questi cinque danni insieme, oppure se alcuni appetiti causino determinati danni, e altri danni diversi; per esempio, se alcuni causino tormento, altri stanchezza, altri tenebra, ecc.
3. Per rispondere al primo dubbio circa il danno positivo, dico che solo gli appetiti volontari, aventi per oggetto il peccato mortale, possono privare l’anima di Dio e lo fanno totalmente. Essi, infatti, privano l’anima della grazia in questa vita e nell’altra della gloria, cioè del possesso di Dio. Al secondo dubbio rispondo affermando che sia gli appetiti in materia di peccato mortale sia quelli volontari in materia di peccato veniale o di imperfezione sono sufficienti a provocare nell’anima tutti questi danni positivi insieme. Li chiamo positivi, sebbene in un certo senso siano privativi, perché si riferiscono all’anima che si volge alle cose create, come il privativo di riferisce al suo allontanamento da Dio. Ma c’è una differenza: gli appetiti, aventi per oggetto il peccato mortale, causano cecità totale, tormento, sporcizia e debolezza, ecc.; mentre quelli aventi per oggetto i peccati veniali o l’imperfezione non causano questi mali in forma assoluta e in sommo grado, perché non privano l’anima della grazia, da cui dipende la loro presenza. La morte della grazia è, infatti, la vita degli appetiti. Tuttavia essi provocano nell’anima qualcosa di tali mali gradualmente, a mano a mano che diminuisce in essa la grazia. In questo modo, più un appetito riduce l’azione della grazia, più grave è il tormento, la cecità e l’impurità che procura all’anima.
4. Va notato, però, che, sebbene ciascun appetito causi tutti questi mali che ho chiamato positivi, tuttavia ve ne sono alcuni che ne provocano uno in modo principale e diretto, dal quale poi derivano tutti gli altri. Sebbene sia vero che un appetito sensuale causi tutti questi mali, è altrettanto vero che principalmente e propriamente esso insudicia l’anima e il corpo. Tutti questi danni li provoca anche l’appetito dell’avarizia, ma principalmente e direttamente esso genera afflizione. Allo stesso modo, sebbene un appetito di vanagloria, come gli altri, sia causa di tutti quegli effetti, principalmente e direttamente, però, esso provoca tenebre e cecità. Infine, sebbene un appetito di gola generi i suddetti mali, principalmente provoca tiepidezza nella virtù. Lo stesso vale per gli altri appetiti.
5. Qualsiasi atto volontario degli appetiti produce, dunque, nell’anima tutti questi effetti insieme, perché è direttamente contrario agli atti di virtù che producono nell’anima gli effetti contrari. Come un atto di virtù produce nell’anima e genera allo stesso tempo soavità, pace, consolazione, luce, purezza e forza, così un appetito disordinato causa tormento, fatica, stanchezza, cecità e debolezza. Tutte le virtù crescono quando se ne pratica una, e tutti i vizi, insieme agli effetti da essi lasciati nell’anima, crescono con l’aumentare di uno di essi. E sebbene nel momento in cui si soddisfa quell’appetito non si riescano a vedere tutti questi mali, perché il piacere provato non lo consente, tuttavia prima o poi se ne avvertono le conseguenze. Tale verità viene chiaramente insegnata nell’Apocalisse, quando l’angelo comanda a san Giovanni di mangiare un libro, che gli sembrò dolce nella bocca e amaro nelle viscere (Ap 10,9-10). Infatti, quando l’appetito viene soddisfatto è dolce e sembra buono, ma dopo se ne avvertono i suoi amari effetti. Questo lo può ben dire chi si lascia trasportare dalle passioni. Non ignoro, tuttavia, che esistono persone tanto cieche e insensibili da non sentire tale amarezza, perché, non curandosi di andare a Dio, non si preoccupano degli ostacoli che li separano da lui.
6. Qui non tratterò degli appetiti secondo natura, che sono involontari, né dei pensieri che rimangono allo stadio di moti primi, né di altre tentazioni alle quali non si acconsente, perché tutti questi non recano nessuno dei mali suddetti all’anima. La persona che li subisce, a causa della passione e del turbamento che in quel momento le provocano, può pensare che la stiano sporcando e accecando, ma non è così; anzi, le procurano i vantaggi contrari. Opponendo resistenza ad essi, infatti, acquista fortezza, purezza, luce, consolazione e molti altri beni, secondo quanto il Signore ha insegnato a san Paolo: La virtù si manifesta pienamente nella debolezza (2Cor 12,9). Quanto agli appetiti volontari, essi provocano tutti i mali di cui abbiamo parlato e molti altri. Per questo la preoccupazione principale dei maestri di spirito è quella di mortificare nei loro discepoli qualsiasi appetito, invitandoli a privarsi della soddisfazione dei loro desideri, per liberarli da una miseria così grande.
CAPITOLO 13
Ove si tratta del comportamento che l’anima deve seguire per entrare in questa notte dei sensi.
1. Non mi resta, ora, che offrire alcune norme, perché l’anima sappia e possa entrare in questa notte dei sensi. A tale proposito, occorre sapere che l’anima abitualmente entra in questa notte dei sensi in due modi: uno attivo e l’altro passivo. Quello attivo comprende tutto ciò che l’anima può fare e fa da sola per entrare nella notte. Ne tratterò subito nelle norme che seguiranno. Quello passivo, invece, si verifica quando l’anima non fa nulla da sé, ma resta passiva all’azione di Dio. Di questa tratterò nel libro quarto, quando si parlerà dei principianti. E poiché là, a Dio piacendo, darò molti suggerimenti ai principianti, secondo le molte imperfezioni in cui abitualmente cadono lungo questo cammino, qui non mi dilungo. Del resto, questo non è il luogo più opportuno per dare tali suggerimenti, perché qui ci occupiamo di conoscere solo i motivi per cui questo passaggio si chiami notte, in che cosa essa consista e in quante parti si divida. Perché la mia esposizione non appaia troppo breve e poco utile alle anime, proporrò loro alcuni mezzi o norme necessarie per esercitarsi in questa notte degli appetiti. Ho voluto fornirli qui di seguito in forma succinta. Lo stesso farò alla fine delle altre due parti o cause di questa notte, di cui mi propongo di trattare con l’aiuto di Dio.
2. I suggerimenti seguenti, necessari per vincere gli appetiti, sebbene siano brevi e pochi, sono, a mio avviso, molto utili ed efficaci quanto concisi. Chi, dunque, volesse davvero metterli in pratica, non ne avrà bisogno di altri, perché questi li comprendono tutti.
3. In primo luogo, occorre coltivare un costante desiderio d’imitare Cristo in ogni azione, conformandosi alla sua vita, sulla quale bisogna riflettere per saperla imitare e per comportarsi come lui si comporterebbe.
4. In secondo luogo, per ben riuscire in quest’intento, occorre rinunciare a qualsiasi piacere che si presenti ai sensi, che non sia unicamente a onore e gloria di Dio. Occorre liberarsene per amore di Gesù Cristo, che in questa vita non ebbe né cercò altro piacere che fare la volontà del Padre suo, che egli chiamava suo cibo e sua bevanda (Gv 4,34). Se, per esempio, si presenta un’occasione di ascoltare con piacere cose che non servono al servizio e all’onore di Dio, si rinunzi al gusto di ascoltarle. Se, poi, si offre il piacere di guardare cose che non aiutano ad amare di più Dio, si reprima il desiderio di guardarle. Ci si comporti allo stesso modo nel parlare, nel compiere qualche altra azione o nel soddisfare qualche altro senso, per quanto sarà possibile. Se ciò non fosse possibile, basta non assaporarne il gusto delle cose che non si possono evitare. In questo modo, occorre mortificare e liberare i sensi dalle soddisfazioni, come se li si lasciasse al buio. Così facendo, in breve tempo si progredirà molto.
5. Per mortificare e placare le quattro passioni naturali, che sono la gioia, la speranza, il timore e il dolore, dalla cui concordia e pacificazione derivano questi e altri beni, è rimedio efficace, fonte di grande merito e causa di grandi virtù mettere in pratica quanto segue.
6. Procuri l’anima di tendere sempre:
non al più facile, ma al più difficile;
non al più saporito, ma al più insipido;
non al più piacevole, ma al più disgustoso;
non al riposo, ma alla fatica;
non al conforto, ma allo sconforto;
non al più, ma al meno;
non al più alto e pregevole, ma al più vile e spregevole;
non a voler qualcosa, ma a non voler nulla;
non alla ricerca del meglio nelle cose terrene, ma al peggio, e desiderare in tutto nudità, vuoto e povertà di quanto v’è al mondo per amore di Cristo.
7. Occorre che l’anima abbracci di cuore queste norme e procuri di addestrarvi la volontà. Se, infatti, le metterà in pratica, in brevissimo tempo troverà in esse gran diletto e consolazione, e agirà con ordine e discrezione.
8. Per entrare nella notte dei sensi è sufficiente eseguire bene quanto ho detto. Ciò nonostante, per offrire più ampie spiegazioni, proporrò un’altra sorta di esercizi che insegnano a mortificare la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, cose che secondo san Giovanni, regnano nel mondo (1Gv 2,16) e dalle quali derivano tutti gli altri appetiti.
9. Anzitutto, l’anima cerchi di lavorare al disprezzo di sé e di desiderare che lo facciano anche gli altri; questa pratica va contro la concupiscenza della carne. In secondo luogo, cerchi di parlare in proprio disprezzo e desiderare che anche gli altri si comportino allo stesso modo; questa pratica va contro la concupiscenza degli occhi. In terzo luogo, cerchi di pensare umilmente di sé fino al proprio disprezzo e di desiderare che anche gli altri facciano lo stesso; questa pratica va contro la superbia della vita.
10. A conclusione di questi suggerimenti e di queste norme, è opportuno riportare qui quei versi scritti sotto il disegno della Salita del Monte, riprodotto nelle pagine immediatamente prima di quest’opera. Essi racchiudono la dottrina per salire al suo vertice, cioè all’unione divina. Sebbene sia vero che ivi si parla del lavoro spirituale e interiore dell’anima, s’insegna anche a mortificare lo spirito d’imperfezione nel suo aspetto sensibile ed esteriore, come si può vedere nelle due vie poste ai lati del sentiero della perfezione. È in quest’ultimo senso che qui li intendiamo. Nella seconda parte di questa notte, invece, li interpreteremo in senso spirituale.
11. I versi dicono così:
Per poter gustare il tutto,
non cercare il gusto in nulla.
Per poter possedere il tutto,
non voler possedere nulla.
Per poter essere tutto,
non voler essere nulla.
Per poter conoscere il tutto,
non voler sapere nulla.
Per raggiungere ciò che ora non godi,
devi passare per dove non godi.
Per arrivare a ciò che non sai,
devi passare per dove non sai.
Per arrivare al possesso di ciò che non hai,
devi passare per dove non hai.
Per giungere a ciò che non sei,
devi passare per dove non sei.
METODO PER NON OSTACOLARE IL TUTTO
12. Se ti fissi su qualcosa,
tralasci di slanciarti verso il tutto.
Se vuoi giungere per davvero al tutto,
devi rinnegarti totalmente in tutto.
E qualora giungessi ad avere il tutto,
devi possederlo senza voler nulla.
Se vuoi possedere qualcosa nel tutto,
non hai il tuo unico tesoro in Dio.
13. In questa nudità la persona spirituale trova pace e riposo. Non desiderando nulla, nulla l’appesantisce nell’ascesa verso l’alto, nulla la sospinge verso il basso, perché è al centro della sua umiltà. Quando, invece, brama qualcosa, proprio per questo si affatica.
CAPITOLO 14
Ove si spiega il secondo verso della strofa:
Con ansie, dal mio amor tutta infiammata.
1. Ho già spiegato il primo verso di questa strofa, che parla della notte dei sensi; ho pure detto che cosa intendere per notte dei sensi e perché si chiama notte. Si è parimenti indicato l’ordine e il comportamento da seguire per entrare attivamente in essa. Ora è il momento di trattare delle sue proprietà e dei suoi effetti meravigliosi, contenuti nei versi successivi di detta strofa. Perciò, come ho promesso nel Prologo, citerò e spiegherò brevemente questi versi; poi passerò al libro II, che tratta dell’altra parte di questa notte, cioè della notte dello spirito.
2. L’anima afferma, dunque che con ansie e dall’amor tutta infiammata, attraverso la notte oscura del senso, giunse all’unione con l’Amato. In realtà, per vincere tutti gli appetiti e mortificare le attrattive di tutte le cose create, per amore e affetto delle quali la volontà è solita accendersi allo scopo di goderne, era necessaria un’altra fiamma di un amore superiore, che è quello del suo Sposo. Riponendo in lui la propria gioia e la propria forza, trova vigore e costanza per negare facilmente tutti gli altri amori. Per vincere la forza degli appetiti sensibili, non basta all’anima il semplice amore per il suo Sposo; deve altresì ardere d’amore e stare in ansia per lui. Accade, infatti, come testimonia l’esperienza, che la sensibilità è talmente attratta verso le realtà sensibili da tante ansie di appetito che se la parte spirituale non è infiammata da un amore ancora più forte verso le realtà spirituali, non potrà spezzare il giogo della natura, né entrare in questa notte dei sensi, né avere il coraggio di starsene all’oscuro di tutte le cose, privandosi del loro piacere.
3. Non è possibile né opportuno dire in questo luogo quali e quanti siano i desideri d’amore che le anime nutrono agli inizi di questo cammino di unione; quali siano le attenzioni e gli espedienti da loro adoperati per uscire dalla propria casa, cioè dalla propria volontà, nella notte della mortificazione dei loro sensi; e, infine, quanto le ansie dello Sposo rendano facili, dolci e piacevoli le fatiche e i pericoli di questa notte. Poiché è meglio meditare e sperimentare tali cose più che descriverle, passerò alla spiegazione degli altri versi nel capitolo che segue.
CAPITOLO 15
Ove si spiegano gli altri versi della strofa:
Oh, sorte fortunata!,
uscii, né fui notata,
stando la mia casa al sonno abbandonata.
1. L’anima ricorre a una metafora per indicare la triste situazione di schiavitù in cui essa giace; così reputa sorte fortunata quella di chi riesce a liberarsene senza che nessuno dei carcerieri glielo impedisca. Difatti, dopo il peccato originale, l’anima è veramente come prigioniera in questo corpo mortale, soggetta alla passione e agli appetiti naturali. Essa considera sorte fortunata l’essersi liberata dal loro dominio senza esser veduta, cioè senza che passione o appetito alcuno glielo abbia impedito o l’abbia trattenuta.
2. A questo scopo le è giovato entrare nella notte oscura, cioè privarsi di tutti i gusti e mortificare tutti i suoi appetiti, come ho detto. Quando aggiunge: stando la mia casa al sonno abbandonata, vuol dire che la casa, cioè la parte sensitiva, sede di tutte le passioni, è tutta addormentata, perché le ha vinte e tenute a freno. Ma fino a quando le passioni non sono assopite per mezzo della mortificazione della sensibilità, e la stessa sensibilità non è lasciata in pace da quelle, in modo da non fare alcuna guerra allo spirito, l’anima non può giungere alla vera libertà né godere l’uno del bene amato.
Seconda strofa
Al buio e più sicura,
per la segreta scala, travestita,
oh, sorte fortunata!,
al buio e ben celata,
stando la mia casa al sonno abbandonata.
1. In questa seconda strofa l’anima canta la sorte fortunata che le è toccata nel liberare lo spirito da ogni imperfezione e da ogni brama di appropriarsi dei beni spirituali. La sua sorte è stata tanto più felice in quanto ha incontrato maggiori difficoltà per addormentare la casa nella parte spirituale ed entrare in questa oscurità interiore, che è privazione spirituale di ogni cosa, tanto sensitiva che immateriale, appoggiandosi solo alla pura fede e per mezzo di essa salire fino a Dio. La fede viene qui chiamata segreta scala, perché tutti i suoi gradini o articoli di fede che essa contiene sono segreti e nascosti tanto ai sensi quanto all’intelletto. L’anima, dunque, all’oscuro di ogni luce naturale dei sensi e dell’intelletto, oltrepassa i limiti della sua natura e ragione per salire questa divina scala della fede; attraverso questa giunge a penetrare fin nelle profondità di Dio. L’anima dice che procedeva travestita, perché, salendo per mezzo della fede, il suo costume, la veste e il portamento umano si erano cambiati in divino travestimento. Tale trasformazione le consentiva di non essere riconosciuta né trattenuta dalle realtà temporali né da quelle della ragione e nemmeno dal demonio, poiché nulla di tutto questo può danneggiare chi cammina nella fede. Ma c’è di più. L’anima è talmente protetta, nascosta e al sicuro da tutti gli inganni del demonio da poter camminare veramente – come dice in questo verso – al buio e ben celata, cioè senza essere vista dal demonio, per il quale la luce della fede è densa tenebra. Possiamo, dunque, affermare che l’anima che procede alla luce della fede avanza al riparo e nascosta agli occhi del demonio, come si vedrà più chiaramente in seguito.
2. Essa afferma, perciò, di essere uscita al buio e più sicura. Chi ha la fortuna di poter camminare tra le oscurità della fede e, come un cieco, assume questa per guida, si libera da tutte le rappresentazioni naturali e dai ragionamenti spirituali, procedendo molto sicuro, come già ho detto. L’anima aggiunge che entrò in questa notte dello spirito, stando la sua casa al sonno abbandonata. Ciò vuol dire che quando l’anima giunge all’unione con Dio, ha messo a tacere la sua parte spirituale e razionale: le sue potenze naturali sono inattive, sopiti gli impeti e le ansie dei sensi nella parte spirituale. Per questo motivo, qui non dice che uscì con ansie, come nella prima notte dei sensi, perché, per entrare in essa e spogliarsi di ciò che appartiene ai sensi, occorreva che avesse sperimentato ansie di amore sensibile per poterne uscire; invece, per placare definitivamente la casa dello spirito, si richiede di consolidare nella pura fede le sue potenze, le sue attrattive e tutti gli appetiti spirituali. Fatto questo, l’anima si unisce all’Amato in un’unione piena di semplicità, purezza, amore e somiglianza.
3. Occorre notare che nella prima strofa, parlando della parte sensitiva, l’anima dice che uscì in una notte oscura: mentre qui, ove si tratta della parte spirituale, afferma che uscì al buio, perché le tenebre dello spirito sono più dense, proprio come il buio è tenebra più profonda dell’oscurità della notte. Difatti, per quanto fonda possa essere una notte, tuttavia si scorge qualcosa, mentre al buio non si vede nulla. Così nella notte dei sensi c’è ancora qualche luce, perché operano, senza essere accecati, l’intelletto e la ragione. Nella notte dello spirito, ossia nella fede, invece, vi è totale privazione di luce sia nell’intelletto che nei sensi. Per questo motivo l’anima afferma che camminava al buio e più sicura, cosa che non faceva nell’altra notte. Quanto meno essa si affida alle sue capacità naturali, tanto più avanza sicura, perché procede nella fede. Ciò è quanto verrà esposto diffusamente in questo libro II. Sarà, perciò, necessario che il devoto lettore ponga attenzione, perché in esso dirò cose molto importanti circa il vero spirito. E sebbene queste verità presentino qualche difficoltà a essere comprese, tuttavia esse sono collegate così bene tra loro che la conoscenza di una parte apre alla comprensione delle altre, in modo che si possa capire tutto molto bene.
CAPITOLO 2
Ove si comincia a parlare della seconda parte o causa della notte, che è la fede. Con due argomenti si prova che questa è più oscura della prima e della terza
1. Ora è il momento di trattare della seconda parte di questa notte, cioè della fede. Questa è, come ho detto, il meraviglioso mezzo per arrivare al fine che è Dio, che, a sua volta, costituisce per l’anima la terza causa o parte di questa notte. La fede, infatti, in quanto mezzo, può essere paragonata alla mezzanotte. Si può allora dire che per l’anima questa parte della notte è più oscura della prima e, in un certo senso, della terza. La prima, infatti, cioè la notte dei sensi, è paragonata alla prima parte della notte, quando scompaiono dalla vista tutti gli oggetti materiali, senza però che la luce scompaia del tutto, come accade invece a mezzanotte. La terza parte, che corrisponde all’aurora, quando ormai si è prossimi alla luce del giorno, non è così oscura come la mezzanotte, perché precede immediatamente l’irradiazione e lo splendore della luce diurna ed è paragonata a Dio. Infatti, da un punto di vista naturale, è pur vero che Dio per l’anima è come una notte oscura quanto la fede. Tuttavia, allorché l’anima ha attraversato queste tre parti naturali della notte, Dio comincia a illuminarla soprannaturalmente con i raggi della sua luce. È l’inizio dell’unione perfetta che si realizza al termine della terza notte, ragion per cui si può dire che questa sia meno oscura delle altre.
2. La notte della fede è ancora più oscura della prima, perché, mentre questa riguarda la parte inferiore, cioè i sensi dell’uomo, e per conseguenza è più esterna, quella della fede riguarda la parte superiore o razionale dell’uomo. Questa è, quindi, più interiore e più oscura, perché priva l’anima della luce della ragione o, per meglio dire, l’acceca. A buon diritto, perciò, è paragonata alla mezzanotte, che è la parte culminante e più buia della notte.
3. Ora devo provare come questa seconda parte, cioè la fede, sia una notte per lo spirito, come la prima lo è per i sensi. Parlerò, poi, degli ostacoli che la fede incontra e come l’anima debba disporsi attivamente per entrare in essa. Del suo aspetto passivo, cioè di quanto Dio faccia per introdurla in questa notte, senza il concorso dell’anima, tratterò a suo luogo, cioè nel libro terzo.
CAPITOLO 3
Ove si dimostra con argomenti, autorità e figure della sacra Scrittura come la fede sia una notte oscura per l’anima.
1. I teologi affermano che la fede è un abito certo e oscuro dell’anima. È abito oscuro perché induce a credere verità rivelate da Dio stesso, che sono al di sopra di ogni luce naturale e superano oltre misura ogni umana comprensione. Ne consegue che la luce eccessiva della fede è per l’anima profonda oscurità, perché il più assorbe e vince il meno, come la luce del sole eclissa qualsiasi altra luce, al punto che questa scompare quando quella risplende vincendo la nostra potenza visiva. In tal modo questa rimane piuttosto accecata e priva della vista, perché la luce che riceve è sproporzionata ed eccessiva. Allo stesso modo la luce della fede, per sua natura ha come oggetto solo la scienza naturale. Tuttavia l’anima è in grado di accogliere quella soprannaturale, qualora il Signore voglia elevarla a tale ordine.
2. Ne consegue che l’intelletto, di per sé, può conoscere solo per via naturale, cioè solo ciò che raggiunge attraverso i sensi. Ma a tale scopo esso ha bisogno dei fantasmi e delle immagini offertigli dagli oggetti realmente presenti o che a loro somigliano. Senza questa mediazione non vi è conoscenza alcuna, perché, come dicono i filosofi, ab obiecto et potentia paritur notitia, cioè ogni cognizione umana nasce con il concorso dell’oggetto presente e delle potenze. Per esempio, se a uno dicessero che in una certa isola esiste un animale che egli non ha mai visto e non gli indicano qualche somiglianza di quell’animale con un altro da lui conosciuto, sebbene s’insista a parlargliene, non ne avrà un’idea più chiara di prima. Con un esempio ancor più chiaro si potrà capire meglio. Se a un cieco nato, che non ha mai visto alcun colore, si volesse descrivergli il bianco o il giallo, per quanto si insista, egli non se ne potrà mai fare un’idea, perché non ha mai visto quei colori né qualcosa di simile; gliene rimarrà solo il nome, che ha potuto sentire con l’udito, ma non la forma e la figura, che non ha mai visto.
3. Lo stesso è della fede per l’anima: essa ci propone cose che non abbiamo mai visto né compreso sia in se stesse che in altre cose simili a loro, perché non esistono. Di tale fede, quindi, non possiamo farci un’idea attraverso la nostra scienza naturale, perché ciò che ci propone non è proporzionato a nessuna potenza sensitiva. Noi lo apprendiamo solo per sentito dire, credendo ciò che la fede c’insegna, sottomettendo ad essa e mettendo da parte la nostra luce naturale. Difatti san Paolo afferma: Fides ex auditu: La fede dipende dall’udire la predicazione (Rm 10,17), quasi a voler dire che la fede non è una scienza che si ottiene tramite i sensi, ma è solo assenso dell’anima a ciò che essa percepisce attraverso l’udito.
4. La fede, inoltre, supera di molto quanto ci possono far capire i precedenti esempi. Infatti non solo non offre conoscenze e scienza, ma, come ho detto, oscura e priva l’anima di qualsiasi altra conoscenza e scienza, perché si possa ben calcolare la sua funzione in questa parte della notte. Le altre scienze, infatti, si acquistano con la luce dell’intelletto, senza la quale, invece, si acquista la luce della fede; quando, anziché rinnegare la ragione, la si adopera, la fede viene meno. Per questo Isaia dice: Si non credideritis, non intelligetis, cioè: Se non crederete, non comprenderete (Is 7,9). È, dunque, chiaro che la fede è notte oscura per l’anima, e solo così la illumina; quanto più l’ottenebra, tanto più luce le comunica, perché, accecandola, le dà luce, come dice Isaia: Perché, se non crederete, non comprenderete, cioè non avrete luce. Per questo motivo, la fede è raffigurata da quella nube che divideva i figli d’Israele dagli egiziani, al momento di entrare nel Mar Rosso. Di essa la sacra Scrittura dice che erat nubes tenebrosa et illuminans noctem (Es 14,20), per significare che quella nube era tenebrosa e illuminava la notte.
5. Stupisce che quella nube, pur essendo tenebrosa, illuminasse la notte. Questo perché la fede, che è nube oscura per l’anima – che a sua volta è notte, perché in presenza della fede rimane priva e cieca della sua luce naturale –, con le sue tenebre rischiara e dà luce alle tenebre dell’anima. Del resto è opportuno che il discepolo, cioè l’anima, sia simile al maestro, cioè alla fede. L’uomo immerso nelle tenebre non può essere giustamente illuminato che da alte tenebre, come ci insegna Davide, quando afferma: Dies diei eructat verbum et nox nocti indicat scientiam, cioè: Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia (Sal 18,3). In termini più chiari ciò vuol dire: il giorno, che è Dio nella sua beatitudine, ove è come il giorno per gli angeli e i santi che a loro volta sono giorno per i riflessi divini, pronuncia e comunica la Parola, il suo Figlio, perché lo conoscano e lo godano. La notte, che è la fede nella Chiesa militante, dov’è ancora notte, comunica la scienza alla Chiesa, quindi a ogni anima, che è notte, perché non gode della chiara sapienza beatifica, come pure della sua luce naturale a motivo della fede in essa presente.
6. Da ciò dobbiamo concludere che la fede, essendo notte oscura, dà luce all’anima, che vive al buio, perché si realizzi ciò che Davide dice a questo proposito: Nox illuminatio mea in deliciis meis, cioè: La notte è chiara come il giorno nelle mie delizie (Sal 138,11). Il che equivale a dire: nelle gioie della mia pura contemplazione e unione con Dio, la notte della fede sarà la mia guida. Con ciò egli fa capire chiaramente che l’anima deve tenersi nelle tenebre se vuole avere la luce necessaria per intraprendere questo cammino di unione con Dio.
CAPITOLO 4
Ove si dice, in maniera generale, come l’anima, per quanto dipende da essa, debba starsene al buio per essere ben guidata dalla fede sino ai vertici della contemplazione.
1. Credo, ormai, di aver fatto capire un po’ come la fede sia notte oscura per l’anima e, altresì, come questa debba rimanere all’oscuro della sua luce naturale per lasciarsi guidare dalla fede alla sublime meta dell’unione divina. Ma perché l’anima possa riuscire in questo, occorre adesso spiegare più dettagliatamente questa oscurità da cui essa deve lasciarsi avvolgere per accedere a questo abisso di fede. Per tale motivo, nel presente capitolo, parlerò in generale di detta virtù e più avanti, a Dio piacendo, indicherò più in particolare il modo da seguire per non smarrirsi in essa né ostacolarne la guida.
2. Affermo, quindi, che per farsi guidare in modo sicuro dalla fede verso questo stato di contemplazione l’anima non solo deve restare al buio nella sua parte sensitiva e inferiore, riguardante le cose create e quelle temporali, di cui ho già trattato, ma deve farsi cieca e porsi al buio anche nella sua parte razionale e superiore, quella riguardante Dio e le cose dello spirito, di cui ora parlerò. Per giungere alla trasformazione soprannaturale, è chiaro che l’anima debba mettersi al buio e trascendere tutto ciò che concerne la sua natura, tanto sensitiva che razionale. Soprannaturale, infatti, vuol significare proprio ciò che è sopra il naturale; di conseguenza, ciò che è naturale resta al di sotto. Ora, poiché la trasformazione e l’unione non dipendono né dai sensi né dall’abilità umana, l’anima deve, per quanto le è possibile, svuotarsi completamente e volontariamente di tutto ciò che dipende da lei, sia nella parte superiore che inferiore, cioè secondo l’affetto e la volontà. E allora chi potrà mai proibire a Dio di fare ciò che vuole in quest’anima docile, spogliata di tutto e nuda? Essa, però, deve svuotarsi di tutto ciò che può dipendere dalla sua abilità, in modo che, sebbene riceva molti doni soprannaturali, ne rimanga sempre distaccata e come ignara nei loro confronti, al pari di un cieco, aggrappandosi alla fede oscura, prendendola per guida e luce, senza appoggiarsi a cose che comprende, gusta, sente e immagina. Tutto questo, infatti, è tenebra che la fa sbagliare, mentre la fede è al di sopra di questo comprendere, gustare, sentire e immaginare. Se l’anima, dunque, non si fa cieca riguardo a tali cose, rimanendo completamente al buio, non arriverà mai a ciò che è superiore, cioè a quello che insegna la fede.
3. Chi non è cieco del tutto, non si lascia condurre volentieri dalla sua guida, ma, per quel poco che vede, ritiene sia meglio seguire la strada che intravede appena, perché non ne scorge altre migliori; in tal modo potrebbe far sbagliare anche la sua guida che vede meglio di lui, perché, in fondo, comanda più lui che il suo accompagnatore. Così pure accade all’anima. Se si avvale di qualche sua conoscenza, di qualche suo gusto o sentimento di Dio, per quanto ottime mediazioni, sono sempre poca cosa e impari all’Essere divino; si sbaglia facilmente nel seguire tale cammino o si arresta, perché non vuole affidarsi, completamente cieca, alla fede che è la sua vera guida.
4. La sacra Scrittura ci vuole dire proprio questo quando afferma: Accedentem ad Deum oportet credere quod est, cioè: Chi si accosta a Dio deve credere che egli esiste (Eb 11,6). In altri termini, chi vuole arrivare all’unione con Dio non deve appoggiarsi sulla propria conoscenza umana, né attaccarsi ai gusti, ai sensi, all’immaginazione, ma credere che Dio esiste, verità questa che non può essere afferrata né dall’intelletto né dagli appetiti né dall’immaginazione né da qualunque altra sensazione. Dio non può essere conosciuto, in questa vita, così com’è. Anzi, in questa vita il massimo che si possa percepire e gustare, ecc., di Dio, è infinitamente distante dalla sua realtà e dal suo puro possesso. Isaia e san Paolo dicono: Nec oculus vidit, nec auris audivit, neque in cor hominis ascendit, quae preparavit Deus iis qui diligunt illum: Quelle cose che occhio non vide né orecchio udì né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano (1Cor 2,9; cfr. Is 64,3). Come può l’anima pretendere di unirsi per grazia perfettamente in questa vita a Colui con il quale sarà unita per gloria nell’altra, realtà, questa, che, come dice san Paolo, occhio non vide né orecchio udì né entrò in cuore di uomo? È chiaro che per giungere in questa vita a unirsi a Dio per mezzo della grazia e di un amore perfetto, l’anima dev’essere all’oscuro di tutto quanto può passare attraverso l’occhio, di tutto ciò che può ricevere tramite l’orecchio e può essere immaginato con la fantasia e compreso con il cuore, che in questo caso significa l’anima. Colui che è in cammino verso questo stato eccelso di unione con Dio, si crea gravi ostacoli ogni volta che si attacca a qualche suo pensiero, sensazione o immaginazione, al suo parere o alla sua volontà, al suo modo di agire o a qualsiasi altra cosa od opera propria, non riuscendo a distaccarsene e a privarsene del tutto. Come ho già detto, la meta a cui tende sorpassa tutte queste mediazioni, quantunque esse siano il meglio di quanto si possa sapere o gustare: rinunciando a tali mediazioni, egli deve cercare di non sapere nulla.
5. Pertanto, in questo cammino di unione, iniziare a camminare significa lasciare la propria via o, meglio, passare oltre; lasciare il proprio modo di agire significa entrare in ciò che non ha un modo, cioè in Dio. Difatti l’anima che perviene a tale unione non ha più modi o maniere personali, né tanto meno si attacca o può attaccarsi ad essi; intendo dire modi di capire, di gustare, di sentire. Pur possedendoli tutti in sé, agisce come chi non ha nulla e possiede tutto. Avendo avuto il coraggio di oltrepassare, interiormente ed esteriormente, i limiti della propria natura, entra nei confini del soprannaturale che non ha alcun modo, poiché nella sostanza li racchiude tutti. Ne segue che, per giungere a questo stato, occorre uscire dalla propria condizione e, in ogni caso, allontanarsi molto da se stessi, da tanta bassezza per tendere verso l’assoluta altezza.
6. Andando oltre tutto ciò che può conoscere o intendere, sia spiritualmente che naturalmente, l’anima deve desiderare con tutte le sue forze di giungere a ciò che in questa vita non può conoscere né può gustare nel suo cuore. Lasciando, inoltre, dietro di sé tutto ciò che gusta, sente e può gustare e sentire in questa vita attraverso i sensi e lo spirito, deve desiderare con tutte le forze di raggiungere ciò che sorpassa ogni sentimento e ogni gusto. Per restare libera e vuota in vista di tale scopo, l’anima non deve assolutamente contare su ciò che può accogliere nella sua parte spirituale o sensitiva, come dirò presto quando spiegherò questo punto in particolare. Infatti, quanto più pensa a ciò che essa comprende, gusta e immagina, quanto più dà valore a tutto ciò, spirituale o meno, tanto minore stima pone nel Bene supremo e stenta a raggiungerlo. Al contrario, meno valore dà a ciò che può avere, per quanto possa essere considerevole, rispetto al sommo Bene, tanto più esalta e stima quest’ultimo e, di conseguenza, tanto più si avvicina ad esso. In questo modo, al buio, l’anima si avvicina a grandi passi all’unione divina per mezzo della fede. Pur essendo oscura anche quest’ultima, tuttavia le offre una luce meravigliosa. Se, però, l’anima volesse vedere Dio, rimarrebbe abbagliata davanti a lui molto più in fretta di chi spalanca gli occhi per vedere lo splendore del sole.
7. In questo cammino, quindi, l’anima vedrà la luce solo se accecherà le sue potenze, come il Signore afferma nel vangelo: In iudicium veni in hunc mundum: ut qui non vident, videant, et qui vident, caeci fiant, cioè: Sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi (Gv 9,39). Sono parole, queste, che, così come suonano, devono essere applicate al cammino spirituale. Insomma, occorre sapere che se l’anima si terrà nelle tenebre e farà a meno di tutte le luci proprie e naturali, vedrà in un modo soprannaturale; mentre quella che vorrà appoggiarsi su qualche luce personale, diventerà sempre più cieca e si attarderà nel cammino dell’unione.
8. Per procedere meno confusamente mi sembra necessario spiegare nel capitolo seguente che cosa sia quella che chiamiamo unione dell’anima con Dio. Una volta compresa questa, infatti, si farà molta luce su ciò che dirò in seguito. Credo, quindi, sia arrivato il momento di trattarne qui. Tale digressione non sarà inutile, perché, anche se si dovrà interrompere il filo del discorso, mediante ciò, a questo punto, farò luce proprio su questo argomento. Il capitolo che segue sarà, dunque, come una parentesi, posta dentro uno stesso sillogismo retorico, perché subito dopo parlerò, in particolare, delle tre potenze dell’anima e delle rispettive virtù teologali nell’ambito di questa seconda notte.
CAPITOLO 5
Ove si spiega con un paragone in che cosa consiste l’unione dell’anima con Dio.
1. Da quanto è stato detto si può in qualche modo arguire che cosa s’intende qui per unione dell’anima con Dio; è possibile, così, comprendere meglio ciò che ora esporrò. Non è mia intenzione trattare delle sue distinzioni né delle sue parti, perché non finirei più se mi mettessi a spiegare che cosa sia l’unione dell’intelletto, quella della volontà o quella della memoria, o ancora che cosa sia l’unione transeunte o quella permanente di suddette facoltà o di tutte e tre prese insieme. Ne parlerò nel corso della trattazione, quando si presenterà l’occasione, perché ora non aiuterebbe a capire ciò che occorre dire di esse, mentre lo capiremo molto meglio a suo luogo, allorché, trattando questo argomento, avremo sotto mano l’esempio vivo insieme alla presente teoria; allora si potrà esaminare e comprendere meglio ogni cosa e se ne potrà meglio giudicare.
2. Ora voglio solo parlare dell’unione totale e permanente dell’anima, secondo la sua sostanza e le sue potenze, immerse nell’oscurità abituale di tale unione. In seguito, con l’aiuto di Dio, dirò che l’atto non può determinare un’unione permanente delle potenze in questa vita, ma solo transeunte.
3. Per comprendere, dunque, bene la natura dell’unione di cui sto parlando, occorre sapere che Dio dimora ed è presente sostanzialmente in qualsiasi anima, anche in quella del peggior peccatore del mondo. Questa sorta di unione tra Dio e tutte le creature sussiste sempre; per mezzo di essa, egli le sostiene nella loro esistenza; se la sua presenza negli esseri creati venisse meno, essi cadrebbero nel nulla e cesserebbero di esistere. Quando, perciò, parlo di unione dell’anima con Dio, non mi riferisco a quella sostanziale, che vige sempre, ma all’unione e trasformazione dell’anima in Dio, che si verifica solo quando viene a crearsi somiglianza d’amore. Questa, perciò, si può chiamare unione di somiglianza, l’altra, invece, unione essenziale o sostanziale: questa è naturale, quella soprannaturale e ha luogo quando le due volontà, quella dell’anima e quella di Dio, sono d’accordo tra loro, senza che nulla dell’una ripugni all’altra. Quando, dunque, l’anima cancella in sé tutto ciò che ripugna o non è conforme alla volontà divina, allora è trasformata in Dio per amore.
4. Tale spogliamento si riferisce non solo agli atti che ripugnano a Dio, ma anche alle abitudini. Così l’anima deve respingere non solo gli atti volontari imperfetti, ma deve annullare qualsiasi abitudine che ha relazione con essi. Poiché ogni cosa creata, azione e capacità umana non può raggiungere né avvicinarsi a ciò che è Dio, l’anima deve spogliarsi di ogni cosa creata, azione e capacità, cioè del suo modo di comprendere, di gustare e di sentire. Solo così, eliminato tutto ciò che non somiglia o non è conforme a Dio, non restandole altro che la sua volontà, essa può raggiungere la somiglianza con lui e la trasformazione in lui. Sebbene sia vero, come ho detto, che Dio è sempre nell’anima per darle e conservarle l’essere naturale con la sua presenza, tuttavia non sempre le comunica l’essere soprannaturale. Questo viene partecipato solo per amore e per grazia, che non tutte le anime possiedono in ugual misura; alcune hanno un grado maggiore di amore, altre un grado inferiore. Per questo, Dio si comunica maggiormente all’anima più avanti nell’amore, cioè quella che ha la volontà più conforme alla sua volontà. L’anima, la cui volontà è pienamente conforme e simile a quella di Dio, è completamente unita a lui e soprannaturalmente in lui trasformata. Da quanto è stato detto risulta che, quanto più un’anima è sedotta, affettivamente e abitualmente, dalle creature e dalle proprie capacità, tanto meno è disposta a tale unione, perché non offre totalmente a Dio la possibilità di trasformarla soprannaturalmente. L’anima, quindi, non deve fare altro che spogliarsi di quanto è opposto e dissimile, sul piano naturale, a Dio, perché questi, che le si è già comunicato naturalmente per mezzo della natura, le si conceda soprannaturalmente per grazia.
5. Questo è quanto ha voluto farci comprendere san Giovanni quando ha detto: Qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt (Gv 1,13). È come se volesse dire: ha dato potere di diventare figli di Dio, cioè di trasformarsi in lui, solo a coloro che non sono nati dal sangue, cioè dall’unione e composizione di elementi naturali, e neppure dalla volontà della carne, cioè dall’arbitrio dell’abilità e della capacità naturale, né tanto meno dalla volontà dell’uomo. Simili espressioni alludono a tutti i modi umani di giudicare e di comprendere con la ragione. A nessuno di costoro, dunque, ha dato potere di diventare figli di Dio, ma solo a quelli che sono nati da lui, cioè a coloro che, morti a tutto ciò che è uomo vecchio e rinati, quindi, nella grazia, si elevano al di sopra di se stessi sino al soprannaturale, ricevendo da Dio tale rinascita e filiazione, superiore a tutto ciò che si possa immaginare. Per questo motivo, altrove lo stesso san Giovanni afferma: Nisi quis renatus fuerit ex aqua, et Spiritu Sancto, non potest videre regnum Dei, cioè: Se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio (Gv 3,5), che è lo stato di perfezione. Rinascere nello Spirito Santo in questa vita significa avere un’anima molto simile a Dio per purezza, senza avere in sé alcuna mescolanza d’imperfezione. Solo così può realizzarsi una pura trasformazione dell’anima in Dio per partecipazione d’unione, anche se ciò non avviene sul piano dell’essenza.
6. Per poter comprendere meglio questa verità, ricorro a un paragone. Un raggio di sole batte su una vetrata; se questa ha delle macchie o è appannata, il sole non può illuminarla e trasformarla totalmente nella sua luce, come accadrebbe, invece, se fosse nitida e senza tutte quelle macchie. Anzi, tanto meno la illuminerà quanto meno sarà smacchiata e pulita, e, viceversa, quanto più sarà tersa tanta maggior luce riceverà. Ciò si verifica non per colpa del raggio, ma della vetrata stessa. Se, infatti, questa fosse completamente limpida e tersa, il raggio la trasformerebbe e la illuminerebbe a tal punto da essere identificata con il raggio stesso e da riflettere la sua stessa luce. In tal caso, però, pur essendo la vetrata identificata con il raggio, conserva sempre la sua natura distinta da esso; potremmo, però, dire che essa è raggio o luce per partecipazione. L’anima è come questa vetrata che è sempre investita dalla luce dell’essere divino, o meglio tale luce dimora sempre in essa per natura, come ho detto.
7. Quando l’anima fa spazio, cioè elimina in sé ogni ombra e macchia di cosa creata, tenendo la volontà perfettamente unita a quella di Dio – perché amare vuol dire cercare di spogliarsi e privarsi per Dio di tutto ciò che non è lui –, viene immediatamente illuminata e trasformata in Dio. Questi, allora, le comunica il suo essere soprannaturale, in modo che quella sembra Dio stesso e possiede ciò che possiede Dio. L’unione che s’instaura, quando Dio concede all’anima tale grazia soprannaturale, produce una trasformazione partecipativa tale che tutte le cose di Dio e l’anima costituiscono una sola cosa. L’anima assomiglia più a Dio che a se stessa, addirittura è Dio per partecipazione. È pur vero, però, che il suo essere, anche se trasformato, resta per natura distinto da Dio come prima; proprio come la vetrata che, pur essendo illuminata dal raggio di sole, ne rimane pur sempre distinta.
8. Da ciò risulta più chiaro che i mezzi a disposizione dell’anima per arrivare a tale unione, come si diceva prima, non consistono nel capire, nel gustare, nel sentire, nell’immaginare Dio, né in qualsiasi altra attività umana, ma nella purezza e nell’amore, cioè nello spogliamento e nella rinuncia assoluta a tutto per amore di Dio. Ora, poiché non si può dare trasformazione perfetta se non vi è perfetta purezza, l’illuminazione e l’unione dell’anima con Dio saranno più o meno intense e proporzionate alla purezza dell’anima. Tale unione, ripeto, non sarà perfetta fintanto che l’anima non sarà del tutto perfetta, pura e limpida.
9. Il paragone seguente ci aiuterà a capire quanto ho detto. Pensiamo a un’immagine ben rifinita, dai numerosi e sublimi pregi e dai delicati e fini smalti, alcuni dei quali si possono appena distinguere per la loro delicatezza e perfezione. Ora, chi ha una vista poco chiara e imperfetta riuscirà a scorgere solo qualcosa dell’arte e della finezza di quell’immagine; chi, invece, ha una vista migliore vi scoprirà maggiori perfezioni; chi, infine, ha una vista molto acuta vi vedrà bellezze e perfezioni più degli altri. Nell’immagine, infatti, vi è tanto da vedere che, malgrado tutto quello che si è potuto ammirare, più si ammira, più resta da ammirare.
10. Possiamo dire che le anime si comportano con Dio allo stesso modo, quando vengono da lui illuminate e trasformate. Se è vero che ogni anima, a seconda della sua poca o molta capacità, può giungere a quest’unione, non tutte però vi pervengono con lo stesso grado d’intensità, perché ciò dipende dalla volontà del Signore. Accade loro come ai santi in cielo: alcuni contemplano più e altri meno, ma tutti vedono Dio e sono contenti, perché tutta la loro capacità ricettiva è appagata.
11. Da ciò risulta altresì che, quantunque in questa vita vi siano anime che nello stato di perfezione godono uguale pace e tranquillità e ognuna di esse è soddisfatta, tuttavia alcune possono essere molto più elevate di altre, ma tutte sono totalmente contente, in quanto tutta la loro capacità è soddisfatta. Ma l’anima che non raggiunge una purezza proporzionata alle sue capacità, non conseguirà mai la vera pace e soddisfazione, perché non ha operato quello spogliamento e quel vuoto nelle sue potenze, necessari per l’unione semplice con Dio.
CAPITOLO 6
Ove si spiega come le tre virtù teologali abbiano il compito di perfezionare le tre potenze dell’anima, producendo in esse il vuoto e le tenebre.
1. Esporrò ora il modo d’introdurre le tre potenze dell’anima, cioè l’intelletto, la memoria e la volontà, in questa notte dello spirito, che conduce all’unione con Dio. Per prima cosa è necessario spiegare, in questo capitolo, come le tre virtù teologali, fede, speranza e carità, che sono propriamente gli oggetti soprannaturali di dette potenze, mediante le quali l’anima si unisce a Dio, creano, ognuna nella rispettiva potenza, lo stesso vuoto e la stessa oscurità: la fede nell’intelletto, la speranza nella memoria e la carità nella volontà. In seguito si vedrà come l’intelletto debba perfezionarsi nelle tenebre della fede, la memoria nel vuoto della speranza e come la volontà si debba fortificare nell’assenza e nello spogliamento di ogni affetto per unirsi a Dio. Detto questo, apparirà chiaro quanto bisogno ha l’anima di percorrere sicura questo cammino spirituale, di passare per questa notte oscura, appoggiandosi a queste tre virtù, che la svuotano di tutte le cose e la tengono al buio nei loro confronti. Difatti, come ho già detto, l’anima in questa vita non si unisce a Dio per mezzo di ciò che può comprendere, godere o immaginare, né tramite qualsiasi altra sensazione, ma solo mediante la fede, la speranza e la carità in rapporto all’intelletto, alla memoria e alla volontà.
2. Queste tre virtù, ripeto, creano il vuoto nelle potenze: la fede crea il vuoto nell’intelletto, impedendogli di comprendere; la speranza spoglia di ogni possesso la memoria; e la carità opera il vuoto nella volontà per spogliarla di ogni affetto e piacere riguardo a tutto ciò che non è Dio. La fede, già lo sappiamo, ci parla di cose che non possiamo capire con l’intelletto. Di essa così si afferma nella lettera agli Ebrei: Fides est sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium (Eb 11,1). Per quanto riguarda il nostro argomento, queste parole vogliono dire che la fede è sostanza delle cose che si sperano. Sebbene l’intelletto aderisca alle cose sperate con ferma certezza, tuttavia non riesce a comprenderle, perché, se le penetrasse, non vi sarebbe più fede. Questa, infatti, benché dia certezza all’intelletto, non gli offre chiarezza, ma solo oscurità.
3. Quanto alla speranza, non v’è dubbio che essa crei vuoto e oscurità anche nella memoria circa le cose di questa e dell’altra vita. Difatti la speranza ha per oggetto le cose che non si possiedono, perché, se si possedessero, non ci sarebbe più speranza. Per questo san Paolo dice nella lettera ai Romani: Spes, quae videtur, non est spes; nam quod videt quis, quid sperat?: Ciò che si spera, se visto, non è più speranza; infatti ciò che uno già vede o possiede, come potrebbe ancora sperarlo? (Rm 8,24). Anche questa virtù, quindi, crea vuoto, perché ha per oggetto ciò che non si ha, non ciò che si ha.
4. La carità crea, ugualmente, nella volontà il vuoto rispetto a tutte le cose create, perché ci obbliga ad amare Dio più di tutte le cose. Ciò si ottiene distaccando da esse ogni affetto per riporlo unicamente in Dio. In Luca Cristo dice: Qui non renuntiat omnibus quae possidet, non potest meus esse discipulus, che vuol dire: Chi non rinunzia a tutti i suoi averi, con la volontà, non può essere mio discepolo (Lc 14,33). È così che tutt’e tre queste virtù pongono l’anima nell’oscurità e nel vuoto rispetto a tutte le cose.
5. È bene ricordare a questo punto la parabola del Signore trasmessa nel vangelo di Luca, dove si parla di un uomo che andò da un suo amico a mezzanotte per chiedergli tre pani (Lc 11,5), che rappresentano le tre virtù. Il testo riferisce che l’amico andò a chiedere questi tre pani a mezzanotte. Ciò significa che l’anima, al buio di tutte le cose, ove terrà le sue potenze, dovrà acquisire queste tre virtù e, in questa notte, dovrà perfezionarsi in esse. Nel capitolo 6 di Isaia (v. 2) leggiamo che il profeta vide due serafini ai lati di Dio, ognuno con sei ali, due delle quali coprivano i loro piedi, a significare la cecità e l’annullamento degli affetti della volontà in tutte le cose per amore di Dio; altre due coprivano i loro volti, e significano le tenebre dell’intelletto di fronte a Dio; mentre con le altre due volavano: questo è il volo della speranza verso le cose che non si possiedono, al di sopra di tutto ciò che non si può avere quaggiù e lassù, eccetto Dio.
6. Le tre potenze dell’anima, dunque, devono tendere verso queste tre virtù, in modo che ciascuna di quelle sia informata dalla virtù corrispondente; occorre tenere al buio e spogliare le potenze di tutto ciò che è estraneo a queste tre virtù. Tale è la notte dello spirito, che ho chiamato attiva, perché l’anima fa ciò che le è possibile per entrarvi. Come nella notte dei sensi ho indicato il modo per liberare, secondo l’appetito, le potenze sensitive dai loro oggetti sensibili, perché l’anima possa passare dal suo ambito verso il campo della fede, così in questa notte dello spirito spiegherò, con l’aiuto di Dio, il modo con cui le potenze spirituali si svuotano e si purificano da tutto ciò che non è Dio e si mantengono nell’oscurità di queste tre virtù, che, ripeto, sono il mezzo e la disposizione adeguata perché l’anima possa unirsi a Dio.
7. In tal modo l’anima troverà perfetta sicurezza contro le astuzie del demonio e contro la forza dell’amor proprio e le sue ramificazioni così sottili, da ingannare e ostacolare il cammino delle persone spirituali. In realtà, questa non sanno spogliarsi di ogni bene creato e regolarsi secondo queste tre virtù. Per questo non riescono mai a raggiungere il bene spirituale nella sua sostanza e nella sua purezza, né percorrono quel cammino diritto e breve che potrebbero seguire.
8. Occorre ricordare che ora vorrei rivolgermi specialmente a coloro che hanno cominciato a entrare nello stato di contemplazione, perché per i principianti sarà necessario trattare questo argomento più a lungo, come farò nel libro secondo, con l’aiuto di Dio, quando parlerò delle loro disposizioni.
CAPITOLO 7
Ove si mostra quanto sia angusto il sentiero che porta alla vita eterna e quanto spogli e liberi debbano essere coloro che vogliono percorrerlo. S’incomincia a parlare della notte dell’intelletto.
1. Per trattare ora in modo adeguato dello spogliamento e della purezza delle tre potenze dell’anima sarebbero necessarie una mente e una scienza superiore a quelle che possiedo io, così da far capire alle persone spirituali quanto stretto sia questo cammino che, secondo le parole del Signore, conduce alla vita. Una volta persuase di questa verità, esse non si meraviglieranno del vuoto e della nudità in cui devono lasciare le potenze dell’anima durante questa notte.
2. A tale proposito è opportuno considerare le parole del Signore riportate in san Matteo circa questo cammino: Quam angusta porta, et arcta via est, quae ducit ad vitam, et pauci sunt qui inveniunt eam, cioè: Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita e quanto pochi sono quelli che la trovano! (Mt 7,14). Occorre notare che all’autorità di queste parole si aggiunge l’efficacia intensiva contenuta nella particella quam. È come se il Signore volesse dire: è davvero molto stretta, più di quanto pensiate! Va inoltre osservato come egli in primo luogo affermi che stretta è la porta, il che permette di capire che per entrare in questa porta di Cristo, che è l’inizio del cammino, l’anima deve anzitutto mortificare e spogliare la sua volontà di tutte le cose sensibili e temporali, amando Dio al di sopra di tutto. Questo lavoro si compie nella notte dei sensi, di cui si è già parlato.
3. Subito dopo aggiunge che angusta è la via, cioè quella della perfezione. Con tale espressione vuol far capire che per avanzare nel cammino della perfezione l’anima non solo deve passare attraverso la porta stretta, privandosi dei beni sensibili, ma deve altresì mortificarsi, espropriarsi e sbarazzarsi completamente dei beni spirituali. Ciò che dice della porta stretta va, quindi, riferito alla parte sensitiva della persona, e a quella spirituale o razionale ciò che dice della via angusta. La causa, poi, dell’espressione: Pochi sono quelli che la trovano, va ricercata nel fatto che pochi sanno e vogliono entrare in questa estrema nudità e vuoto dello spirito. Poiché questo sentiero verso il sublime «Monte della perfezione» sale verso l’alto ed è angusto, può essere percorso soltanto da viandanti che non portano pesi aggravanti la parte inferiore, cioè i sensi, né impedimenti che ingombrano quella superiore, cioè lo spirito. Poiché si tratta di un impegno in cui si cerca e si raggiunge solo Dio, Dio solo va cercato e posseduto.
4. Da ciò risulta chiaro che l’anima deve sbarazzarsi non solo di ogni affezione verso le cose create, ma deve altresì essere libera e distaccata dai beni riguardanti il suo spirito. Per istruirci e guidarci in questo cammino il Signore, nel vangelo di san Marco, c’insegna quella mirabile dottrina che è tanto meno praticata dalle persone spirituali quanto più è loro necessaria. Per questo motivo e poiché fa al nostro caso, la riporto tutta, spiegandone il genuino e spirituale significato. Il Signore afferma, dunque, così: Si quis vult me sequi, deneget semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me. Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet eam: qui autem perdiderit animam suam propter me… salvam faciet eam, cioè: Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà (Mc 8,34-35).
5. Oh!, chi potrà far comprendere, praticare e gustare tutta l’importanza di questo consiglio del nostro Salvatore? Egli chiede di rinnegare se stessi, affinché le persone spirituali vedano quanto il modo di comportarsi in tale cammino sia diverso da quello che molte di loro immaginano. Alcune, infatti, pensano che basti una qualsiasi forma di ritiro o di riforma della vita; altre si limitano a esercitarsi in qualche modo nella virtù, nella pratica dell’orazione e della mortificazione, ma senza arrivare allo spogliamento e alla povertà, all’abnegazione e alla purezza spirituale – che sono un tutt’uno – consigliatici qui dal Signore. Si preoccupano, infatti, più di nutrire e ricoprire la loro natura di consolazioni e sentimenti spirituali che di spogliarla e privarla di ogni conforto per amore di Dio. Pensano che basti mortificarla nei piaceri del mondo e non che debba essere annientata e purificata anche nella sua parte spirituale. Avviene dunque che, quando si presenta loro l’opportunità di compiere un atto di virtù solido e perfetto, come l’annullamento di ogni soavità in Dio, la permanenza nell’aridità, nelle avversioni, nelle sofferenze – cose in cui consiste la pura croce spirituale, la nudità e la povertà di spirito del Cristo –, tali persone rifuggono tutto questo come se fosse la morte e vanno solo in cerca di dolcezze e soavità nei rapporti con Dio. Ma questo non è rinnegare se stessi né nudità di spirito, bensì golosità spirituale! Agendo così, esse si rendono nemiche della croce di Cristo (Fil 3,18), perché il vero spirito cerca nel Signore più l’amaro che il dolce, propende più per la sofferenza che per la consolazione, più per la mancanza di ogni bene per amore di Dio che per il possesso, più per le aridità e le afflizioni che per le dolci comunicazioni, sapendo che questo significa seguire Cristo e rinnegare se stessi; il resto, invece, è cercare se stessi in Dio, cosa molto contraria all’amore. Infatti, cercare se stessi in Dio significa ricercare i doni e le consolazioni di Dio, mentre cercare unicamente Dio non è solo voler rinunciare a tutto per amore di Dio, ma essere propensi a scegliere per Cristo quanto di più disgustoso vi possa essere, sia da parte di Dio che del mondo. Questo è amore di Dio.
6. Chi potrà far comprendere fin dove il Signore vuole che arrivi questa rinuncia? Essa dev’essere, certamente, come una morte e un totale annientamento temporale, naturale e spirituale in relazione alla volontà, nella quale si opera ogni rinuncia. Ciò è quanto intende dirci il Signore quando afferma: Chi ama la sua vita la perde (Gv 12,25), cioè: chi vorrà possedere qualcosa o ricercarla e tenerla gelosamente per sé, la perderà. Ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà (Mt 10,39, cioè: chi per amore di Cristo rinuncia a tutto ciò che può desiderare e gustare, scegliendo ciò che più assomiglia alla croce – il Signore stesso nel vangelo di san Giovanni chiama quest’atteggiamento odiare la propria vita (Gv 12,25) –, costui la guadagnerà. Tale è l’insegnamento che il Signore offrì a quei due discepoli che gli chiedevano di sedere alla sua destra e alla sua sinistra. Egli non diede loro alcuna speranza di raggiungere la gloria richiesta, ma offrì il calice, che egli stesso avrebbe bevuto, come la cosa più preziosa e più sicura su questa terra, piuttosto che il godimento (Mt 20,20-22).
7. Bere questo calice significa morire alla propria natura, spogliandola e mortificandola in tutto ciò che riguarda i sensi, come ho detto, e in tutto ciò che riguarda lo spirito, come ora dirò, cioè nel suo modo d’intendere, di gustare e di sentire, perché la persona possa camminare per lo stretto sentiero. Così non solo sarà liberata da ciò che viene dai sensi e dallo spirito, ma, in ciò che riguarda quest’ultimo, essa non inciamperà in nessun ostacolo lungo l’angusto cammino. Qui, infatti, c’è posto solo per l’abnegazione – come lascia intendere il Signore – e per la croce, il bastone cui appoggiarsi, che rende il cammino più facile e agevole. Per questo il Signore afferma nel vangelo di san Matteo: Il mio giogo è dolce e il mio carico leggero (Mt 11,30). Il giogo è la croce che l’uomo deve impegnarsi a portare, il che significa decidersi davvero a voler cercare e sopportare ogni sorta di fatiche per amore di Dio. Solo così troverà in esse grande sollievo e dolcezza nel percorrere questo cammino, privo di tutto, senza volere nulla. Se, invece, pretende di appropriarsi di qualcosa, proveniente da Dio o da altrove, non procede spoglio e distaccato da tutto e, pertanto, non potrà imboccare né percorrere questo stretto sentiero sino alla vetta.
8. Per questo motivo vorrei convincere le persone spirituali circa il fatto che questo cammino che porta a Dio non consiste nella molteplicità delle meditazioni, nei metodi, negli esercizi, nei gusti – sebbene tutto questo sia in qualche modo necessario ai principianti –, ma in una sola cosa indispensabile: nel saper rinnegare davvero se stessi, esteriormente e interiormente, offrendosi alla sofferenza per amore di Cristo e annientandosi in tutto. Esercitandosi in tali cose, si possono acquisire tutti quei beni e di più grandi; se, invece, si trascurano, siccome esse sono compendio e radice delle virtù, ogni altra pia pratica è dispersione inutile, anche se quelle persone abbiano meditazioni e comunicazioni pari a quelle degli angeli. In realtà, si fa progresso solo imitando Cristo, che è la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, come dice egli stesso nel vangelo di Giovanni (Gv 14,6). E altrove: Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo (Gv 10,9). Di conseguenza, non riterrei per buono quello spirito che volesse camminare attraverso dolesse e agiatezze, e rifiutasse d’imitare Cristo.
9. Ho detto che Cristo è la via, e questa via è la morte alla nostra natura sia sensitiva che spirituale. Ora voglio far comprendere come questo avvenga in noi, a imitazione di Cristo nostro modello e nostra luce.
10. In primo luogo è certo che egli morì ai sensi, in modo spirituale, durante la sua vita, e fisicamente, alla fine della sua vita, poiché, come egli stesso afferma, in vita non aveva dove posare il capo (Mt 8,20) né tanto meno lo ebbe in croce.
11. In secondo luogo è certo che Cristo al momento della morte fu annientato anche nell’anima, quando fu lasciato senza conforto e sollievo alcuno, abbandonato dal Padre nella più profonda aridità affettiva. Allora egli sentì il bisogno di gridare: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? (Mt 27,46). Questo fu l’abbandono più desolante, a livello affettivo, da lui provato durante la sua vita. In esso, però, compì l’opera più grande di tutta la sua vita, quella che sorpassa i miracoli e ogni altro evento compiuto sulla terra e in cielo, cioè la riconciliazione del genere umano la sua unione con Dio per mezzo della grazia. Come dico, tutto questo accadde nel tempo e nel momento in cui nostro Signore toccò il massimo dell’annientamento: nella stima degli uomini, che vedendolo morire, anziché apprezzarlo, si burlavano di lui; nella natura, per mezzo della quale si annientò morendo; nel sostegno e nel conforto spirituale del Padre, che in quella circostanza lo abbandonò, affinché pagasse interamente il debito e unisse l’uomo a Dio, lasciandolo annientato e ridotto quasi a nulla. Davide dice di lui: Ad nihilum redactus sum, et nescivi: Ero ridotto un niente e non capivo (Sal 72,22). Comprenda, perciò, l’uomo spirituale il mistero della porta e della via di Cristo per unirsi a Dio e sappia che quanto più per amor suo si annienterà, nelle sue parti sensitiva e spirituale, tanto più si unirà a Dio e più grande sarà la sua opera. Quando si sarà ridotto al nulla, avrà cioè raggiunto l’estrema umiltà, allora realizzerà la sua unione spirituale con Dio, che è lo stato più grande ed elevato al quale si possa pervenire in questa vita. Tale unione non consiste, quindi, nelle gioie, nelle consolazioni o nei sentimenti spirituali, ma in una vera morte di croce, sensitiva e spirituale, cioè esteriore e interiore.
12. Non voglio dilungarmi oltre su questo argomento, anche se non smetterei mai di parlarne, perché vedo che Cristo è assi poco conosciuto da coloro che si considerano amici suoi. Li vediamo, infatti, cercare in lui dolcezze e consolazioni e amare molto se stessi, piuttosto che cercare le sue amarezze e la sua morte, segno di coloro che lo amano molto. Parlo di quelli che si ritengono suoi amici, non degli altri che vivono lontano e separati da lui, grandi letterati, potenti e tutti gli altri che vivono là nel mondo, preoccupati di soddisfare le loro ambizioni e le loro manie di grandezza, perché di costoro posso dire che non conoscono Cristo e che avranno una fine, per quanto buona, molto amara. Non parlo di loro in questo scritto. Di essi si parlerà nel giorno del giudizio, perché costoro soprattutto avevano il dovere di annunciare la parola di Dio, essendo stati da lui posti in alto dinanzi agli uomini per cultura e dignità.
13. Ora, però, parlo all’intelligenza dell’uomo spirituale, soprattutto di colui al quale Dio ha fatto il dono di elevarlo allo stato di contemplazione. Come ho già detto, ora parlo specialmente a queste persone, dicendo come devono indirizzarsi a Dio nella fede, purificando il loro intelletto da ciò che a lui è contrario e mortificandosi, per poter entrare in questo sentiero stretto della contemplazione oscura.
CAPITOLO 8
Ove si dimostra, in maniera generale, che nessuna creatura né alcuna conoscenza accessibile all’intelletto possono servire come mezzo immediato per l’unione con Dio.
1. Prima di parlare della fede, quale mezzo proprio e più adeguato per l’unione con Dio, è opportuno provare che nessuna realtà creata o pensata può servire all’intelletto come mezzo specifico per unirsi a Dio, e che tutto ciò che l’intelletto può raggiungere gli è più d’impedimento che d’aiuto, qualora volesse appoggiarvisi. Ora, in questo capitolo, proverò questa verità in maniera generale e poi in particolare, esaminando tutte le conoscenze che l’intelletto può formarsi con l’aiuto dei sensi esterni e interni, nonché gli inconvenienti e i danni che può subire da tutte queste informazioni esteriori e interiori, se vuole procedere senza l’aiuto della fede, che è l’unico mezzo per l’unione divina.
2. Occorre però ricordare che, secondo un principio filosofico, tutti i mezzi devono essere proporzionati al fine, cioè devono avere una qualche convenienza o somiglianza con esso, in modo da poter raggiungere il fine al quale per loro tramite si tende. Per esempio, se uno vuole andare in una città, deve necessariamente percorrere la strada, che è il mezzo che ad essa unisce e conduce. Così pure, se si vuole appiccare il fuoco al legno, è necessario che il calore, suo mezzo specifico, raggiunga quei determinati gradi che occorrono per rendere progressivamente il legno simile al fuoco. Se, invece, si volesse accendere il legno con un mezzo diverso da quello proprio che è il calore, per esempio con l’aria, o con l’acqua o con la terra, sarebbe impossibile unire il legno al fuoco; come sarebbe ugualmente impossibile arrivare a una città se non si seguisse la strada che porta ad essa. Così è per l’intelletto. Perché possa unirsi a Dio in questa vita, nei limiti del possibile, esso deve necessariamente usare quel mezzo che lo unisce a lui e con lui ha una forte somiglianza.
3. A questo proposito, dobbiamo ricordare che fra tutte le creature superiori e inferiori non ce n’è alcuna che sia mezzo adatto all’unione con Dio o che abbia somiglianza con lui. Difatti, come dicono i teologi, sebbene sia vero che tutte le creature abbiano un certo rapporto con Dio e qualche traccia del suo essere – chi più, chi meno, secondo la loro natura – tuttavia non v’è relazione alcuna o somiglianza essenziale tra esse e Dio, a motivo dell’infinita distanza che intercorre tra il loro essere e quello di Dio. È quindi impossibile che l’intelletto possa unirsi a Dio mediante le creature, sia celesti che terrene, perché non c’è una sufficiente somiglianza. Per tale motivo, parlando delle creature celesti, Davide afferma: Fra gli dei nessuno è come te, Signore (Sal 85,8), chiamando dei gli angeli e i santi. E altrove: O Dio, santa è la tua via; quale dio è grande come il nostro Dio? (Sal 76,14), come a dire: la via per arrivare a te, o Dio, è una via santa, cioè una via di pura fede; per cui, quale dio sarà così grande? Cioè: quale angelo sarà così elevato nel suo essere o quale santo così glorificato da poter essere una via proporzionata e sufficiente per venire a te? Sempre Davide, parlando delle creature terrene e celesti insieme, afferma: Eccelso è il Signore e guarda verso l’umile, ma al superbo volge lo sguardo da lontano (Sal 137,6). Come a dire: essendo eccelso nella sua essenza, scorge che l’essere delle creature della terra è infimo a confronto con il suo; quanto alle cose elevate o creature celesti, le vede e conosce molto distanti dal suo essere. Nessuna delle creature, quindi, può servire all’intelletto come mezzo adeguato per raggiungere Dio.
4. Allo stesso modo, tutto ciò che l’immaginazione può rappresentare e l’intelletto apprendere e capire in questa vita, non è né può essere mezzo immediato per arrivare all’unione con Dio. Dal punto di vista naturale, l’intelletto può raggiungere solo ciò che è contenuto e si presenta sotto le forme e le immagini delle cose che ci vengono attraverso i sensi corporali; ora queste cose, come ho detto, non possono servire da mezzo per l’unione; di conseguenza non ci si può avvalere dell’intelligenza naturale. Parlando, poi, dal punto di vista soprannaturale, per quanto è possibile in questa vita, l’intelletto, secondo la sua potenzialità ordinaria, finché è nel carcere del corpo, non ha né la disposizione né la capacità di avere una conoscenza chiara di Dio, perché tale conoscenza non appartiene alla condizione naturale: o si deve morire o si deve farne a meno. Quando Mosè chiese a Dio questa conoscenza, gli fu risposto che non era possibile: Nessun uomo può vedermi e restare vivo (Es 33,20). E san Giovanni aggiunge: Nessuno ha mai visto Dio né qualcosa di simile a lui (1Gv 4,12; Gv 1,18). Continuano in questa linea Isaia e san Paolo quando affermano: Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo… (1Cor 2,9; cfr. Is 64,3). Questo è il motivo per cui Mosè, come si racconta negli Atti degli Apostoli (7,32), non osò guardare il roveto ardente, dov’era presente Dio. Sapeva, infatti, che il suo intelletto era incapace di contemplare Dio, in maniera adeguata e conformemente a ciò che di lui ascoltava. Di Elia, nostro padre, si dice che sul monte si coprì il volto alla presenza di Dio (1Re 19,13), cioè rese cieco il proprio intelletto. Egli compì quel gesto, perché non osava posare la sua mano tanto vile su una cosa così eccelsa, ben sapendo che qualsiasi cosa avesse meditato e compreso nei particolari, sarebbe stata sempre molto lontana e diversa da Dio.
5. Pertanto nessuna conoscenza o percezione soprannaturale, in questa nostra condizione mortale, può servire come mezzo immediato per la sublime unione d’amore con Dio. Tutto ciò che l’intelletto può comprendere, la volontà gustare e l’immaginazione fabbricare è, ripeto, molto diverso e sproporzionato rispetto a Dio. Ciò è quanto meravigliosamente riferisce Isaia con tutta la sua autorevolezza: A chi potreste paragonare Dio e quale immagine mettergli a confronto? Il fabbro fonde l’idolo, l’orafo lo riveste d’oro e l’argentiere lo copre con lamelle d’argento (Is 40,18-19). Per fabbro qui s’intende l’intelletto, che ha il compito di formare le conoscenze e spogliarle del ferro delle specie e delle immagini. Per orafo qui s’intende la volontà, che ha la capacità di ricevere la figura e la forma dei piaceri, causati dall’oro dell’amore. Per argentiere, incapace – così viene qualificato – di rappresentare Dio con lamelle d’argento, s’intende la memoria unitamente all’immaginazione. Difatti si può giustamente dire che le conoscenze e le fantasie, da entrambe elaborate e forgiate, sono come lamelle d’argento. Tutto ciò sta a significare che né l’intelletto con le sue conoscenze potrà comprendere cose simili a Dio, né la volontà gustare diletti e dolcezze somiglianti a quelle di Dio, né la memoria riprodurre nella fantasia conoscenze e immagini che lo rappresentino. È chiaro, quindi, che nessuna di queste conoscenze può immediatamente indirizzare l’intelletto verso Dio. Per avvicinarsi a lui deve procedere piuttosto con la rinuncia che con il desiderio di capire, tenersi nella cecità e nelle tenebre piuttosto che spalancare gli occhi e fissare il raggio divino.
6. Per questo la contemplazione, che consente all’intelletto di raggiungere la più alta conoscenza di Dio, è chiamata teologia mistica, che vuol dire segreta sapienza di Dio, perché è nascosta allo stesso intelletto che la riceve. San Dionigi la chiama anche raggio di tenebra. Di essa il profeta Baruc ha detto: Non hanno conosciuto la via della sapienza, non si sono ricordati dei suoi sentieri (Bar 3,23). È chiaro, quindi, che l’intelletto deve rendersi cieco riguardo a tutti i sentieri che può intraprendere per unirsi a Dio. Aristotele afferma che l’infinita luce di Dio è fitta tenebra per il nostro intelletto, come il sole lo è per gli occhi del pipistrello. E aggiunge che quanto più le cose di Dio sono eccelse e chiare in sé, tanto più sono ignorate e oscure per noi. Lo stesso afferma l’Apostolo quando scrive: La sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio (1Cor 3,19).
7. A questo punto non finirei mai di citare testi e addurre argomenti per provare diffusamente che fra tutte le cose create e quelle che possono essere raggiunge con l’intelletto non esiste scala per la quale questo possa arrivare alle altezze di Dio. Al contrario, occorre sapere che se l’intelletto vuole servirsi di tutte le cose create, o di alcune di esse, come mezzo immediato per l’unione con Dio, vi troverà non solo un impedimento per salire questo «Monte», ma gli saranno anche occasione di gravi errori e inganni.
CAPITOLO 9
Ove si prova come la fede sia per l’intelletto il mezzo immediato e adeguato che conduce l’anima all’unione divina d’amore. Viene dimostrato con testi e immagini tratti dalla sacra Scrittura.
1. Da quanto detto si deduce che, per disporsi a questa unione divina, l’intelletto deve rimanere libero e purificato da tutto ciò che cade sotto i sensi, spoglio e sgombro da tutto quanto potrebbe conoscere chiaramente, intimamente pacificato, ridotto al silenzio, stabilito nella fede, unico mezzo immediato e adeguato all’unione dell’anima con Dio. È così grande, infatti, la somiglianza tra la fede e Dio, che non c’è differenza tra il vedere Dio qual è e il credere in lui: Dio è infinito, ed essa ce lo propone infinito; Dio è uno e trino, ed essa ce lo propone uno e trino; Dio è tenebra per la nostra intelligenza, e anch’essa è oscurità e tenebra per la nostra intelligenza. La fede è l’unico mezzo attraverso cui Dio si manifesta all’anima nella luce divina che supera ogni intelligenza. E così, quanto più l’anima ha fede, tanto più è unita a Dio. Ciò è quanto intendeva dire l’autore biblico nel passo citato sopra: Chi si accosta a Dio deve credere che egli esiste (Eb 11,6), cioè è necessario che vada a lui camminando nella fede. L’intelletto deve restare nell’oscurità e nelle tenebre, lasciandosi guidare solo dalla fede, perché in queste tenebre Dio si comunica all’intelletto e in esse si nasconde, secondo le parole di Davide: Fosca caligine pose sotto i suoi piedi. Cavalcava un cherubino e volava, si librava sulle ali del vento. Si avvolgeva di tenebre come di velo; acque oscure e dense nubi lo coprivano (Sal 17,10-12).
2. Le espressioni: pose fosca caligine sotto i suoi piedi, si avvolgeva di tenebre e acque oscure e dense nubi lo coprivano vogliono indicare l’oscurità della fede in cui Dio è avvolto. Le altre: cavalcava un cherubino e volava e si librava sulle ali del vento vogliono dire che egli trascende ogni intelletto; i cherubini, infatti, significano gli essere intelligenti o contemplanti. E le ali del vento significano le sottili e acute conoscenze, nonché le cognizioni degli spiriti, sopra tutte le quali si libra il suo essere, che nessuno può raggiungere con le proprie forze.
3. Una figura di questa verità la troviamo nella sacra Scrittura, ove si legge che, quando Salomone ebbe finito di edificare il tempio, Dio vi scese in una nube e lo riempì d’una oscurità tale che i figli d’Israele non potevano vedere nulla. Salomone, allora, si espresse in questi termini: Il Signore ha deciso di abitare nella densa nube (1Re 8,12). Ugualmente in una nube, dove si nascondeva, Dio apparve a Mosè sul monte. Tutte le volte che Dio si manifestava nella sua maestà, appariva in una nube, come vediamo nel libro di Giobbe (38,1 e 40,1), dove si legge che Dio gli parlò di mezzo al turbine. Tutte queste tenebre significano l’oscurità della fede in cui è nascosta la Divinità mentre si comunica all’anima. Una volta avvenuto l’intervento divino, come dice san Paolo, quello che è imperfetto scomparirà (1Cor 13,10): scompariranno, cioè, le tenebre della fede e verrà ciò che è perfetto, ossia la luce di Dio. Di tale verità abbiamo una figura significativa nell’esercito di Gedeone. Tutti i suoi soldati, si dice, avevano le fiaccole in mano, ma non le vedevano, perché le tenevano nascoste dentro brocche vuote. Rotte queste, apparve d’improvviso la luce (Gdc 7,16ss). Così è la fede, simboleggiata da queste brocche. Essa contiene in sé la luce divina, ma nel momento in cui questa virtù cesserà, al termine di questa vita mortale, apparirà subito la gloria e la luce della Divinità in essa racchiusa.
4. È, quindi, chiaro che l’anima, in questa vita, per arrivare a unirsi e intrattenersi immediatamente con Dio, deve necessariamente penetrare in questa tenebra, ove Dio aveva promesso a Salomone di abitare; deve avvicinarsi a quella nube oscura, ove Dio volle rivelare i suoi segreti a Giobbe, e prendere nelle mani le brocche vuote di Gedeone, per poter agire alla luce della fede oscura nell’unione d’amore con Dio. Ben presto, quando si romperanno le brocche di questa vita, unico impedimento alla luce della fede, essa lo potrà vedere faccia a faccia nella gloria.
5. Non mi resta, ora, che parlare, in particolare, delle diverse conoscenze e percezioni che l’intelletto può acquisire, come pure degli ostacoli e dei danni che l’anima può incontrare in questo cammino di fede. Spiegherò altresì come l’anima deve comportarsi in tali conoscenze, provenienti sia dai sensi sia dallo spirito, perché le siano di giovamento e non di danno.
CAPITOLO 10
Ove si illustra la distinzione fra tutte le percezioni e conoscenze che l’intelletto è in grado di avere.
1. Dovendo trattare in particolare dei vantaggi e dei danni che le percezioni e conoscenze dell’intelletto possono recare all’anima nei confronti della fede – mezzo, ripeto, propedeutico all’unione divina – è necessario stabilire qui la distinzione fra tutte le conoscenze, naturali e soprannaturali, che esso può acquisire. In seguito ne tratterò il più brevemente possibile, con ordine e distinzione, in modo da indirizzare l’intelletto verso la notte oscura della fede.
2. Occorre sapere che l’intelletto può ricevere informazioni e conoscenze in due modi: naturale e soprannaturale. Quello naturale comprende tutto ciò che l’intelletto può capire sia attraverso i sensi corporali che da se stesso. Quello soprannaturale comprende tutto ciò che gli viene offerto al di sopra della sua capacità e attitudine naturale.
3. Alcune conoscenze soprannaturali sono corporee, altre spirituali. Quelle corporee sono di due specie: alcune vengono ricevute dall’intelletto attraverso i sensi esterni, altre attraverso i sensi interni, con tutto ciò che l’immaginazione può racchiudere, immaginare o elaborare.
4. Anche le conoscenze spirituali sono di due specie: alcune sono distinte e particolari, un’altra è confusa, oscura e generale. Tra quelle distinte e particolari rientrano quattro generi di conoscenze particolari che vengono comunicate allo spirito-mente senza mediazione di alcun senso corporale; sono le visioni, le rivelazioni, le locuzioni e i sentimenti spirituali. La conoscenza oscura e generale si ha solo nella contemplazione, raggiunta nella fede: è in questa che dobbiamo collocare l’anima, guidandovela attraverso tutte le altre specie di conoscenze, cominciando dalle prime, per dire poi come essa se ne debba liberare.
CAPITOLO 11
Ove si parla dell’impedimento e del danno provenienti dalle conoscenze che l’intelletto può ricevere soprannaturalmente attraverso i sensi corporali esterni, e come l’anima deve comportarsi nei loro confronti
1. Le prime conoscenze, di cui ho parlato nel capitolo precedente, sono quelle che l’intelletto acquisisce per via naturale. Ne ho già trattato nel libro I, dove ho indicato come l’anima debba introdursi nella notte dei sensi. Non ne parlo, dunque, più: bastano gli insegnamenti offerti all’anima allora su questo punto. Nel presente capitolo tratterò, pertanto, solamente delle conoscenze e percezioni che l’intelletto acquisisce soprannaturalmente attraverso i sensi esterni, cioè attraverso la vista, l’udito, l’odorato, il gusto e il tatto. Da tali conoscenze possono e sogliono nascere nelle persone spirituali rappresentazioni e notizie soprannaturali. Così attraverso la vista sogliono presentarsi figure e personaggi dell’altra vita, qualche santo, angeli, diavoli, alcune luci e splendori straordinari. Per mezzo dell’udito si possono ascoltare parole straordinarie, pronunciate dagli stessi personaggi che si vedono o senza vedere chi le pronunci. Per mezzo dell’olfatto si percepiscono, a volte, profumi soavissimi, senza sapere da dove vengano. Anche per mezzo del gusto si possono sperimentare sapori molto squisiti, e ugualmente provare grande piacere per il tatto, tanto che a volte sembra che la carne e le ossa godano e fremano immersi nel piacere. Così è quella che viene chiamata «unzione dello spirito», che da questo si diffonde nelle membra delle anime pure. Questa soavità dei sensi è molto comune nelle persone spirituali, perché procede dai sentimenti e dalla devozione particolare dello spirito, ma è più o meno intensa in ogni anima.
2. Occorre tener presente, però, che, sebbene tutti questi fenomeni possano introdursi nei sensi corporali per intervento di Dio, non si deve mai fare assegnamento su di essi né accoglierli. Occorre, piuttosto, guardarsene categoricamente, senza nemmeno indagare se siano buoni o cattivi. Del resto, quanto più sono esterni e corporali, tanto meno certamente provengono da Dio. Infatti, abitualmente e convenientemente Dio si manifesta più allo spirito, dove c’è maggiore sicurezza e profitto per l’anima, che ai sensi, ove ordinariamente si celano molti pericoli e inganni. In realtà, in queste circostanze il senso si erige a giudice ed estimatore delle cose spirituali, credendo che siano come le percepisce, mentre esse sono tanto diverse quanto lo sono il corpo e l’anima, la sensibilità e la ragione. Il senso corporale ignora le cose dello spirito tanto quanto, e forse più, il giumento le cose razionali.
3. Sbaglia molto chi apprezza questa sorta di favori e corre grave pericolo di essere ingannato o, quanto meno, troverà in sé un forte ostacolo per accedere al piano dello spirito. Infatti, ripeto, tutti questi favori corporali non hanno alcun rapporto con le cose dello spirito. Per questo motivo occorre sempre ritenere che essi provengano dal demonio piuttosto che da Dio. Il demonio ha più mano libera sulla parte esteriore e corporale e gli è più facile ingannare su questo punto, che non riguardo alla parte interiore e spirituale.
4. Tali manifestazioni e forme corporee tanto meno giovano all’anima e allo spirito quanto più sono esteriori, a motivo della grande distanza e della sproporzione che intercorrono tra il corporale e lo spirituale. Difatti, anche se esse comunicano qualche profitto spirituale, come sempre accade quando provengono da Dio, tuttavia tale effetto è sempre molto inferiore a quello che si avrebbe se tali manifestazioni fossero spirituali e interiori. In tal modo esse possono trarre in errore molto facilmente e infondere presunzione e vanità nell’anima. Essendo tanto palpabili e materiali, solleticano molto i sensi, e l’anima crede che siano più preziose in quanto più sensibili. Essa, perciò, corre dietro a loro e abbandona la fede, ritenendo che quella luce sia la guida e il mezzo per raggiungere il suo scopo, cioè l’unione con Dio. Al contrario, essa smarrisce la via e il mezzo della fede quanto maggiormente pone attenzione a simili manifestazioni.
5. Ma vi è di più. Quando l’anima si accorge che le accadono tali fatti straordinari, spesso comincia ad accarezzare segretamente una certa opinione di valere qualcosa dinanzi a Dio, il che è contrario all’umiltà. Il demonio, inoltre, sa istillare nell’anima una segreta autocompiacenza, qualche volta anche troppo palese. A tale scopo, talvolta produce questi effetti nei sensi, offrendo agli occhi immagini di santi e splendori bellissimi, all’orecchio parole lusinghiere, all’olfatto profumi soavissimi, dolcezze al palato e delizie al tatto, per indurre le anime al male, adescandole attraverso i sensi. Occorre, quindi, respingere sempre simili rappresentazioni e sensazioni, perché, anche se venissero da Dio, non gli si reca offesa né si perdono l’effetto e il frutto che Dio intende comunicare all’anima per mezzo di esse, solo perché respinte e non cercate.
6. Il motivo sta nel fatto che, se la visione corporea o qualunque sensazione proveniente dai sensi, o qualsiasi altra comunicazione interiore, viene da Dio, nel momento stesso in cui appare ed è avvertita produce il suo effetto nello spirito, ancor prima che l’anima abbia deciso di accettarla o di respingerla. Dio, infatti, come concede questi fenomeni soprannaturali senza il minimo concorso o una disposizione particolare da parte dell’anima, così, senza alcuna sua cooperazione e abilità, provoca in essa l’effetto che vuole ottenere con tali grazie, perché queste accadono e si attuano nello spirito passivamente. Non si tratta, quindi, di volerle o di respingerle perché ci sia o non ci sia l’effetto, così come non giova a una persona nuda il desiderio di non bruciarsi quando le buttassero addosso del fuoco, perché questo produrrebbe necessariamente il suo effetto. Così è delle visioni e delle rappresentazioni che vengono da Dio; anche se non ricercate, producono il loro effetto principalmente nell’anima prima ancora che nel corpo. Analogamente, quelle che vengono dal demonio provocano nell’anima, sebbene essa non le desideri, turbamento e aridità, vanità o presunzione di spirito, ma non hanno tanta efficacia nel male quanto quelle che vengono da Dio l’hanno nel bene. Quelle che vengono dal demonio possono suscitare solo i primi impulsi nella volontà, ma non possono obbligarla, se vi si oppone; l’inquietudine che esse arrecano non dura molto, se il poco coraggio e la poca prudenza dell’anima non permette loro di durare più a lungo. Quanto alle manifestazioni che provengono da Dio, esse penetrano nell’anima, spingono la volontà ad amare e producono il loro effetto, al quale l’anima non può resistere, anche se volesse, come il vetro non può opporsi al raggio di sole quando ne viene colpito.
7. L’anima, quindi, non deve mai azzardarsi a volere simili fenomeni, anche se, ripeto, venissero da Dio, perché accogliendoli va incontro a sei inconvenienti. In primo luogo, la sua fede va diminuendo, perché ciò che si sperimenta con i sensi svigorisce molto la fede, che, come si è detto, è al di sopra di tutti i sensi. In tal modo l’anima, non chiudendo gli occhi a tutte le cose che le vengono dai sensi, si allontana dal mezzo adatto per l’unione con Dio. In secondo luogo, tali manifestazioni diventano un impedimento per lo spirito se non vengono respinte, perché l’anima si adagia in esse e lo spirito non spicca il volo verso l’invisibile. Uno dei motivi per cui il Signore disse ai discepoli che era necessario per lui andarsene, perché potesse venire lo Spirito Santo (cfr. Gv 16,7), era proprio questo. Per lo stesso motivo non permise che Maria Maddalena lo trattenesse dopo la risurrezione, ma si aggrappasse solo alla fede (cfr. Gv 20,17). In terzo luogo, l’anima va coltivando un sentimento di possesso nei confronti di queste comunicazioni e non fa progressi nella via della vera rinuncia e nudità di spirito. In quarto luogo, l’anima perde gradualmente l’effetto spirituale da esse prodotto. Quest’ultimo s’imprime e si conserva nell’anima quanto più si rinuncia alle cose sensibili, molto diverse dal puro spirito. In quinto luogo, l’anima perde, a poco a poco, i favori di Dio, perché li considera sua proprietà e non sa trarne il profitto dovuto. Considerarli come sua proprietà e non trarne profitto significa impossessarsene, mentre Dio non li concede perché l’anima desidera averli; anzi, essa non deve mai pensare che tali favori vengano da Dio. Il sesto inconveniente si verifica quando l’anima, con il desiderio di ammettere queste comunicazioni, apre la porta al demonio che la può ingannare con altre simili, che egli sa imitare e mascherare molto bene in modo da farle sembrare buone. Come dice l’Apostolo, egli può mascherarsi da angelo di luce (2Cor 11,14). Di questo, con l’aiuto di Dio, tratteremo in seguito, nel libro III, nel capitolo dedicato alla gola spirituale.
8. È sempre bene, quindi, che l’anima respinga ad occhi chiusi questi fenomeni da qualunque parte arrivino; se non lo facesse, offrirebbe spazio a quelli provenienti dal demonio e gli darebbe mano libera tanto che, anziché ricevere quelli di Dio, essa riceverebbe quelli del demonio; questi ultimi si moltiplicherebbero e quelli di Dio cesserebbero. L’anima, allora, giungerebbe ad avere tutto da demonio e nulla da Dio. Così è accaduto a molte anime incaute e poco avvedute. Si sentivano tanto sicure nell’accogliere questi fatti che molte di loro fecero non poca fatica per ritornare a Dio nella purezza della fede. Alcune non vi riuscirono, perché gli inganni del demonio avevano gettato in loro profonde radici. Per questo motivo è necessario chiudersi all’influsso di tali fenomeni e rifiutarli tutti, perché in quelli cattivi si respingono gli inganni del demonio e in quelli buoni non si pone ostacolo alcuno alla fede; così lo spirito può continuare a raccogliere i frutti che essi devono produrre. Quando le anime accolgono tali favori, Dio, a poco a poco, non li concede più perché si attaccano ad essi invece di approfittarne rettamente. Il demonio, al contrario, insinua e moltiplica i suoi falsi favori, perché trova spazio e libero accesso nell’anima; ma se questa ne è distaccata e contraria, il demonio a poco a poco si ritira, perché si accorge di non riuscire a causare danni; Dio, invece, con le sue grazie, si fa sempre più presente in quell’anima umile e distaccata, dandole autorità su molto, come al servo che era stato fedele nel poco (Mt 25,21).
9. Se in queste grazie l’anima continuerà ad essere fedele e distaccata, Dio non mancherà di condurla, di grado in grado, sino all’unione e trasformazione in lui. Egli prova ed eleva l’anima a poco a poco, concedendole inizialmente favori esteriori, ordinari, sensibili, proporzionati alla sua scarsa capacità. In seguito, se essa si comporta come deve, prendendo questo primo nutrimento con sobrietà per rafforzarsi e sostenersi, le offrirà un cibo più abbondante e migliore. Se essa saprà vincere il demonio in questo primo stadio, passerà al secondo; e se lo vincerà nel secondo, passerà al terzo e così, gradino dopo gradino, raggiungerà tutte e sette le mansioni, che sono i sette gradi dell’amore, finché lo Sposo non la introdurrà nella cella vinaria (Ct 2,4) della sua perfetta carità.
10. Beata l’anima che saprà lottare contro l’apocalittica bestia dalle sette teste (Ap 12,3), contrarie a questi sette gradi dell’amore, con le quali fa guerra contro questi gradi e lotta contro l’anima in ognuna delle sette mansioni, ove essa si esercita per conquistare tutti i gradi dell’amore di Dio! Se l’anima combatterà fedelmente in ciascuna mansione e vincerà, meriterà di salire, di grado in grado o di dimora in dimora, fino all’ultima, dopo aver tagliato una dopo l’altra le sette teste che le muovevano guerra spietata. Lo stesso san Giovanni, nel libro citato (Ap 13,7), dice che fu concesso alla bestia di lottare contro i santi e di vincerli in ognuno di questi gradi d’amore, impiegando contro ciascuno di essi tutte le armi e le munizioni necessarie. È molto triste, perciò, constatare che parecchie persone, dopo aver intrapreso questa battaglia spirituale contro la bestia, non sappiano tagliarle nemmeno la prima testa, perché non vogliono rinunciare ai beni sensibili di questo mondo. Alcuni, poi, che si decidono a tagliare la prima testa, non riescono a fare altrettanto con la seconda, perché non rinunciano alle visioni sensibili, di cui sto parlando. Ma la cosa ancora più triste è constatare che alcuni, essendo riusciti a tagliare non solo la prima e la seconda testa, ma anche la terza – respingendo le percezioni dei loro sensi interni, oltrepassando lo stadio della semplice meditazione e spingendosi molto più avanti –, quando stanno per entrare nella zona del puro spirito, vengono sconfitti dalla bestia. Questa, allora, riesce a risollevare e risuscitare contro di loro addirittura la prima testa. E così la condizione finale risulta peggiore della prima, a causa della ripresa della bestia, che prende con sé altri sette spiriti peggiori (Lc 11,26).
11. L’uomo spirituale deve, quindi, respingere tutte le percezioni accompagnate dai piaceri temporali, derivanti dai sensi esterni, se vuole tagliare la prima e la seconda testa della bestia; potrà, così, entrare nella prima dimora dell’amore e nella seconda della fede viva, non accogliendo nulla che provenga dai sensi, che lo allontanano molto dalla fede.
12. È, dunque, chiaro che queste visioni e rappresentazioni sensibili non potranno essere un mezzo adeguato per raggiungere l’unione divina, perché non sono proporzionate a Dio. Uno dei motivi per cui Cristo non voleva che la Maddalena (Gv 20,17) e san Tommaso (Gv 20,29) lo toccassero era proprio questo. Si capisce, allora, come il demonio sia molto soddisfatto quando un’anima voglia ricevere rivelazioni e mostri inclinazioni per esse, perché in tal caso essa gli offre una facile occasione per insinuare errori ed allontanarla dalla fede il più possibile. Infatti, come ho già detto, l’anima che cerca tali rivelazioni si allontana da questa virtù e a volte cade anche in tentazioni e presunzioni.
13. Mi sono un po’ dilungato sulle percezioni provenienti dai sensi esterni, allo scopo di far luce sulle altre manifestazioni che ora tratterò. Ma su questo argomento ci sarebbe così tanto da dire che non finirei mai. Capisco di essere stato anche fin troppo breve, ma credo sufficiente quanto ho detto e vorrei ripetere di avere sempre molta cura nel respingere tali comunicazioni, facendo eccezione solo per qualcuna e dietro parere di persona molto esperta; ma anche in questo caso non bisogna mai desiderarle.
CAPITOLO 12
Ove si tratta delle percezioni immaginarie naturali. Si spiega che cosa siano e si prova che non possono essere mezzo adatto per giungere all’unione con Dio. Si parla, infine, del danno provocato dall’attaccamento ad esse.
1. Prima di trattare delle visioni immaginarie che sogliono presentarsi soprannaturalmente ai sensi interni, cioè all’immaginazione e alla fantasia, per procedere con ordine è opportuno trattare qui delle percezioni naturali di questi stessi sensi interni corporali. Si procederà, così, dal meno al più, dal più esterno al più interno, fino a giungere a quella quiete intima dove l’anima si unisce con Dio. Del resto è l’ordine seguito finora. Difatti ho parlato anzitutto dello spogliamento dei sensi circa le percezioni naturali degli oggetti esterni e, conseguentemente, delle forze naturali dei nostri appetiti. Tale è stato l’argomento dei libro I, dove ho parlato della notte dei sensi. Subito dopo ho cominciato a trattare dello spogliamento dell’anima circa le percezioni esterne soprannaturali, che accecano appunto i sensi esterni. L’ho fatto nel capitolo precedente, per introdurre l’anima nella notte dello spirito.
2. In questo libro II il primo argomento da trattare riguarda i sensi corporali interni, cioè l’immaginazione e la fantasia. Occorre spogliare anche tali sensi da tutte le forme e percezioni immaginarie che essi possono concepire naturalmente. Devo altresì provare che è impossibile all’anima giungere all’unione con Dio se non smette di agire per mezzo di queste percezioni, perché non possono costituire un mezzo adeguato e prossimo a tale unione.
3. Ricordo che i sensi dei quali parlo qui in particolare sono i due sensi corporali interni: l’immaginazione e la fantasia. Essi sono ordinati l’uno all’altro e si condizionano a vicenda, perché il primo procede per immagini, l’altro forma le immaginazioni, ossia ciò che è immaginato, lavorando con la fantasia. Per il nostro argomento è indifferente trattare dell’uno o dell’altro; perciò, quando li citerò entrambi, ci si ricordi di quello che ho detto qui. Ciò posto, bisogna dire che tutto quanto tali sensi possono accogliere o elaborare si chiama immaginazioni e fantasie: forme, cioè, che si presentano a questi sensi sotto l’immagine e la figura di un corpo. Tali forme possono essere di due specie: alcune soprannaturali, in quanto si presentano ai due sensi senza la loro cooperazione, ma vengono da essi ricevute passivamente. A queste, di cui parlerò più avanti, diamo il nome di visioni immaginarie. Vengono all’uomo per via soprannaturale. Altre sono naturali, in quanto i sensi interni possono produrle con la loro attività, sotto l’aspetto di forme, figure o immagini. Su queste due potenze si basa la meditazione, che è un atto discorsivo elaborato attraverso immagini, forme e figure, fabbricate e immaginate dai suddetti sensi. Avviene così quando ci si immagina Cristo crocifisso o legato alla colonna o in un’altra situazione, oppure Dio seduto in trono in tutta la sua maestà; o ancora la gloria come una luce bellissima, ecc., e similmente qualsiasi altra cosa del genere, sia divina che umana, che può essere oggetto d’immaginazione. Ora, l’anima deve liberarsi da tutte queste immaginazioni, rimanendo al buio secondo questo senso, se vuole pervenire all’unione divina. Queste, infatti, non possono assolutamente essere un mezzo proporzionato, immediato, per arrivare a Dio, proprio come le sensazioni corporali che provengono dai cinque sensi esterni.
4. Il motivo di questo sta nel fatto che l’immaginazione non può fabbricare né rappresentare una realtà diversa da quella sperimentata con i sensi esterni, cioè che ha visto con gli occhi, udito con le orecchie, ecc.; al massimo può formare immagini simili a quelle viste, udite o sperimentate, anche se queste non saranno mai superiori e così intense come quelle percepite attraverso i sensi esterni. Infatti, anche se può immaginare palazzi di perle o montagne d’oro, perché ha visto perle e oro, in realtà tutto questo è meno di un granello d’oro o di una perla, sebbene nell’immaginazione sia superiore in quantità e bellezza. Poiché, come ho già detto, tutte le cose create non possono essere assolutamente proporzionate all’essere di Dio, ne segue che tutto ciò che si può immaginare a loro somiglianza non può costituire un mezzo prossimo all’unione divina, anzi, ripeto, ce ne allontana.
5. Coloro, quindi, che immaginano Dio sotto qualcuna di queste forme, o come un grande fuoco o splendore, o sotto qualsiasi altra forma, oppure pensano che qualcosa del genere gli somigli, si allontanano molto da lui. Certamente queste considerazioni, forme e maniere per meditare sono necessarie ai principianti perché comincino a innamorarsi e a nutrire lo spirito per mezzo dei sensi, come dirò più avanti. Tutte queste rappresentazioni costituiscono per loro, dunque, mezzi remoti per unirsi a Dio, attraverso i quali ordinariamente devono passare per arrivare al termine e alla quiete del riposo spirituale. Tuttavia le anime devono solo passare attraverso di essi, non fermarvisi, perché altrimenti non arriverebbero alla meta, che non somiglia né ha nulla in comune con i mezzi remoti. Questi sono come i gradini di una scala che non hanno nulla di somigliante al termine o alla stanza cui conducono, ma sono soltanto mezzi per arrivarvi. Perciò, se colui che sale non lasciasse dietro di sé i gradini, ma volesse fermarsi su qualcuno di essi, non salirebbe né giungerebbe mai al pianerottolo e alla piacevole dimora in cima alla scala. Allo stesso modo l’anima che in questa vita vuole giungere all’unione con Colui che è assoluto riposo e sommo bene, deve passare per tutti i gradi delle considerazioni, delle forme e delle conoscenze e disfarsene, perché queste non hanno somiglianza alcuna né proporzione con il termine al quale conducono, cioè Dio. Per questo san Paolo, negli Atti, afferma: Non debemus aestimare auro vel argento, aut lapidi sculpturae artis, et cogitationis hominis divinum esse simile, che vuol dire: Non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all’oro, all’argento e alla pietra, che porti l’impronta dell’arte o dell’immaginazione umana (At 17,29).
6. Questo è il motivo per cui molte persone spirituali si sbagliano di grosso. Si sono esercitate, come principianti, ad avvicinarsi a Dio per mezzo di immagini, rappresentazioni e meditazioni, mentre sono da lui chiamate a conseguire beni più elevati, interiori e invisibili. A tale scopo vengono private del gusto e della sostanza della meditazione discorsiva, e ciò nonostante non smettono né osano né tanto meno sanno distaccarsi da quei modi sensibili cui sono abituate. Benché si affatichino a praticarli, vogliono procedere, come prima, con la riflessione e la meditazione di immagini, pensando che debba essere sempre così. In tale tentativo si affaticano molto e ricavando poco o nessun giovamento. Anzi, quanto più si affannano per quel gusto che provavano prima, tanto più crescono in esse l’aridità, la stanchezza e l’inquietudine spirituale. Ma l’anima non può conseguire tale gusto come in passato, perché, come ho detto, essa non prova più gusto per un cibo così grossolano. Sente il bisogno di un altro più delicato, più interiore e meno sensibile, che non consiste nel lavorare con l’immaginazione, ma nel riposo e nella quiete assoluta. Tale nutrimento è più spirituale. In realtà, quanto più l’anima diventa spirituale, tanto più cessa di operare con le potenze in atti particolari, concentrandosi in un atto generale e puro. A questo punto le potenze abbandonano la via che aveva condotto l’anima a tale stato, così come i piedi, alla fine del viaggio, cessano di muoversi e si fermano. Se si dovesse camminare sempre, non si arriverebbe mai, e se tutto si riducesse a un mezzo, dove e quando si godrebbero il fine o la meta del viaggio?
7. Per questo motivo dispiace assai osservare tante persone che turbano la loro anima costringendola a badare a cose esteriori e, senza motivo, cercano di rifare il cammino già percorso abbandonando il fine o la meta in cui riposavano e che avevano raggiunto con i mezzi della meditazione, mentre la loro anima vorrebbe restare nella serenità e nel riposo della quiete interiore per gustare la pace e nutrirsi di Dio. Tutto questo provoca disgusto e ripugnanza nell’anima che avrebbe voluto rimanere in quella pace, che non comprende, come nel posto che le è proprio. La stessa pena sperimenta colui che è arrivato con fatica al luogo del suo riposo ed è costretto a riprendere il lavoro. Purtroppo tali persone non comprendono il mistero di questa novità. Pensando di stare in ozio, senza far nulla, non accettano quel riposo, ma cercano di meditare e di discorrere. In questo modo aumenta la loro aridità e invano si sforzano di ricevere giovamento da dove ormai non possono più averne. Anzi si può dire che più si affannano, meno progrediscono, perché quanto più si ostinano, tanto più si trovano a disagio; non fanno altro che sottrarre l’anima alla pace spirituale, lasciare il più per il meno e ripercorrere il cammino già percorso, siccome vogliono rifare ciò che è già fatto.
8. A costoro occorre dire che imparino a starsene in quella quiete spirituale in un’attenzione e contemplazione piena d’amore per Dio, a non occuparsi dell’immaginazione e della sua attività. In questo stato, ripeto, le potenze dell’anima riposano e non sono attive, bensì passive, accettando quanto Dio opera in esse. Se talvolta agiscono, non lo fanno con sforzo o con l’aiuto di prolungati ragionamenti, ma con la soavità dell’amore, mosse più da Dio che dall’abilità dell’anima, come spiegherò più avanti. Per il momento basti questo per far capire quanto sia conveniente e necessario, a coloro che vogliono progredire, sapersi distaccare, al momento opportuno, da tutti questi modi di agire o da simili rappresentazioni dell’immaginazione, quando lo richiede il progresso dello stato in cui si trovano.
9. Per conoscere quale sia il momento opportuno, nel capitolo seguente indicherò alcuni segni che le persone spirituali devono scoprire in sé per sapere quando possono servirsi liberamente del metodo indicato e abbandonare la via del ragionamento e del lavoro dell’immaginazione.
CAPITOLO 13
Ove si descrivono i segni che la persona spirituale deve osservare in se stessa, per conoscere il momento adatto per abbandonare la meditazione e il ragionamento e passare allo stato della contemplazione.
1. Perché questa dottrina non resti nebulosa, converrà in questo capitolo indicare alla persona spirituale il momento adatto per abbandonare la meditazione discorsiva, portata avanti con l’uso delle suddette rappresentazioni, forme e figure, perché non lo faccia né prima né dopo rispetto alle esigenze dello spirito. Se, infatti, è conveniente lasciare la meditazione immaginativa a tempo debito perché non sia di ostacolo per andare a Dio, è parimenti necessario non lasciarla prima del tempo per non tornare indietro. Sebbene le percezioni dell’immaginazione e della fantasia non servano ai proficienti come mezzi prossimi all’unione con Dio, tuttavia possono essere d’aiuto ai principianti come mezzo remoto per disporsi e per abituarsi alle realtà spirituali attraverso i sensi, per poi svuotarli, durante il cammino, da tutte le altre forme e immagini vili, temporali, mondane e naturali. A questo proposito offrirò qui alcuni segni e indizi, che la persona spirituale deve scoprire in sé, per valutare se abbandonare o meno queste immagini, a un dato momento.
2. Il primo segno si presenta quando l’anima si accorge di non poter più meditare né discorrere con l’immaginazione, come pure di non trovare gusto in questo esercizio come le avveniva prima. Al contrario, ora prova aridità nelle cose in cui prima era solita fissare il gusto e trarne giovamento. Ma finché ci trova gusto e può discorrere nella meditazione, non deve lasciarla, a meno che la sua anima abbia raggiunto la pace e la serenità di cui si parla nel terzo segno.
3. Il secondo segno si verifica quando l’anima non ha nessuna voglia di applicare la sua fantasia o i sensi ad altri oggetti particolari, esteriori o interiori. Non intendo dire che la fantasia non lavori, perché anche nel profondo raccoglimento essa è solita essere libera, ma che non piace alla persona applicarla di proposito ad altri oggetti.
4. Il terzo segno, che è più sicuro, si ha quando l’anima prova piacere a starsene sola con Dio, in uno sguardo d’amore contemplante, senza particolari considerazioni. Sua unica occupazione è godere la pace interiore, la quiete e il riposo divino, escludendo ogni attività ed esercizio delle potenze, della memoria, dell’intelletto e della volontà, o perlomeno gli atti discorsivi, nei quali si passa da un oggetto all’altro. Essa intende godere la presenza di Dio accompagnata solo da uno sguardo e una conoscenza generale amorosa, di cui abbiamo parlato, senza particolari conoscenze, rinunciando persino a comprenderne l’oggetto.
5. La persona spirituale deve riscontrare contemporaneamente in sé questi tre segni prima di decidersi a lasciare lo stato della meditazione e l’uso dei sensi, per passare poi a quello della contemplazione e dello spirito.
6. Non basta che scorga in sé il primo segno senza il secondo, perché potrebbe darsi che non possa più rappresentarsi né meditare le cose di Dio, come prima, per distrazione o poca diligenza. Deve, quindi, scorgere in sé anche il secondo segno, che è quello di non aver voglia né desiderio di pensare a cose estranee. Infatti, quando l’impossibilità di fissare l’immaginazione o i sensi sulle cose di Dio proviene da distrazione o tiepidezza, l’anima avverte subito il desiderio e la voglia di occuparsi di altre cose, cercando un pretesto per abbandonare la meditazione. Non basta nemmeno scorgere in sé il primo e il secondo segno, se non congiunti al terzo. Infatti, anche se l’anima si rende conto che non può meditare né riflettere sulle cose di Dio e che tanto meno le giova pensare a quelle diverse da lui, questo stato potrebbe derivare da malinconia o da qualche altro cattivo umore proveniente dalla testa o dal cuore. Tale umore abitualmente provoca nei sensi un certo torpore e inattività delle facoltà tanto da impedire di pensare a qualcosa, di volerla o aver voglia di pensarvi, per rimanere in quello stato di astrazione saporosa. Per evitare questo, l’anima deve verificare in sé il terzo segno, che consiste nella conoscenza e nello sguardo amoroso e pacifico su Dio, ecc., come ho detto sopra.
7. Ma è vero che, agli inizi di questo stato, non si riesce a percepire del tutto tale conoscenza amorosa. Ciò accade per due motivi: primo, perché agli inizi questa conoscenza amorosa è abitualmente molto sottile e delicata e quasi impercettibile; secondo, perché l’anima, essendo stata abituata all’altro esercizio della meditazione, completamente basato sui sensi, non riesce a vedere e quasi non avverte questa conoscenza nuova che non passa attraverso i sensi, in quanto è puramente spirituale. Ciò le capita soprattutto quando, non comprendendola, non vi si abbandona serenamente, ma continua a cercare l’altro stato più sensibile. E così, sebbene sia investita da una pace interiore, piena d’amore, più abbondante, non riesce a sentirla né a goderla. Ad ogni modo, quanto più si abituerà alla quiete interiore, tanto più crescerà in essa e avvertirà quella conoscenza piena d’amore per Dio. Quest’ultima le piacerà più di ogni altra cosa creata, perché le procurerà pace, riposo, gusto e diletto, senza alcuna fatica.
8. Per chiarire ulteriormente quanto è stato detto, esporrò nel capitolo seguente cause e ragioni che dimostrano la necessità di questi tre segni per passare al piano dello spirito.
Ove si dimostra la convenienza di questi segni, spiegando quanto sia necessario per l’anima saperli riconoscere al fine di progredire.
1. Circa il primo segno che ho presentato, occorre ricordare che la persona spirituale – per entrare nella via dello spirito, cioè nella contemplazione – deve abbandonare la via delle immagini e della meditazione sensibile quando non vi provi più gusto e non riesca più a discorrere. E questo per due motivi, che si fondono in uno. Il primo è che l’anima ha già ricevuto, in certo modo, tutto il bene spirituale che poteva trovare nelle cose di Dio attraverso la meditazione e il ragionamento. L’indizio consiste nel fatto che non può più, come prima, né meditare né discorrere né trovare in tali esercizi gusto o piacere, perché fino a quel momento non era ancora arrivata al bene spirituale ad essa riservato in questo stato. Difatti, ordinariamente, tutte le volte che l’anima riceve qualche bene spirituale, lo gusta, perlomeno spiritualmente, proprio in quel mezzo attraverso cui lo riceve e che le è utile; altrimenti sarà un caso se ne trae giovamento o se nella causa di tale bene trova quel sostegno e quel gusto che prova quando lo riceve. Avviene proprio come dicono i filosofi: Quod sapit, nutrit: Ciò che dà sapore, nutre e ingrassa. A tale proposito Giobbe afferma: Numquid poterit comedi insulsum, quod non est sale conditum?: Si mangia forse un cibo insipido, senza sale? (Gb 6,6). Il motivo, dunque, per cui l’anima non può più meditare né discorrere come prima è questo: il poco sapore e lo scarso profitto che lo spirito trova in tale esercizio.
2. Il secondo motivo sta nel fatto che a questo punto l’anima possiede lo spirito di meditazione sostanzialmente e abitualmente. Occorre ricordare, infatti, che scopo della meditazione e del discorrere nelle cose di Dio è quello di ottenere un po’ di conoscenza e di amore di Dio. Ogni volta che l’anima, tramite la meditazione, ricava tale frutto, compie un atto. Come molti atti, in qualsiasi altro campo, finiscono per generare nell’anima un’abitudine, così molti atti di queste conoscenze piene d’amore, che l’anima ha di volta in volta emesso in particolare, con il loro ripetersi finiscono per diventare in essa un abito. Dio è solito concedere tale abito a molte anime anche senza la mediazione di tali atti, o almeno d’un buon numero di essi, collocandole subito nello stato di contemplazione. Così, ciò che prima l’anima otteneva periodicamente meditando con fatica su conoscenze particolari, ora, come ho detto, attraverso la ripetizione si è tramutato in abito e sostanza di una conoscenza amorosa generale, non distinta né particolare come prima. Perciò, quando l’anima si mette a pregare, beve con piacere senza fatica alcuna, come chi ha l’acqua a portata di mano, senza doverla far arrivare attraverso i faticosi mezzi precedenti, quali i ragionamenti, le rappresentazioni e le figure. Così, appena si mette alla presenza di Dio, possiede una conoscenza di Dio confusa, amorosa, piena di pace e di quiete, in cui beve i fiotti della sapienza, dell’amore e della dolcezza.
3. Questo è il motivo per cui l’anima prova molta pena e disgusto quando si trova in questa quiete e si vuole farla applicare faticosamente alla meditazione e a conoscenze particolari. Accade ad essa come al bambino che viene strappato dal petto materno mentre, tutto raccolto, sta succhiando il latte, per obbligarlo a spremere e comprimere con fatica la mammella onde procurarselo di nuovo. Somiglia, altresì, a colui che ha già tolto la buccia e sta gustando la polpa, quando venisse costretto a lasciare questa e a tornare di nuovo alla buccia che non c’è più: così non troverebbe più la buccia e cesserebbe di gustare la polpa che aveva già tra le mani; in questo è simile a uno che lascia ciò che ha per correre dietro a ciò che non ha.
4. Così agiscono molte di quelle anime che cominciano a entrare in questo stato. Pensano che tutta la loro occupazione consista nel ragionare e comprendere cose particolari di Dio attraverso immagini e forme, che sono la corteccia della vita spirituale. Poiché non trovano tali immagini e forme nella quiete amorosa e sostanziale in cui desiderano restare, e non comprendono che cosa stia accadendo, pensano di smarrirsi o di perdere tempo. Tornano a cercare la scorza delle loro immagini e del loro ragionamento, ma non la trovano più perché è sparita; e così non gustano né il frutto, che è la contemplazione, né la scorza, che è la meditazione. Allora esse si turbano, credendo di tornare indietro e di perdersi. E in realtà si perdono, ma non come pensano loro, perché si perdono ai loro sensi e al primitivo modo di comprendere le cose; ora tutto questo significa che stanno raggiungendo il puro spirito, concesso loro a poco a poco. Quanto meno capiscono ciò che sta accadendo, tanto più entrano nella notte dello spirito – di cui si parla in questo libro – che esse devono attraversare per unirsi a Dio al di là di ogni conoscenza.
5. Per quanto riguarda il secondo segno c’è poco da dire, perché è chiaro che l’anima, a questo punto, non prova assolutamente più gusto nelle immagini estranee, cioè mondane, dal momento che essa non si diletta nemmeno più delle immagini relative alle cose di Dio per i motivi già detti. Ma, ripeto, durante questo raccoglimento l’immaginazione è solita spaziare liberamente, senza che l’anima si compiaccia o vi acconsenta; anzi ne è infastidita, perché ciò disturba la sua pace e il suo diletto.
6. Credo non sia opportuno parlare ora della convenienza e necessità del terzo segno, cioè della conoscenza o attenzione generale, piena d’amore, per Dio, al fine di abbandonare la meditazione, perché è stato detto qualcosa trattando del primo segno. Se ne parlerà espressamente a suo luogo, quando si esaminerà questa conoscenza generale e confusa, cioè dopo aver analizzato i modi particolari di apprendere dell’intelletto. Qui mi limiterò ad addurre un solo motivo che permette di vedere chiaramente come, al momento di lasciare la via della meditazione e del ragionamento, il contemplativo abbia bisogno di questa conoscenza o attenzione piena di amore per Dio, in maniera generale. Questo perché, se l’anima in quel momento non avesse questa conoscenza o sentimento della presenza di Dio, resterebbe inoperosa e non avrebbe nulla. In realtà, dopo aver lasciato la meditazione, che aiuta a discorrere attraverso le potenze sensitive, se all’anima viene a mancare anche la contemplazione, cioè, ripeto, la conoscenza generale nella quale essa tiene impegnate le potenze spirituali, la memoria, l’intelletto e la volontà, unite ormai in questa conoscenza già prodotta in esse, detta anima rimarrebbe necessariamente priva di ogni esercizio nei confronti di Dio. Essa, infatti, non può operare né ricevere ciò che viene compiuto se non per mezzo delle potenze sensitive e spirituali. Mediante le prime, come ho detto, l’anima può discorrere, cercare ed elaborare le conoscenze degli oggetti; mediante le seconde può godere delle conoscenze ricevute attraverso le potenze precedenti, senza che queste operino più.
7. La differenza, dunque, che esiste nell’uso che l’anima fa delle potenze nell’uno e nell’altro stato, è la stessa che vige tra il lavorare a un’opera e il godere dell’opera fatta, oppure tra la fatica del cammino e la riposante quiete al termine del cammino. È come la differenza che intercorre tra la preparazione di un cibo e il mangiarlo o gustarlo già cotto e triturato, senza alcuna fatica; o ancora tra il ricevere e l’approfittare di ciò che si è ricevuto. Ugualmente, se l’anima non fosse occupata nell’operare con le potenze sensitive nella meditazione e nel ragionamento, o con l’aiuto delle potenze spirituali nella contemplazione e nella conoscenza, di cui ho parlato, nella quale essa gode di un bene ricevuto e acquisito; in breve, se essa non si serve di entrambe queste potenze, non potremmo assolutamente dire né come né in che cosa sia occupata. È, quindi, indispensabile all’anima avere questa conoscenza generale per poter lasciare la via della meditazione e del ragionamento.
8. Ma a questo proposito si deve sapere che questa conoscenza generale di cui sto parlando, a volte è molto sottile e delicata, soprattutto quando è più pura, semplice, perfetta, più spirituale e interiore, tanto che l’anima, pur essendo occupata in essa, non riesce a vederla né a sentirla. Questo accade quando tale conoscenza, ripeto, è in sé più limpida, perfetta e semplice. E lo è quando essa investe un’anima più spoglia e distaccata da altre conoscenze e nozioni particolari alle quali l’intelletto e i sensi potrebbero essere attaccati. Così, essendo l’anima priva di queste conoscenze particolari, offerte dall’intelletto e dai sensi secondo la loro abituale capacità, non le sente più, perché le mancano le forme sensibili. Questo è il motivo per cui, quanto più pura, perfetta e semplice è tale conoscenza, tanto meno l’intelletto la comprende e tanto più la sente oscura. Al contrario, quanto meno essa è in sé pura e semplice nell’intelletto, tanto più chiara e preziosa apparirà all’intelletto stesso, essendo vestita o mescolata o avvolta in alcune forme sensibili su cui l’intelletto o i sensi possono fermarsi.
9. Il seguente paragone ci permetterà di comprendere meglio questo pensiero: quando un raggio di sole entra per la finestra, più esso è pieno di corpuscoli e di polvere, più appare visibile, percettibile e chiaro al senso della vista. Ma naturalmente il raggio è meno puro e meno chiaro e in sé meno semplice e perfetto, perché pieno di tanta polvere e corpuscoli estranei; quanto invece è più puro e privo di quei corpuscoli e di pulviscolo, tanto meno sensibile e percettibile appare all’occhio materiale; quanto più è puro, tanto più oscuro e inafferrabile appare. Se questo raggio fosse completamente privo di particelle di polvere, anche delle più minuscole, sarebbe del tutto invisibile e impercettibile all’occhio, perché privo di quegli elementi visibili che formano l’oggetto proprio della vista. Quest’ultima, infatti, non troverebbe elementi su cui posarsi, perché la luce non è l’oggetto proprio della vista, ma il mezzo con cui scorge ciò che è visibile. Così, mancando gli elementi visibili sui quali il raggio o la luce possono riflettersi, non si vede nulla. Per cui, se il raggio entrasse da una finestra e uscisse da un’altra senza imbattersi in nessun oggetto che faccia da schermo, non si vedrebbe nulla. Eppure il raggio sarebbe in sé più puro e più limpido di quando, carico di particelle visibili, si vede e si percepisce come più luminoso.
10. Lo stesso accade per la luce spirituale nei confronti della vista dell’anima, cioè l’intelletto. Questa conoscenza generale, questa luce soprannaturale, di cui sto parlando, lo investe con tanta limpidezza e semplicità ed è tanto spoglia e aliena da tutte le forme sensibili, le quali sono l’oggetto proprio dell’intelletto, che questo non l’avverte e non la vede. Anzi, a volte, quanto tale conoscenza è più pura, crea oscurità nell’intelletto, perché lo priva delle sue luci abituali, delle forme e dei fantasmi, e allora esso si rende conto dell’oscurità in cui si trova. Ma quando l’anima non è investita da questa luce divina con tanta forza, non scorge le tenebre, né vede la luce, né percepisce avvertitamene conoscenza alcuna di quaggiù o di lassù. Così, a volte, essa viene a trovarsi come in un profondo oblio, non sapendo dove si trova, né cosa abbia fatto, né se sia passato del tempo. Può dunque accadere, e accade, che l’anima trascorra molte ore in questo oblio e, quando ritorna in sé, le sembra che tale oblio sia durato un attimo e che non sia accaduto nulla.
11. La causa di tale oblio è da ricercarsi nella purezza e nella semplicità di questa conoscenza che, occupando l’anima, la rende semplice, pura e distaccata da tutte le percezioni e le immagini dei sensi e della memoria con cui essa operava nel tempo, lasciandola così nell’oblio e senza tempo. Quest’orazione, sebbene duri molto, all’anima – ripeto – sembra brevissima, perché è stata unita a Dio per mezzo della sua intelligenza pura, cioè libera da ogni mediazione, quindi fuori del tempo. Tale è l’orazione breve, di cui si dice che penetra i cieli: breve perché non è nel tempo; penetra i cieli perché l’anima è unita a Dio attraverso la sua intelligenza ormai celestiale. Perciò tale conoscenza lascia nell’anima, quando questa ritorna in sé, gli effetti in essa prodotti, senza che se ne accorga. Questi sono l’elevazione dello spirito all’intelligenza celestiale, il distacco e l’allontanamento da tutte le cose, forme e figure e dal loro ricordo. Davide afferma che gli accadde così quando tornò in sé da un oblio simile: Vigilavi, et factus sum sicut passer solitarius in tecto, che vuol dire: Nel continuo vegliare sono diventato come un passero solitario sopra un tetto (Sal 101,8). Dice di essere solitario, cioè staccato ed estraniato da tutte le cose. Abita sopra un tetto, perché il suo spirito è molto elevato. Così è l’anima, completamente ignorante delle cose della terra, perché conosce solo Dio. Per questo la sposa del Cantico afferma che, tra gli effetti prodotti in lei da questo suo sogno e oblio, c’era questo non sapere, quando, al momento in cui riceveva questa grazia, esclamò: Nescivi, cioè non seppi (Ct 6,12) da dove mi veniva tale grazia. Sebbene all’anima favorita di tale conoscenza sembri di non fare nulla né di essere occupata in cosa alcuna, perché non agisce con i sensi e le potenze, tuttavia non creda che stia perdendo tempo. Difatti, anche se l’armonia delle potenze dell’anima è sospesa, la sua intelligenza è nello stato di cui ho parlato sopra. Per questo motivo la sposa, che era saggia, sempre nel Cantico risponde a se stessa su questo dubbio, affermando: Ego dormio et cor meum vigilat (Ct 5,2), come a dire: sebbene io dorma, secondo la mia natura, cessando di agire naturalmente, il mio cuore vigila, elevato soprannaturalmente in una conoscenza soprannaturale.
12. Non si deve, però, credere che questa conoscenza, così come l’ho descritta, causi necessariamente oblio. Tale fenomeno avviene solo quando Dio priva l’anima dell’esercizio di tutte le sue potenze naturali e spirituali. Ciò accade rare volte, perché non sempre tale conoscenza occupa l’anima interamente. Affinché essa produca l’effetto di cui sto parlando, basta che l’intelletto sia libero da qualsiasi conoscenza particolare, nell’ordine temporale e spirituale, e che la volontà non abbia alcun desiderio di pensare agli oggetti d’entrambi gli ordini, come ho detto, perché allora è segno che l’anima è occupata. Questo, dunque, è l’indizio per sapere se l’anima si trova in tale stato, cioè quando tale conoscenza si applica e si comunica solo all’intelletto. Ciò accade, a volte, quando l’anima non se ne accorge. Quando, infatti, si comunica allo stesso tempo anche alla volontà, cioè quasi sempre, l’anima non manca di comprendere, press’a poco, se vuole prestarvi attenzione, di essere applicata e occupata in questa conoscenza. La riconosce perché sente di provare una soavità piena di amore, senza però sapere e comprendere in particolare ciò che ama. Per questo motivo definisce generale tale conoscenza piena d’amore, perché questa si comunica all’intelletto in modo oscuro e nella volontà veicola soavità e amore in modo confuso, senza cioè che questa sappia esattamente ciò che ama.
13. Per ora questo può bastare per far capire quanto convenga all’anima essere occupata in simile conoscenza prima di abbandonare la via della meditazione discorsiva e per essere sicura, sebbene ad essa sembri il contrario, che è ben occupata, dal momento che scorge in sé i suddetti segni. Dal paragone sopra riportato, inoltre, credo che si capisca come l’anima non debba ritenere questa luce più pura, elevata e chiara perché si presenta all’intelletto più comprensibile e percettibile. È simile al raggio di sole che è più visibile all’occhio quando è pieno di impurità. È dunque evidente, come dice Aristotele e ripetono i teologi, che quanto più alta ed eccelsa è la luce divina, tanto più oscura essa è per il nostro intelletto.
14. C’è molto da dire su questa conoscenza divina, considerata in se stessa e negli effetti che produce nei contemplativi. Rimando tutto al momento opportuno, perché anche su quello che ho detto in questo capitolo non mi sarei dilungato tanto se non per il timore di lasciare questa dottrina un po’ più confusa di quanto non sia ora. Di fatto lo è, e molto anche, lo ammetto, perché si tratta di un argomento di cui si parla poco sia a voce che per iscritto, essendo di per sé straordinario e oscuro. A tale difficoltà si aggiungono il mio povero modo di presentare tale dottrina e la mia poca scienza. Per questo, dubitando di non saperla spiegare, mi accorgo che spesso mi dilungo troppo e oltrepasso i limiti consentiti al luogo e alla dottrina in questione. Confesso, d’altronde, che a volte lo faccio di proposito, perché ciò che non si riesce a far capire con alcune ragioni, forse riuscirà comprensibile con altri argomenti e anche perché così si fa più luce su quanto si dirà più avanti. Per concludere questa parte, credo quindi opportuno rispondere a un dubbio che può sorgere circa la durata di questa conoscenza. È ciò che farò nel capitolo seguente.
CAPITOLO 15
Ove si mostra ai proficienti, che cominciano a entrare in questa conoscenza generale della contemplazione, come sia a loro opportuno servirsi talvolta della meditazione discorsiva e delle loro potenze naturali.
1. Su quanto già è stato detto può sorgere un dubbio: i proficienti, quelli cioè che Dio comincia a introdurre in questa conoscenza soprannaturale di contemplazione, di cui sto parlando, e che iniziano appena a farne esperienza, non devono mai servirsi della meditazione, dei ragionamenti e delle immagini naturali? A questo dubbio si risponde nel modo seguente: a coloro che cominciano ad avere questa conoscenza amorosa generalmente non è proibito cercare di meditare, sia perché, essendo all’inizio del loro cammino, non sono abituati a questa conoscenza amorosa al punto d’intraprenderla immediatamente appena vogliano, sia perché non si sono ancora distaccati dalla meditazione tanto da non potere più talvolta meditare o discorrere naturalmente, com’erano soliti fare, con le immagini e le letture consuete, per trarne qualche nuovo profitto. Anzi, al principio, quando dagli indizi suddetti tali persone si accorgeranno che la loro anima non è più occupata nella conoscenza che dà pace, dovranno avvalersi della meditazione discorsiva, finché non arriveranno alla contemplazione abituale in un modo più o meno perfetto, come accennavo sopra. Ciò accadrà quando, volendo meditare, non raggiungeranno immediatamente la conoscenza e la pace interiore, e neppure ne avranno il minimo desiderio, come ho detto. Prima di arrivare a questo stato, che è proprio dei proficienti, si deve ricorrere sia all’uno che all’altro esercizio, secondo i momenti.
2. Così l’anima molte volte si troverà immersa in questa amorosa e pacifica presenza di Dio, senza l’aiuto delle sue potenze, non ponendo atti particolari, cioè non operando attivamente, ma disponendosi solo a ricevere. Altre volte, invece, per potersi introdurre in tale presenza, dovrà aiutarsi dolcemente e moderatamente con la meditazione discorsiva. Ma una volta entrata in quello stato, torno a ripetere, l’anima non si serve più delle sue potenze. Al contrario, si può veramente dire che, a questo punto, la conoscenza e il diletto abbondano in essa e l’unica sua attività consiste in uno sguardo pieno d’amore per Dio, senza cercare di sentire o di volere qualcos’altro. Così, dunque, Dio le si comunica passivamente, proprio come la luce si comunica a chi ha gli occhi aperti e il cui unico sforzo è quello di tenerli aperti per riceverla. Ricevere la luce che si comunica soprannaturalmente significa che l’anima comprende passivamente. Quando si dice che essa che essa non agisce, non significa che non comprenda, ma che comprende cose che non richiedono la sua capacità, bensì solo la disponibilità a ricevere ciò che le viene dato, come accade per le illuminazioni, le illustrazioni o le ispirazioni divine.
3. Sebbene in questo stato la volontà riceva gratuitamente questa conoscenza generale e confusa di Dio, per avere più semplicemente e abbondantemente questa luce divina è necessario solo che s’impegni a non interporvi altre luci più palpabili di altre conoscenze, forme o immagini di qualsiasi genere, perché niente di tutto questo somiglia a quella luce delicata e pura di Dio. Per questo, se l’anima volesse allora comprendere e meditare cose particolari, anche se spirituali, creerebbe ostacolo alla luce limpida, semplice e generale dello spirito, frapponendole come delle nubi. Somiglierebbe a colui che ha davanti agli occhi qualche ostacolo che gli impedisce di vedere la luce e di spingere più oltre lo sguardo.
4. Risulta quindi chiaro che, quando l’anima sarà completamente purificata e libera da tutte le forme o immagini percepibili, s’immergerà in questa luce pura e semplice, trasformandosi in essa fino allo stato di perfezione. Difatti questa luce non manca mai all’anima, però non le si comunica in presenza delle forme e dei veli delle creature, da cui è avvolta e impedita. Se l’anima si libererà da questi ostacoli, completamente, come dirò più avanti, si ritroverà nel puro spogliamento e nella povertà di spirito. Divenuta semplice e pura, essa si trasformerà nella semplice e pura Sapienza, che è il Figlio di Dio. Quando nell’anima innamorata viene a mancare ciò che è naturale, immediatamente penetra n essa il divino, in un modo naturale e soprannaturale, perché non si abbia il vuoto della natura.
5. La persona spirituale impari a starsene in un’attenzione amorosa per Dio e conservi il suo intelletto nella pace, quando non può meditare, anche se ha l’impressione di non fare nulla. Così, a poco a poco, e molto presto, le verranno infusi riposo e pace divina, con meravigliose e sublimi conoscenze di Dio, pregne del suo amore. E non si avvalga di idee, meditazioni, immagini o ragionamenti, per non turbare la sua anima e strapparla dalla sua gioia e pace. Ciò significherebbe procurarle disgusto e ripugnanza. Se, come ho detto, avesse lo scrupolo di non fare nulla, ricordi che non è poca cosa calmare la sua anima e conservarla nel riposo e nella pace, libera da ogni attività e preoccupazione. Ciò è quanto ci chiede anche il Signore per bocca di Davide: Vacate, et videte quoniam ego sum Deus (Sal 45,11), cioè: Imparate ad essere spogli di tutte le cose, sia interiormente che esteriormente, e vedrete che io sono Dio.
CAPITOLO 16
Ove si parla delle percezioni immaginarie che si presentano soprannaturalmente alla fantasia. Si afferma che non possono essere per l’anima un mezzo immediato per l’unione con Dio.
1. Dopo aver trattato delle percezioni che possiamo avere per via naturale e intorno alle quali lavorano la fantasia e l’immaginazione con l’aiuto del ragionamento, passo ora a trattare di quelle soprannaturali, che si chiamano visioni immaginarie, appunto perché, costituite da immagini, forme e figure, entrano nell’ambito di questi sensi, né più né meno di quelle prodotte per via naturale.
2. Ora va osservato che sotto il nome di visioni immaginarie si vogliono includere tutte le cose che possono presentarsi soprannaturalmente alla fantasia come immagini, forme, figure o specie. Infatti le percezioni e le immagini che i cinque sensi corporali producono nell’anima, in cui trovano la loro sede, possono verificarsi e stabilirsi in essa anche per via soprannaturale senza il concorso dei sensi esterni. In effetti, il senso della fantasia, insieme alla memoria, è come un archivio o deposito dell’intelletto, in cui vengono accolte tutte le forme e immagini intelligibili: al pari di uno specchio, la fantasia le conserva in sé, dopo averle ricevute dai cinque sensi oppure, come ho detto, per via soprannaturale. Le presenta poi all’intelletto, che a sua volta le analizza e le giudica. La fantasia può, inoltre, comporre e formare altre immagini simili a quelle che già conosce.
3. Si tenga presente che, come i cinque sensi esterni offrono a quelli interni le immagini e le forme dei loro oggetti, così – ripeto – sia Dio che il demonio possono, soprannaturalmente e senza il concorso dei sensi esterni, produrre le stesse immagini e forme, anzi di più belle e perfette. Dio, servendosi di queste immagini, spesso rivela all’anima molte cose e le insegna una profonda sapienza, come si legge in ogni pagina della sacra Scrittura. Isaia (6,2-4), per esempio, vide Dio nella sua gloria circondato dal fumo che riempiva il tempio e dai serafini che si coprivano il volto e i piedi con lei ali; Geremia (1,11) vide la verga che vigilava e Daniele (7,10) ebbe moltissime visioni, ecc. Anche il demonio cerca d’ingannare l’anima con le sue – apparentemente buone – manifestazioni, come si legge nel primo libro dei Re, quando ingannò tutti i profeti di Acab: mostrò alla loro immaginazione i corni con cui, affermava, avrebbe distrutto gli assiri; e invece mentiva (1Re 22,11). Si potrebbero qui ricordare anche le visioni che ebbe la moglie di Pilato (Mt 27,19), perché questi non condannasse Cristo, e molti altri episodi. Da ciò risulta che nello specchio della fantasia e dell’immaginazione tali visioni immaginarie si presentano ai proficienti più frequentemente di quelle corporee esterne. Come ho detto, le visioni immaginarie non si differenziano, quanto alla forma e alla rappresentazione, da quelle provenienti dai sensi esterni. Sono, invece, molto diverse quanto all’effetto che producono e alla loro perfezione, perché sono più sottili e producono nell’anima un effetto più profondo, in quanto soprannaturali e più interiori di quelle soprannaturali provenienti dai sensi esterni. Ciò non toglie, tuttavia, che alcune delle visioni corporee esterne producano un effetto maggiore; in fondo, Dio si comunica all’anima come gli pare e piace. Ma voglio soltanto dire che tali visioni, in quanto spirituali, sono generalmente più efficaci.
4. Ordinariamente il demonio per i suoi inganni, sia naturali che soprannaturali, si serve dei sensi dell’immaginazione e della fantasia. Essi, infatti, sono la porta d’entrata nell’anima e qui, come ho detto, l’intelletto attinge, quasi fosse un porto o un luogo dove prendere e deporre le sue provviste. Per questo, sia Dio che il demonio sono solleciti nell’offrire all’intelletto le pietre preziose delle loro immagini e forme soprannaturali. Tuttavia Dio non ricorre solo a questo mezzo per istruire l’anima, ma, dimorando sostanzialmente in essa, può fare ciò in modo diretto e con altri mezzi.
5. Non è ora il caso che mi dilunghi a descrivere i segni per riconoscere quali visioni provengano da Dio e quali no, e i diversi modi in cui esse avvengano. Il mio intento, infatti, non è questo, ma soltanto mostrare che l’intelletto deve stare attento affinché le visioni provenienti da Dio non gli siano d’impedimento o di ostacolo all’unione con la divina Sapienza, e le false non lo traggano in inganno.
6. Per questo dico che l’intelletto non deve lasciarsi ingombrare né tanto meno deve nutrirsi di tutte queste percezioni e visioni immaginarie o di qualsiasi altra rappresentazione che gli si presenti sotto una forma, figura o conoscenza particolare, siano esse false e provenienti dal demonio o sicuramente vere perché provenienti da Dio. L’anima non deve accoglierle né trattenerle, ma rimanerne distaccata, spoglia, pura e semplice, senza alcuna forma o modalità, come si richiede per l’unione con Dio.
7. Questo perché tutte le forme suddette, nel momento in cui vengono percepite, si presentano sempre – ripeto – sotto forme e modi limitati, mentre la Sapienza di Dio, alla quale deve unirsi l’intelletto, non ha forma né modo speciali; essa non soggiace ad alcun limite, né tanto meno è contenuta in una conoscenza distinta e particolare, perché è totalmente pura e semplice. Per unire due estremi, come quelli dell’anima e della Sapienza divina, è necessario che vi sia tra loro una certa somiglianza; perché l’anima si unisca alla Sapienza divina, dev’essere pura e semplice, non limitata né legata ad alcuna conoscenza particolare, né modificata dai limiti di forme, specie o immagini. Dio non può essere contenuto in alcuna immagine o forma né in una cognizione particolare; per questo, se l’anima vuole unirsi a lui, non dev’essere assoggettata a una forma o conoscenza distinta.
8. Che in Dio non esista forma né somiglianza, lo fa ben capire lo Spirito Santo nel libro del Deuteronomio quando afferma: Vocem verborum eius audistis, et formam penitus non vidistis: Voi udivate il suono delle parole, ma non vedevate alcuna figura (Dt 4,12). Aggiunge che c’erano tenebre, nuvole e oscurità (Dt 4,11), cioè questa conoscenza confusa e oscura di cui sto parlando, nella quale l’anima si unisce a Dio. Poco più avanti dice: Non vidistis aliquam similitudinem in die, qua locutus est vobis Dominus in Horeb de medio ignis, cioè: Non vedeste alcuna figura, quando il Signore vi parlò sull’Oreb dal fuoco (Dt 4,15).
9. Che l’anima non possa giungere fino alle altezze di Dio, nei limiti concessi in questa vita, per mezzo di figure e immagini, ce lo ricorda ancora la sacra Scrittura nel libro dei Numeri. Ivi si legge che Dio rimproverò Aronne e Maria perché avevano mormorato contro Mosè, loro fratello, per far loro comprendere a qual grado di unione e di amicizia lo aveva elevato. Disse loro così: Si quis inter vos fuerit propheta Domini, in visione apparebo ei, vel per somnium loquar ad illum. At non talis servus meus Moyses, qui in omni domo mea fidelissimus est: ore enim ad os loquor ei, et palam, et non per aenigmata et figuras Dominum videt, che significa: Se ci sarà un vostro profeta, io, il Signore, in visione a lui mi rivelerò, in sogno parlerò con lui. Non così per il mio servo Mosè: egli è l’uomo di fiducia in tutta la mia casa. Bocca a bocca parlo con lui, in visione e non con enigmi, ed egli guarda l’immagine del Signore (Nm 12,6-8). Questo testo ci fa chiaramente comprendere che nell’eccelso stato di unione, di cui sto parlando, Dio non si comunica all’anima sotto i veli di visioni immaginarie, di somiglianze o di figure, ma bocca a bocca: cioè l’essenza pura e semplice di Dio, che è come la sua bocca per amore, si comunica all’essenza pura e semplice dell’anima, che è come la sua bocca per amore di Dio.
10. Pertanto, per giungere a quest’unione d’amore di Dio essenziale, l’anima deve fare attenzione a non attaccarsi a queste visioni immaginarie, forme, rappresentazioni o conoscenze particolari, che non possono essere un mezzo adeguato e immediato per tale scopo; anzi le sarebbero d’impedimento; deve quindi rinunciare ad esse e cercare di evitarle. L’unico motivo per cui potrebbero essere accettate e apprezzate sarebbe quello del profitto e degli effetti buoni che le visioni vere producono nell’anima. Ma anche in questo caso è bene non accettarle, anzi conviene, per maggiore profitto, negarle sempre. Infatti il bene che queste visioni immaginarie possono operare nell’anima, insieme a quelle corporee esterne di cui si è parlato, consiste nel comunicare conoscenza, amore e dolcezza. Ora, perché producano questi effetti, non è necessario che l’anima le voglia accettare, come ho detto sopra. Le visioni li producono nel momento stesso in cui si presentano all’immaginazione; esse fanno sentire la loro presenza all’anima e le infondono conoscenza, amore, soavità o qualsiasi altra cosa voluta da Dio. Tale effetto viene prodotto nell’anima non solo simultaneamente, ma sostanzialmente, quantunque in momenti diversi, e passivamente, senza che essa possa impedirlo, anche se volesse. Del resto, prima non aveva potuto acquisirlo da sola, anche se dovette lavorare per disporsi a riceverlo. Prendiamo come esempio la vetrata. Come questa non può impedire al raggio di sole di penetrarla, e da esso viene illuminata, passivamente, senza suo concorso se non offrire la sua trasparenza, così l’anima, anche se volesse resistere, non potrebbe non ricevere gli influssi e le comunicazioni di tali visioni. Difatti alle visioni soprannaturali infuse non può resistere la volontà contraria, umile e piena di amore, ma solo l’impurità e l’imperfezione dell’anima, come le macchie sulla vetrata sono di ostacolo alla luce del sole.
11. È chiaro, quindi, che quanto più l’anima si spoglia, secondo la volontà e l’attaccamento, delle conoscenze e delle macchie causate da quelle forme, immagini e figure, con cui sono avvolte le comunicazioni spirituali di cui ho detto, non solo non si priva di tali comunicazioni e dei benefici che ne derivano, ma molto meglio si dispone ad accoglierle con abbondanza, chiarezza e libertà di spirito e semplicità, quando mette da parte tutte quelle conoscenze, perché sono cortine e veli che coprono la parte spirituale in esse contenuta. Se, al contrario, l’anima volesse nutrirsi di tali visioni, queste occuperebbero lo spirito e i sensi, tanto che non avrebbe più la semplicità e la libertà per ricevere simili comunicazioni. Tutto occupato nella corteccia, l’intelletto non avrebbe la libertà di ricevere lo spirito di quelle forme. Pertanto, se l’anima vuole accettare queste visioni e tenerle in conto, se ne ingombra e si contenta di quanto meno importante esse contengono, ossia di tutto quello che essa può afferrarne o conoscerne, come forma, immagine e conoscenza particolare. Difatti, quanto alla parte principale, cioè al bene spirituale che le viene infuso, l’anima non può afferrarlo o comprenderlo; non sa né saprà dire cosa sia, perché è un favore prettamente spirituale. Essa conosce soltanto ciò che di meno importante v’è in esse e secondo il suo modo d’intendere, cioè le forme sensibili. Per questo dico che di quelle visioni le viene comunicato ciò che essa non potrebbe comprendere né immaginare, e tutto ciò passivamente, senza che essa vi applichi o sappia applicarvi la sua capacità di comprensione.
12. L’anima deve, quindi, rifiutare sempre tutte le percezioni che essa può vedere e sentire distintamente, perché la comunicazione dei sensi non è un fondamento sicuro come la fede. Al contrario, deve fissare la sua attenzione non su ciò che appartiene ai sensi ma allo spirito, non su ciò che cade sotto immagini sensibili ma su ciò che porta all’unione nella fede, la quale, come ho detto, ne costituisce il mezzo adatto. Così l’anima trarrà profitto per la sua fede da ciò che di sostanziale c’è in queste visioni, quando saprà rinunciare completamente a ciò che in esse c’è di sensibile e d’intelligibile e, rifiutandole, le userà bene in vista del fine che Dio ha voluto nel comunicargliele. Infatti, come si diceva parlando delle visioni corporee, Dio non le concede all’anima perché essa desidera averle e nemmeno affinché ponga in esse il suo attaccamento.
13. Ma a questo punto sorge un dubbio: se è vero che Dio concede all’anima visioni soprannaturali non perché essa le desideri, vi si attacchi o le apprezzi, allora per quale altra ragione gliele concede? Infatti l’anima, con simili comunicazioni, può cadere in molti errori e pericoli o perlomeno negli inconvenienti descritti che le impediscono di progredire. In realtà Dio potrebbe dare e comunicare spiritualmente e sostanzialmente ciò che invece, attraverso i sensi, le comunica in queste visioni e immagini sensibili.
14. Risponderò a questo dubbio nel capitolo seguente, perché si tratta di una dottrina importante, anzi fondamentale, secondo me, sia per le persone spirituali sia per coloro che le guidano. Ivi s’indicherà il modo di agire e il fine che Dio in quelle cose si prefigge; proprio perché molti ignorano tutto ciò, non sanno governarsi e non sanno guidare se stessi né gli altri verso l’unione divina. Pensano in realtà che, per il solo fatto che tali visioni sono vere e vengono da Dio, sia bene accettarle e basarsi su di esse, non considerando che pure in esse l’anima può nutrire spirito di possesso, attaccamento e ostacolo, allo stesso modo delle cose del mondo, se non saprà rinunciarvi. Crederanno bene accogliere quelle buone e respingere le altre, mettendo se stessi e le anime in grandi difficoltà e gravi pericoli, perché dovranno discernere tra le visioni vere e quelle false. Ma Dio non vuole che vengano a trovarsi in tali situazioni, né prescrive loro di esporre le anime semplici e umili a questi pericoli e incertezze. Essi, cioè coloro che le guidano, hanno una dottrina sana e sicura, che è la fede, con cui possono certamente andare avanti.
15. Per questo motivo occorre chiudere gli occhi a tutto ciò che viene dai sensi, come pure alle conoscenze chiare e particolari. Anche Pietro, pur essendo certissimo d’aver avuto una visione della gloria di Cristo nella trasfigurazione, tuttavia – dopo averla riportata nella sua seconda lettera – non volle che fosse presa come principale argomento di certezza. Per raccomandare la fede aggiunse: Et habemus firmiorem propheticum sermonem: cui benefacitis attendentes, quasi lucernae lucenti in caliginoso loco, donec dies elucescat, ecc.: Ma abbiamo una parola ancor più sicura, quella dei profeti, alla quale fate bene a prestare attenzione, come a lampada che brilla in luogo oscuro (2Pt 1,19). Quest’ultimo paragone, se ci riflettiamo bene, racchiude la dottrina che sto illustrando. Quando si dice di guardare alla fede, di cui parlarono quei profeti, come a lampada che brilla in luogo oscuro, si dice che dobbiamo tenerci al buio, chiudendo gli occhi a tutte le luci della terra e che, in queste tenebre, solo la fede, anch’essa oscura, è la luce a cui dobbiamo aggrapparci. Se, invece, vogliamo basarci su altre luci o conoscenze chiare e distinte, cessiamo di aggrapparci alla luce oscura della fede, che non ci offre più la sua luce in questo luogo oscuro di cui parla san Pietro. Questo luogo significa l’intelletto, che è il candeliere su cui poggia la candela della fede; esso deve rimanere oscuro fino a quando, nell’altra vita, spunterà il giorno della chiara visione di Dio e, in questa, quello della trasformazione e dell’unione con Dio, verso cui l’anima s’incammina.
CAPITOLO 17
Ove si spiegano il fine e il modo in cui Dio comunica all’anima i beni spirituali tramite i sensi, e si risponde al dubbio esposto sopra.
1. Molto c’è da dire sul fine e sul modo in cui Dio concede queste visioni. Egli vuole elevare l’anima dalla sua bassezza fino all’unione divina, di cui parlano tutti i libri spirituali, compreso questo. Perciò, nel presente capitolo, dirò soltanto ciò che serve per rispondere al nostro dubbio che era: dal momento che in queste visioni soprannaturali si nascondono tanti pericoli e molti ostacoli per andare avanti, come ho detto, perché Dio, che è sapientissimo e propenso a liberare le anime da ostacoli e insidie, le offre e le comunica?
2. Prima di rispondere, occorre ricordare tre principi fondamentali. Il primo è tratto dalla lettera ai Romani di san Paolo, ove si dice: Quae autem sunt, a Deo ordinata sunt, cioè: Le cose che esistono sono state ordinate da Dio (Rm 13,1). Il secondo è tratto dal libro della Sapienza, ove lo Spirito dice: Disponit omnia suaviter (Sap 8,1), come a dire: la sapienza di Dio, benché si estenda da un confine all’altro, cioè da un estremo all’altro, governa con bontà eccellente ogni cosa. Il terzo, che viene offerto dai teologi, recita così: omnia movet secundum modum eorum, cioè: Dio muove tutte le cose secondo la loro natura.
3. Secondo questi principi fondamentali è, quindi, chiaro che Dio, per muovere ed elevare l’anima dal limite estremo della sua bassezza al vertice sublime della sua grandezza nell’unione con lui, lo fa con ordine, con soavità e secondo la natura di quest’anima. Ora, poiché l’ordine seguito dalle persone nella conoscenza passa attraverso le forme e le immagini delle cose create, e il modo di conoscere e di apprendere passa attraverso i sensi, Dio per elevare l’anima alla somma conoscenza deve, agendo con soavità, cominciare a muoverla dall’estrema bassezza dei sensi ed elevarla, secondo la sua natura, verso l’altro estremo, quello della sapienza spirituale, che non cade sotto i sensi. Per questo Dio la eleva pian piano, prima istruendola per mezzo di forme, immagini e cose sensibili, sia naturali che soprannaturali, conformi al suo modo di apprendere, e poi attraverso meditazioni discorsive, fino a portarla alla somma grandezza del suo spirito.
4. Questo è il motivo per cui Dio le comunica visioni, rappresentazioni, immagini e altre conoscenze sensibili e intelligibili spirituali. Questo non vuol dire che egli non voglia darle immediatamente, dal primo atto, la sapienza dello spirito. Lo farebbe se i due estremi, quello umano e quello divino, il senso e lo spirito, potessero per via ordinaria congiungersi e fondersi in un unico atto, senza l’intervento di altri atti preparatori che con ordine e soavità possono congiungersi tra loro, facendo gli uni da fondamento e preparazione per gli altri, come gli agenti naturali. E così le prime disposizioni servono alle seconde, le seconde alle terze e via di seguito. Allo stesso modo, Dio va perfezionando l’uomo secondo la sua stessa natura, cominciando dal più basso ed esteriore per arrivare al più alto e interiore. Egli lo perfeziona, dunque, prima nei sensi del corpo, spingendolo a far buon uso degli oggetti dell’ordine naturale, esterni ma eccellenti, come ascoltare prediche, partecipare alla messa, guardare cose sante, mortificare il gusto nel mangiare, mortificare il tatto attraverso il santo rigore della penitenza. Quando questi sensi sono sufficientemente disposti, suole perfezionarli ulteriormente. Accorda ad essi favori soprannaturali e doni per confermarli sempre più nel bene, offrendo loro comunicazioni soprannaturali, come, ad esempio, visioni di santi o di cose sante corporee, profumi e locuzioni soavissime o un grandissimo diletto nel tatto. Attraverso simili favori i sensi vengono confermati nella virtù e liberati dal desiderio degli oggetti cattivi. Oltre a questo, Dio perfeziona a poco a poco anche i sensi corporali interni, di cui sto parlando, cioè l’immaginazione e la fantasia; li abitua al bene con considerazioni, meditazioni e santi discorsi, istruendo così lo spirito. Quando la persona è ormai disposta grazie a questo esercizio naturale, Dio è solito illuminarla e spiritualizzarla ulteriormente con alcune visioni soprannaturali, che sono quelle che si chiamano immaginarie, nelle quali, come ho detto, lo spirito trova grande giovamento; nelle une e nelle altre, infatti, viene dirozzato e riformato a poco a poco. In questo modo Dio eleva gradualmente l’anima, conducendola verso ciò che è più interiore. Non che sia sempre necessario conservare rigidamente quest’ordine di priorità, come è presentato qui. A volte Dio si serve di alcuni mezzi e non di altri, passa dal più interiore al meno interiore, o accorda i suoi favori tutti in una volta. Egli agisce secondo ciò che è bene per l’anima e secondo come vuole concederle i favori. Ma la via ordinaria è quella che ho esposto.
5. In questo modo, dunque, Dio va istruendo e rendendo spirituale l’anima. Comincia a comunicarle la vita spirituale partendo dalle cose esterne, palpabili e adeguate ai sensi, secondo la limitatezza e la poca capacità dell’anima. Attraverso la mediazione della corteccia di queste cose sensibili, di per sé buone, la spinge a emettere atti particolari e a ricevere ogni volta tante piccole comunicazioni spirituali. Così, a poco a poco, essa acquisterà l’abitudine di ciò che è spirituale e conseguirà la sostanza della vita spirituale, del tutto estranea ai sensi. Ma, come ho detto, l’anima potrà giungervi solo a poco a poco, a modo suo, attraverso i sensi, a cui è sempre legata. A mano a mano che si avvicina alla vita dello spirito nel suo rapporto con Dio, si spoglia e si libera dei mezzi sensibili, cioè della meditazione discorsiva e immaginaria. Perciò, quando giungerà a trattare con Dio in un modo perfettamente spirituale, essa sarà necessariamente spogliata di tutto ciò che riguardo a Dio può cadere sotto i sensi. Difatti, quanto più una cosa si avvicina a un estremo, tanto più si allontana e si estrania dall’altro estremo, e quanto più perfettamente aderisce all’uno, tanto più è distaccata dall’altro. Dice un adagio spirituale: Gustato spiritu, desipit omnis caro, che significa: Una volta gustate le dolcezze dello spirito, l’anima trova insipido tutto ciò che viene dalla carne: cioè tutte le vie della carne, che rappresentano ogni tipo di relazione dei sensi con lo spirito, non giovano e non procurano soddisfazione alcuna. Ciò è evidente, perché se è spirito non cade più sotto i sensi, e se può essere afferrato dai sensi allora non è puro spirito. Quanto più i sensi e le facoltà naturali possono sapere dello spirito, tanto meno questo è spirituale e soprannaturale, come si deduce da ciò che è stato detto finora.
6. Pertanto la persona spirituale che ha raggiunto la perfezione non tiene più conto dei sensi, né riceve cosa alcuna per loro tramite, né soprattutto si serve o ha bisogno di servirsi di essi per andare a Dio, come faceva prima quando non era avanzata nella vita spirituale. Questo vuol farci intendere quel passo di san Paolo nella lettera ai Corinzi: Cum essem parvulus, loquebar ut parvulus, sapiebam ut parvulus, cogitabam ut parvulus. Quando autem factus sum vir, evacuavi quae erant parvuli, che significa: Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma divenuto uomo, ciò che era da bambino l’ho abbandonato (1Cor 13,11). Ho già spiegato come le cose relative ai sensi e alla conoscenza che lo spirito può cogliere siano esercizi infantili. Perciò, se l’anima vorrà attaccarvisi per sempre senza mai distogliersene, non cesserà di essere come un bambino e parlerà di Dio sempre come un bambino, penserà a Dio come un bambino. E poiché essa si ferma alla scorza, ai sensi, il che è proprio dei bambini, non arriverà mai alla sostanza dello spirito, che è proprio dell’uomo perfetto. Per poter crescere, dunque, l’anima non dovrà ricercare le rivelazioni di cui parliamo, anche se offerte da Dio. È simile al bambino che deve lasciare il seno materno per abituare il suo palato a un cibo più forte e sostanzioso.
7. Ma ora mi si chiederà: non sarà forse necessario che l’anima, finché è piccola, riceva tali rivelazioni e le abbandoni solo quando sarà cresciuta, così come è necessario al bambino succhiare al seno materno per nutrirsi, fino a quando sarà cresciuto e potrà farne a meno? Rispondo che, se si tratta della meditazione e dell’esercizio del discorso naturale con cui l’anima comincia a cercare Dio, è vero che non deve abbandonare questo mezzo sensibile per potersi nutrire. Essa deve continuare così fino al momento in cui può farlo, cioè sino a quando Dio la introdurrà in un rapporto con sé più spirituale, ossia nella contemplazione, di cui ho già parlato nel capitolo 13 di questo libro. Ma quando si tratta di visioni immaginarie o di altre comunicazioni soprannaturali che possono cadere sotto i sensi, indipendentemente dalla volontà dell’uomo, affermo che in qualsiasi momento, sia nello stadio perfetto che in quello meno perfetto, anche se vengono da Dio, l’anima non deve volerle, per due motivi. Primo perché, come ho detto, tali visioni producono nell’anima il loro effetto senza che essa possa impedirlo, pur potendo impedire e impedisca di fatto la visione stessa, come accade spesso. Di conseguenza, l’effetto che tale visione doveva provocare nell’anima viene prodotto in essa in un modo più sostanziale, anche se per un’altra via. L’anima infatti, ripeto, non può allontanare i favori che Dio vuole comunicarle, a meno che non vi sia qualche imperfezione o spirito di possesso. Ora, se essa rinuncia a queste cose in umiltà, diffidando di sé, non c’è alcuna imperfezione o spirito di possesso. In secondo luogo, l’anima si libera dal pericolo e dalla fatica che c’è nel discernere le visioni buone da quelle false e nel riconoscere se sono prodotte dall’angelo della luce o da quello delle tenebre. Ciò non procura alcun giovamento, ma fa solo perdere tempo, crea ostacoli all’anima, la mette nell’occasione di molte imperfezioni, le impedisce di progredire, occupandola in cose che non sono del suo stato, liberandola cioè da queste minuzie di visioni e di conoscenze particolari, come ho detto a proposito delle visioni corporee e di quelle di cui parlerò più avanti.
8. Dobbiamo convincerci che se il Signore non elevasse l’anima secondo la sua stessa natura, come dirò, non le comunicherebbe mai l’abbondanza del suo spirito mediante canali così stretti quali sono le forme, le figure e le conoscenze particolari, attraverso cui, appunto, le offre delle briciole per sostenerla. Per questo Davide dice: Mittit crystallum suam sicut buccellas: Getta come briciole la sua grandine (Sal 147,17), come a dire: invia la sua sapienza alle anime quasi a bocconi. È cosa veramente triste che l’anima, pur avendo una capacità infinita, venga nutrita con le briciole dei sensi, a causa del suo poco spirito e della sua scarsa sensibilità. Anche san Paolo si rammarica di questa poca disposizione e dell’inettitudine a ricevere i doni spirituali, quando scrive ai cristiani di Corinto: Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma come ad esseri carnali, come a neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non un nutrimento solido, perché non ne eravate capaci. E neanche ora lo siete: Tamquam parvulis in Christo lac potum vobis dedi, non escam (1Cor 3,1-2).
9. Occorre, dunque, ricordare che l’anima non deve porre attenzione alla scorza delle immagini e degli oggetti che le vengono presentati soprannaturalmente. Si terrà distaccata da tutto ciò che le verrà dai sensi esterni, come le locuzioni e le parole che colpiscono l’udito, le visioni di santi e gli splendori affascinanti che colpiscono gli occhi, i profumi che lusingano le narici, i gusti soavi del palato e altri piaceri del tatto, tutte sensazioni che in generale procedono dallo spirito e che ordinariamente accadono alle persone spirituali. Tanto meno dovrà soffermarsi su visioni dei sensi interiori, come le visioni immaginarie, ma respingerle tutte. Deve fissare lo sguardo solo sullo spirito buono che producono, cercando di conservarlo nelle opere e nella pratica ordinata di tutto ciò che riguarda il servizio di Dio, senza badare a quelle manifestazioni e senza cercare alcun gusto sensibile. In tal modo l’anima prenderà da tali comunicazioni solo ciò che Dio intende e vuole, cioè lo spirito di devozione, che è il fine principale per cui egli le concede. Lascerà quanto Dio non darebbe, se fosse possibile riceverle nello spirito senza quest’esercizio, cioè come ho detto, senza tali comunicazioni che passano attraverso i sensi.
CAPITOLO 18
Ove si parla del danno che certi direttori spirituali possono recare alle anime non guidandole con sano criterio per quanto riguarda le suddette visioni. Si mostra, inoltre, come tali visioni, pur venendo da Dio, possono indurre in errore.
1. Sull’argomento delle visioni non posso essere breve come vorrei, perché c’è molto da dire. Sebbene sia stato detto, in sostanza, quanto era necessario per far capire alla persona spirituale come deve comportarsi in queste visioni e al direttore cha la guida come deve trattarla in questi casi, non sarà superfluo approfondire ulteriormente questa dottrina. In questo modo si chiariranno meglio i danni che potranno venire sia alle persone spirituali che ai loro direttori, se presteranno troppa attenzione a quei fenomeni, anche quando venissero da Dio.
2. Il motivo che ora mi spinge a trattenermi ancora sull’argomento è la poca discrezione che ho avuto occasione di rilevare, a tale riguardo, in alcuni maestri spirituali. Costoro, ritenendosi sicuri su queste comunicazioni soprannaturali, convinti che siano buone e provenienti da Dio, sono caduti, insieme ai loro discepoli, in gravi errori e hanno dato prova di grande incapacità. Danno ragione alla seguente sentenza del Salvatore: Si caecus caeco ducatum praestet, ambo in foveam cadunt: Quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadono in un fosso! (Mt 15,14). Non dice che cadranno, ma che cadono; in realtà non occorre cadere in errore perché ci sia caduta effettiva: il solo azzardarsi a condursi a vicenda è un errore, e già almeno in questo sbagliano. Difatti vi sono alcuni che con le anime favorite da queste visioni adottano un comportamento e un modo di fare tali da indurle nell’errore e nello scompiglio, oppure non le guidano lungo la via dell’umiltà, o le inducono in qualche modo a rivolgere l’attenzione ad esse. Di conseguenza, tali anime restano senza un vero spirito di fede e non vengono stabilite in esso, perché questi maestri fanno lunghi discorsi su tali fenomeni. Così fanno capire che ne hanno una grande stima e vi annettono molta importanza. Le anime fanno altrettanto: si attaccano ai quei fenomeni e non hanno per fondamento la fede, né si tengono sgombre, spoglie e distaccate da tutto ciò che impedisce loro di spiccare il volo verso le altezze della fede oscura. Tutto questo deriva dal comportamento e dal linguaggio che l’anima osserva nel suo direttore a tale riguardo. D’altronde non riesco a capire come essa giunga con grande facilità ad avere una stima incondizionata di tali visioni e a distogliere lo sguardo dall’abisso della fede.
3. Questa facilità deriva certamente dal fatto che l’anima è tutta presa da queste visioni. Poiché si tratta di fenomeni che passano attraverso i sensi e verso i quali è incline per natura, e dato che vi prova gusto ed è disposta a queste conoscenze di cose distinte e sensibili, basta che si accorga che il suo confessore o qualche altra persona le stima o vi annette un certo valore, perché faccia altrettanto; inoltre, senza che essa se ne accorga, prende sempre più gusto e si nutre sempre più di queste visioni e si sente sempre più incline e attaccata ad esse. Da ciò derivano quanto meno molte imperfezioni. L’anima non è più tanto umile; pensa che queste visioni abbiano qualche pregio, che essa valga qualcosa, che Dio l’abbia in considerazione; è contenta e soddisfatta di sé. Ma tutto questo è contrario all’umiltà. Presto il demonio ne approfitta per accrescere segretamente questo suo sentimento, senza che essa se ne accorga, e comincia a istillarle sul conto degli altri un certo modo di giudicare: se abbiano o meno tali favori, se siano o no gli stessi che ha lei. Tutto questo è contrario alla santa semplicità e alla solitudine interiore.
4. Ma oltre a questi danni e al fatto che tali anime non crescono nella fede se non si liberano da tali pensieri, vi sono altri danni, in tale comportamento, più sottili e più odiosi agli occhi di Dio, sebbene non così palpabili ed evidenti come i primi, perché impediscono all’anima di conseguire il perfetto spogliamento di sé. Ma tralascio ora tale argomento, per riprenderlo quando parlerò del vizio della gola spirituale e degli altri sei. Ivi, con l’aiuto di Dio, verranno trattate molte di queste macchie sottili e delicate che sporcano lo spirito, perché non si è in grado di guidarlo allo spogliamento.
5. Per adesso mi limito a dire qualcosa sul comportamento che devono assumere certi confessori incapaci di dirigere bene le anime. Naturalmente vorrei sapermi spiegare. Riconosco che è difficile far capire come lo spirito del discepolo si vada formando in modo intimo e segreto sul modello del suo padre spirituale. Temo, altresì, di affrontare questo argomento così vasto, perché sembra che non si possa spiegare un punto senza far capire bene anche l’altro. Del resto, poiché si tratta di realtà spirituali, sono intimamente legate tra loro.
6. Per quanto riguarda il nostro argomento, secondo me, le cose stanno così: se il padre spirituale è incline alle rivelazioni, tanto da attribuire loro importanza e provarne gusto, non potrà non istillare nel discepolo, seppure inconsapevolmente, questo suo stesso atteggiamento, a meno che il discepolo non sia più avanti di lui nella via della perfezione. Ma anche in questo caso il discepolo potrà ricevere grande danno se rimane sotto la sua direzione. Dall’inclinazione del padre spirituale e dal piacere che questi prova per tali visioni, nascerà in lui una certa stima. Se non sta molto attento, non mancherà di dar segni di apprezzamento al discepolo. Se poi quest’ultimo ha la stessa disposizione di spirito, non mancherà, secondo me, di nutrire come il maestro una grande stima per queste manifestazioni.
7. Ma non scendo ora in troppi particolari. Parlo, invece, del confessore, incline o meno verso queste visioni, che non ha la prudenza necessaria per distogliere il discepolo da tali manifestazioni e condurlo al distacco. Anzi si mette a parlarne con lui e, come ho detto, ne fa oggetto di conversazioni spirituali, fornendogli indizi per discernere le buone dalle false visioni. Anche se è bene operare questo discernimento, tuttavia non c’è motivo di porre l’anima in questi imbarazzi, preoccupazioni e pericoli. Quando, al contrario, non si prendono in considerazione o si respingono queste visioni, si evitano i suddetti inconvenienti e si compie il nostro dovere. Ma non è tutto. Certi direttori, quando vedono che alcune anime hanno queste visioni da Dio, chiedono loro di supplicare il Signore affinché riveli cose che riguardano la loro o altrui persona. E queste anime sciocche obbediscono, pensando che sia lecito chiedere tali cose per questa via: poiché Dio, secondo come desidera e per lo scopo che si è prefisso, vuole rivelare o comunicare qualcosa in modo soprannaturale, esse credono che sia lecito desiderare e anche chiedergli di rivelare tale cosa.
8. Se talvolta accade che Dio esaudisca la loro richiesta, tali anime si sentono ancora più rassicurate, pensando che il Signore, per il fatto stesso che risponde, si compiaccia e lo voglia. Ma in realtà Dio non gradisce questo né lo vuole. Quanto a esse, molto spesso agiscono e credono secondo quanto è stato loro rivelato o risposto. Essendo affezionate a questo modo di trattare con Dio, vi si attaccano molto e vi si adattano volentieri. Naturalmente se ne compiacciono e vi si accomodano secondo il loro modo di vedere; così molto spesso sbagliano e, vedendo che le cose non vanno come avevano pensato, si meravigliano. Immediatamente sorge il dubbio se erano o non erano da Dio, perché non le vedono accadere come si aspettavano. In fondo erano persuase di due cose: anzitutto, che tali favori provenissero da Dio, dal momento che penetravano in loro con tanta forza, mentre, come ho detto, possono provenire dalla natura incline a simili comunicazioni; in secondo luogo, che venendo da Dio tali rivelazioni si sarebbero dovute verificare come le avevano immaginate o pensate.
9. Questo è un grande sbaglio, perché le rivelazioni o le locuzioni divine non sempre si verificano come gli uomini le immaginano o come sono in sé. Non devono quindi basarsi su di esse né credervi ciecamente, anche quando si tratta di rivelazioni, risposte o parole di Dio. Difatti, anche se possono essere sicure e vere in sé, non sempre lo sono nelle loro cause e nel nostro modo di comprenderle, come mostrerò nel capitolo seguente. Ivi dirò e proverò, altresì, come Dio, pur rispondendo talora, in modo soprannaturale, a ciò che gli viene chiesto, non gradisce questo comportamento e, pur rispondendo, prova sdegno.
CAPITOLO 19
Ove si afferma e si prova che, sebbene le visioni e le locuzioni che vengono da Dio siano vere, ci si può sbagliare a loro riguardo. Le prove sono tratte dalla sacra Scrittura.
1. Per due motivi ho affermato che, sebbene le visioni e le locuzioni di Dio siano vere e sempre certe in sé, tuttavia non sono sempre tali per noi: il primo dipende dal nostro modo difettoso d’intenderle; e l’altro è dovuto al fatto che le loro cause a volte possono cambiare. Lo proverò con alcune testimonianze della sacra Scrittura. Quanto al primo motivo, è chiaro che non sempre tali rivelazioni sono e accadono secondo il nostro modo di comprenderle. Dio, infatti, essendo immenso e profondo, nelle sue profezie, locuzioni e rivelazioni segue abitualmente altre vie, concetti e idee molto differenti da quelli che comunemente intendiamo noi. Questo risulta da ogni pagina della sacra Scrittura. Difatti vi leggiamo che molte profezie e locuzioni da Dio indirizzate a numerose persone dei tempi antichi non si realizzarono come esse si aspettavano, perché le intendevano a modo loro o le prendevano troppo alla lettera. Ciò è quanto vedremo chiaramente nei brani della sacra Scrittura che seguiranno.
2. Nel libro della Genesi Dio disse ad Abramo, dopo averlo condotto nella terra di Canaan: Tibi dabo terram hanc: Ti darò questa terra (Gn 15,7). Più volte gli rinnovò questa promessa, senza mantenerla. Quando, ormai vecchio, il patriarca si sentì ripetere quelle parole, si rivolse al Signore dicendo: Domine, unde scire possum quod possessurus sum eam?, cioè: Signore mio Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso? (Gn 15,8). Allora Dio gli rivelò che non lui personalmente, ma i suoi figli dopo quattrocento anni l’avrebbero posseduta (Gn 15,13-16). Così Abramo riuscì a comprendere la promessa, verissima in sé, perché Dio, dando quella terra ai suoi figli per amor suo, era come se l’avesse data a lui personalmente. Abramo, quindi, si sbagliava nel suo modo d’interpretare tale promessa: se avesse agito secondo il senso che dava alla profezia, sarebbe caduto in un grave errore, perché essa non doveva realizzarsi nel suo tempo, così che coloro che l’avessero visto morire dopo averlo sentito parlare della promessa fattagli da Dio sarebbero rimasti disorientati e avrebbero potuto pensare che la profezia fosse falsa.
3. Un fatto simile capitò a suo nipote Giacobbe, al tempo in cui il figlio di costui, Giuseppe, lo fece scendere in Egitto a causa della fame che attanagliava i cananei. Gli apparve il Signore e gli disse: Iacob, Iacob, noli timere, descende in Aegyptum, quia in gentem magnam faciam te ibi. Ego descendam tecum illuc… Et inde adducam te revertentem: Giacobbe, Giacobbe, non temere di scendere in Egitto, perché laggiù io farò di te un grande popolo. Io scenderò con te in Egitto e certamente io ti farò tornare (Gn 46,2-4). Ora, questo evento non si realizzò secondo il nostro modo d’intendere. Sappiamo, infatti, che il santo vecchio Giacobbe morì in Egitto (Gn 49,32), da dove, quindi, non uscì vivo. La promessa era destinata a compiersi nei suoi figli, che Dio fece uscire dall’Egitto molti anni dopo, guidandoli personalmente lungo il cammino. È chiaro, quindi, che chiunque avesse saputo di questa promessa fatta da Dio a Giacobbe si sarebbe potuto convincere che Giacobbe, com’era entrato personalmente vivo in Egitto per ordine e con l’aiuto di Dio, così certamente ne sarebbe dovuto uscire vivo, in persona, perché Dio gli aveva promesso il ritorno e il suo aiuto per realizzarlo; ma si sarebbe sbagliato e stupito vedendo lui morire in Egitto e la promessa rimanere irrealizzata. Così, pur essendo la parola di Dio verissima in sé, molti si sarebbero potuti sbagliare a suo riguardo.
4. Anche nel libro dei Giudici leggiamo che le tribù d’Israele si erano riunite per combattere la tribù di Beniamino e punirla d’una cattiva azione di cui si era macchiata. Poiché Dio aveva loro indicato un capo per fare questa guerra, gli israeliti erano così sicuri della vittoria che, quando furono sconfitti e perdettero ventiduemila uomini, rimasero molto sconcertati (Gdc 20,1-21). Trascorsero tutto il giorno in pianto dinanzi al Signore, non conoscendo il motivo della sconfitta: erano convinti che la vittoria sarebbe dovuta toccare a loro. Avendo, poi, chiesto a Dio se dovevano tornare a combattere oppure no, fu loro risposto di andare a combattere. Sicuri, questa volta, della vittoria, corsero all’attacco con grande coraggio; ma ancora una volta furono sconfitti e perdettero diciottomila uomini (Gdc 20,23-25). Caduti in una grande confusione, non sapevano cosa fare: nonostante Dio avesse loro comandato di combattere, venivano sempre sconfitti, cosa strana soprattutto per il fatto che superavano in numero e forza gli avversari. I soldati della tribù di Beniamino, infatti, non erano più di venticinquemilasettecento, mentre essi erano circa quattrocentomila (Gdc 20,17). In realtà essi s’ingannavano sul modo d’interpretare la parola di Dio, che non era menzognera. In effetti Dio non aveva detto che avrebbero vinto, ma solo di combattere; con quelle sconfitte voleva punirli per una certa negligenza e umiliarli per la loro presunzione. Quando, alla fine, Dio rispose loro che avrebbero vinto, conseguirono la vittoria (Gdc 20,28.34-35.43-46), anche se con l’astuzia e con grande fatica.
5. In questo e in molti altri modi le anime possono ingannarsi sulle locuzioni e le rivelazioni da parte di Dio, perché le interpretano alla lettera e in forma riduttiva. Ora, come risulta da quanto è stato detto, lo scopo principale di Dio in queste manifestazioni è quello di dire e comunicare lo spirito in esse racchiuso, difficile da intendere, perché è molto più ricco della lettera e molto più straordinario e trascendente rispetto ad essa. Così, chi si limita alla lettera, alla locuzione, alla forma, all’immagine sensibile della visione, sicuramente si sbaglierà in modo grossolano e poi si troverà turbato e confuso: si è lasciato guidare dai sensi, anziché fare spazio allo spirito distaccandosi, appunto, dai sensi. Littera enim occidit, spiritus autem vivificat, dice san Paolo: La lettera uccide, lo Spirito dà vita (2Cor 3,6). Occorre, quindi, rinunciare alla lettera, in questo caso ai sensi, e fermarsi nel buio della fede, cioè allo spirito, che i sensi non possono percepire.
6. Per questo motivo, molti figli d’Israele che interpretavano alla lettera le parole e le profezie dei profeti, che poi non si realizzavano come si attendevano, finivano per tenerle in poco conto e per non crederci. Sorse così tra loro un detto popolare, a mo’ di proverbio, che scherniva i profeti. Di esso si lamenta Isaia riportandolo in questi termini: Quem docebit Dominus scientiam? et quem intelligere faciet auditum? ablactos a lacte, avulsos ab uberibus. Quia manda, remanda, manda, remanda; exspecta, reexspecta, exspecta, reexspecta; modicum ibi, modicum ibi. In loquela enim labii et lingua altera loquetur ad populum istum: «A chi vuole insegnare la scienza? A chi vuole spiegare il discorso? Ai bambini divezzati, appena staccati dal seno. Sì – delle profezie dicono – precetto su precetto, precetto su precetto, norma su norma, norma su norma, un po’ qui, un po’ là». Con labbra balbettanti e in lingua straniera parlerà a questo popolo (Is 28,9-11). Con tali parole Isaia fa comprendere chiaramente che i figli d’Israele si burlano delle profezie, dicendo per scherno il proverbio norma su norma, norma su norma. In effetti essi erano attaccati al senso letterale, che è il latte dei bambini, e ai loro propri sensi, che sono come il seno materno, i quali si contrappongono alla grandezza della scienza dello spirito. Per questo Isaia dice: a chi Dio insegnerà la sapienza delle sue profezie, a chi spiegherà la sua dottrina, se non a coloro che sono già divezzati dal latte della lettera e dal seno dei loro sensi? Proprio perché intendono tale sapienza secondo il latte della lettera e il seno dei loro sensi, essi dicono: precetto su precetto, precetto su precetto, norma su norma… Ma il Signore deve parlare loro secondo un senso e un linguaggio differenti dai loro sensi e dal loro linguaggio.
7. Non si deve, dunque, badare al nostro senso e al nostro linguaggio, sapendo che la parola di Dio ha un significato spirituale molto diverso dal nostro e più difficile da interpretare. Tant’è vero che lo stesso Geremia, pur essendo profeta del Signore, vedendo che il significato delle parole di Dio era così diverso da quello comunemente attribuito loro dagli uomini, sembra anche lui essersi lasciato ingannare. Prende allora la difesa del popolo, dicendo: Heu, heu, heu, Domine, Deus, ergone decepisti populum istumet Ierusalem, dicens: Pax erit vobis, et ecce pervenit gladius usque ad animam?: Ah, Signore Dio, hai dunque del tutto ingannato questo popolo e Gerusalemme, quando dicevi: «Voi avrete pace», mentre una spada giunge fino alla gola? (Ger 4,10). Ora, la pace che Dio prometteva loro era quella che doveva stabilirsi tra lui e l’umanità mediante il Messia che avrebbe inviato, mentre essi pensavano a una pace temporale. Così, quando essi si trovavano in difficoltà e in guerra, pensavano che Dio li avesse ingannati, perché accadeva il contrario di ciò che si aspettavano. E dicevano quindi con Geremia: Expectavimus pacem, et non est bonum: Aspettavamo la pace, ma non c’è alcun bene (Ger 8,15). Era quindi impossibile che essi non s’ingannassero, perché si fermavano solo al senso letterale. In realtà, chi non si sarebbe ingannato e confuso interpretando alla lettera la profezia che Davide fa di Cristo in tutto il Salmo 71, soprattutto quando dice: Et dominabitur a mari usque ad mare, et a flumine usque ad terminos orbis terrarum: E dominerà da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra (v.8)? Nello stesso salmo aggiunge: Liberabit pauperem a potenti, et pauperem cui non erat adiutor, che significa: Egli libererà il povero che grida e il misero che non trova aiuto (v.12). Chi non si sarebbe ingannato vedendolo poi nascere in umili condizioni, vivere in povertà, morire in miseria e non solo non impossessarsi della terra mentre era in vita, ma sottomettersi a gente ignobile, fino a morire sotto Ponzio Pilato? Come non cadere nell’inganno, pensando che il Signore non solo non liberò i suoi poveri discepoli dalle mani dei potenti di questo mondo, ma li lasciò uccidere e perseguitare per il suo nome?
8. Queste profezie su Cristo dovevano essere interpretate nel loro senso spirituale, e questo senso è molto vero. Cristo, infatti, è il Signore non solo della terra ma anche del cielo, perché è Dio. Quanto ai poveri che l’avrebbero seguito, non solo li avrebbe redenti e liberati dal potere del demonio, il potente contro il quale non avevano nessuno che li aiutasse, ma li avrebbe fatti anche eredi del regno dei cieli. Dio, dunque, parlava della cosa più importante riguardo a Cristo e ai suoi seguaci, cioè del regno eterno e della libertà eterna; al contrario, i giudei interpretavano a modo loro le profezie, fermandosi all’elemento meno importante di queste cose, cioè il dominio temporale e la libertà terrena di cui Dio fa poco conto; ai suoi occhi non sono niente né l’uno né l’altra. Per questo, accecati dall’apparenza vistosa della lettera e non comprendendo né lo spirito né la verità in essa contenuti, uccisero il loro Dio e Signore, come afferma san Paolo: Qui enim habitabant Ierusalem, et principies eius, hunc ignorantes, et voces prophetarum, quae per omne sabbatum leguntur, iudicantes impleverunt: Gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi non l’hanno riconosciuto e condannandolo hanno adempiuto le parole dei profeti che si leggono ogni sabato (At 13,27).
9. Questa difficoltà a comprendere le parole del Signore in modo adeguato era tale da far cadere in errore anche i suoi stessi discepoli, vissuti con lui. Ne abbiamo un esempio nei due discepoli che, dopo la sua morte, andavano a Emmaus, tristi, sfiduciati e dicevano: Nos autem sperabamus quod ipse esset redempturus Israel: Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele (Lc 24,21). Anch’essi pensavano a una redenzione e a un dominio temporale. Gesù, apparendo ad essi, rimproverò la loro stoltezza e durezza di cuore nel credere agli eventi predetti dai profeti (v. 25). Anche mentre saliva al cielo alcuni discepoli, ancora in preda a quella durezza, gli chiesero: Domine, si in tempore hoc restitues regnum Israel?: Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? (At 1,6). Lo Spirito Santo rivela, dunque, molte cose che hanno un significato diverso da quello inteso dagli uomini, come si evince anche dalle parole di Caifa riguardo a Cristo: È meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera (Gv 11,50). Ora Caifa non disse da sé quelle parole; ma egli vi aveva dato un senso molto diverso da quello inteso dallo Spirito Santo.
10. Risulta chiaro, quindi, che, sebbene le parole e le rivelazioni vengano da Dio, non possiamo essere certi del loro significato, perché possiamo ingannarci facilmente nel nostro modo d’interpretarle. Tutte, infatti, sono un abisso della profondità dello spirito. Volerle circoscrivere a ciò che ne capiamo noi e che i nostri sensi possono percepire, è come voler afferrare con la mano l’aria e il pulviscolo in essa contenuto: l’aria ci sfugge di mano e non ci resta nulla.
11. Perciò il maestro spirituale deve fare in modo che lo spirito del discepolo non si inaridisca correndo dietro a tutte le comunicazioni soprannaturali. Queste sono soltanto pulviscolo per lo spirito, ragion per cui il discepolo resterebbe con le mani piene di polvere, mentre non riceverebbe nulla di spirituale. Il maestro deve, invece, allontanarlo da tutte le visioni e locuzioni e deve imporgli di rimanere nella libertà e nelle tenebre della fede, in cui si riceve l’abbondanza dello spirito soprannaturale, quindi la sapienza e l’intelligenza propria delle parole di Dio. Difatti è impossibile all’uomo, se non è spirituale, giudicare e intendere secondo ragione le cose di Dio. Quando le giudica secondo i sensi, non è spirituale. Così, anche se queste vengono a lui comunicate attraverso i sensi, non le comprende. Lo afferma san Paolo quando dice: Animalis autem homo non percipit ea quae sunt spiritus Dei; stultitia enim est illi, et non potest intelligere, quia de spiritualibus examinatur. Spiritualis autem iudicat omnia: L’uomo naturale non comprende le cose dello Spirito di Dio; esse sono follia per lui, e non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito. L’uomo spirituale, invece, giudica ogni cosa (1Cor 2,14-15). Per uomo naturale s’intende qui colui che adopera solo i sensi; l’uomo spirituale è, invece, colui che non si lega e non si lascia guidare dai sensi. È quindi temerario osar trattare con Dio attraverso le comunicazioni soprannaturali e permettere ai sensi la libertà di farlo.
12. Per meglio comprendere questa verità, faccio alcuni esempi. Prendiamo il caso di un santo molto afflitto, perché perseguitato dai suoi nemici, al quale Dio dica: «Ti libererò da tutti i tuoi nemici». Questa profezia può essere verissima e, malgrado ciò, i nemici del santo possono prevalere su di lui e infliggergli la morte. Resterebbe, così, deluso chi avesse interpretato questa profezia in senso temporale, perché Dio può riferirsi alla vera e più importante vittoria, cioè alla salvezza, in cui l’anima è libera e vittoriosa su tutti i suoi nemici, in un modo molto più reale ed elevato che se fosse stata liberata dai nemici quaggiù. Tale profezia era, dunque, molto più reale e significativa di quanto l’uomo potesse capire rapportandola a questa vita. Dio nelle sue parole mira sempre al senso più importante e vantaggioso; l’uomo, invece, può comprendere, a modo suo e secondo una sua idea, il significato meno importante e così restare ingannato. Ciò è quanto si osserva in quella profezia che Davide fa a riguardo di Cristo nel salmo 2: Reges eos in virga ferrea, et tamquam vas figuli confringes eos: Li spezzerai con scettro di ferro, come vasi di argilla li frantumerai (Sal 2,9). Dio qui si riferisce alla sovranità più importante e perfetta, che è quella eterna, in effetti già realizzata, e non a quella regalità meno importante o temporale, che Cristo non esercitò durante la sua vita terrena.
13. Faccio un altro esempio. C’è un’anima che desidera ardentemente il martirio. Può accadere che Dio le dica: «Sarai martire» e le faccia sentire una grande consolazione interiore e la fiducia che questo si avvererà. Ma può accadere che essa non muoia martire e che tuttavia la promessa sia vera. Ma allora perché non si è realizzata questa profezia? Perché si compirà e potrà realizzarsi secondo il senso più importante ed essenziale in essa contenuto: Dio le dà un grande amore e la gloria essenziale del martirio; così conferisce veramente all’anima ciò che essa formalmente desiderava e che le era stato promesso. Il desiderio formale dell’anima, infatti, non era un determinato genere di morte, ma glorificare Dio attraverso il martirio e testimoniargli il suo amore come martire. Quel genere di morte non ha alcun valore senza quest’amore; ma tale amore, l’esercizio e la corona del martirio le vengono concessi compiutamente per altra via; quindi, pur non morendo martire, l’anima è molto soddisfatta per aver ricevuto ciò che desiderava. Questi e altri simili desideri, quando nascono da un amore vivo, anche se non si realizzano secondo i modi che l’anima pensava e intendeva, si compiono tuttavia in maniera diversa, molto superiore e a maggior gloria di Dio di quanto essa potesse chiedere. Per questo Davide dice: Desiderium pauperum exaudivit Dominus: Il Signore accoglie il desiderio dei miseri (Sal 10,17). Nel libro dei Proverbi la Sapienza divina afferma: Desiderium suum iustis dabitur: Il desiderio dei giusti è soddisfatto (Pro 10,24). A volte noi vediamo che molti santi desiderarono ardentemente molte cose per Dio, ma il loro desiderio non si realizzò in questa vita. Ora dobbiamo credere che, essendo il loro desiderio vero e giusto, si è perfettamente realizzato nell’altra vita. Stando così le cose, sarebbe stato vero anche se Dio in questa vita avesse promesso loro: Il vostro desiderio sarà esaudito. Ma non necessariamente sarebbe stato esaudito nel modo da loro pensato.
14. In questo e in altri modi le parole e le visioni di Dio possono essere vere e certe, e tuttavia noi possiamo sbagliarci a loro riguardo, perché non ne comprendiamo il significato profondo e principale che Dio pone in esse. Per questo è meglio e più sicuro fare in modo che le anime rifuggano prudentemente da queste manifestazioni soprannaturali, abituandosi, come ho detto, alla purezza di spirito nella fede oscura, mezzo indispensabile per unirsi a Dio.
CAPITOLO 20
Ove si prova con passi della sacra Scrittura che le rivelazioni e le parole di Dio, pur essendo sempre vere, non sempre sono certe nelle loro cause.
1. Ora devo trattare del secondo motivo per cui le visioni e le parole provenienti da Dio, sebbene siano sempre vere in se stesse, non sempre sono certe rispetto a noi. Ciò è dovuto alle cause su cui si fondano. Molte volte, infatti, Dio dice cose che si fondano sulle creature e sugli effetti prodotti da esse; ma le creature possono cambiare e quindi le cause possono venir meno. Ne risulta, allora, che le parole che si basano su tali fondamenti possono anch’esse variare e non realizzarsi. Quando, infatti, una cosa dipende da un’altra, se viene meno una, verrà meno anche l’altra. Supponiamo che Dio dica: «Tra un anno manderò una calamità su tale nazione». Il motivo di questa minaccia sta in una certa offesa commessa contro Dio in quella nazione. Or dunque, se l’offesa cessasse o venisse modificata, potrebbe venir meno anche la sventura. Ma la minaccia era vera, perché fondata su una colpa reale; se questa si fosse prolungata, quella si sarebbe realizzata.
2. Così accadde alla città di Ninive, quando Dio la minacciò in questi termini: Adhuc quadraginta diebus et Ninive subvertetur: Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta (Gio 3,4). Ma questa profezia non si realizzò perché Ninive rimosse la causa di quella minaccia, cioè i suoi peccati, facendo penitenza. Se i niniviti non avessero agito così, la minaccia si sarebbe realizzata. Anche nel primo libro dei Re (21,21) leggiamo che, avendo il re Acab commesso un peccato molto grave, Dio gli fece annunciare che un grande castigo si sarebbe abbattuto sulla sua persona, la sua casa e il suo regno. Messaggero di tale annuncio fu il nostro padre Elia. Ora, Acab si stracciò le vesti per il dolore, indossò il cilicio, digiunò, dormì coperto di sacco e si mostrò addolorato e umiliato. Dio allora disse al medesimo profeta: Quia igitur humiliatus est mei causa, non inducam malum in diebus eius, sed in diebus filii sui: Poiché si è umiliato davanti a me, non farò piombare la sciagura durante la sua vita, ma la farò scendere sulla sua casa durante la vita del figlio (1Re 21,29). Da queste parole vediamo come, avendo Acab cambiato il suo animo e il suo comportamento, anche Dio cambiò la sua decisione.
3. Da quanto riportato possiamo, dunque, affermare ciò che ci siamo proposti: sebbene Dio abbia rivelato o detto a un’anima in modo affermativo qualcosa, in bene o in male, riguardante la stessa anima o altre, la parola di Dio potrà più o meno modificarsi, variare o essere annullata del tutto in base al cambiamento dei sentimenti di quell’anima o della causa su cui Dio si basava; potrebbe così realizzarsi diversamente da come ci si aspettava, e molte volte senza sapere il perché, noto solamente a Dio. Questi, infatti, è solito dire, insegnare e promettere molte cose, non perché siano comprese e possedute sul momento, ma perché vengano capite in seguito quando sarà il momento adatto per ricevere la luce e poter usufruire dei loro effetti. Tale fu il comportamento del Signore con i suoi discepoli, ai quali raccontava molte parabole e sentenze, di cui non compresero la saggezza fino al momento in cui dovettero predicarla, quando cioè ricevettero lo Spirito Santo (At 2,1-4). Solo lo Spirito, secondo le parole di Gesù, avrebbe spiegato loro tutto ciò che egli aveva loro insegnato durante la sua vita (Gv 14,26). Quando san Giovanni parla dell’ingresso di Cristo in Gerusalemme, afferma: Haec non cognoverunt discipuli eius primum: sed quando glorificatus est Jesus, tunc recordati sunt quia erant scripta de eo: Sul momento i suoi discepoli non compresero queste cose; ma quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che questo era stato scritto di lui (12,16). Vi sono, dunque, molte cose divine, assai particolari, che passano nell’anima senza che essa, o chi la dirige, le comprenda fino al momento opportuno.
4. Anche nel primo libro dei Re leggiamo che Dio, adirato contro Eli, sacerdote d’Israele, perché non puniva i peccati dei suoi figli, gli mandò a dire per mezzo di Samuele, tra l’altro, queste parole: Loquens locutus sum, ut domus tua, et domus patris tui, ministraret in conspectu meo, usque in sempiternum. Verumtamen absit hoc a me: Avevo promesso alla tua casa e alla casa di tuo padre che avrebbero servito sempre alla mia presenza. Ma ora, oracolo del Signore, non sia mai! (1Sam 2,30). L’ufficio del sacerdozio consisteva nel rendere onore e gloria a Dio e a tal fine Dio aveva promesso di concederlo al padre di Eli per sempre. Eli però non ebbe a cuore l’onore di Dio. Allora Dio stesso gli fede sapere che si era offeso: egli onorava i suoi figli più di lui, nascondendo i loro peccati per non svergognarli. Venne così meno anche la promessa, che era per sempre se per sempre essi fossero stati fedeli nel servire Dio con zelo. Non dobbiamo quindi pensare che, sebbene le parole e le rivelazioni vengano da Dio, necessariamente debbano realizzarsi alla lettera, soprattutto quando sono legate a cause umane, che possono variare, mutare e scomparire.
5. Quando tali fatti dipendono da queste cause, Dio solo lo sa, ma non sempre lo rivela. Talvolta egli comunica le sue parole o le sue rivelazioni, tacendo sulle circostanze in cui si avvereranno, come fece con i niniviti, ai quali disse categoricamente che sarebbero stati distrutti al termine di quaranta giorni (Gio 3,4). Altre volte spiega le circostanze, come fece con Roboamo dicendogli: Se ascolterai quanto ti comanderò, se seguirai le mie vie e farai quanto è giusto ai miei occhi osservando i miei decreti e i miei comandi, come ha fatto Davide mio servo, io sarò con te e ti edificherò una casa stabile come l’ho edificata per Davide (1Re 11,38). Tuttavia, che manifesti o meno le condizioni delle profezie, non dobbiamo basarci sulla nostra intelligenza, perché non siamo in grado di comprendere le verità nascoste nella parola di Dio o nei significati molteplici che essa può assumere. Egli sta in cielo e parla in termini di eternità; noi, invece, ciechi, siamo su questa terra e comprendiamo solo le vie della carne e del tempo. Per questo motivo il Saggio ha detto: Non essere precipitoso con la bocca e il tuo cuore non si affretti a proferir parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra (Qo 5,1).
6. Forse mi dirai: ma allora, se non dobbiamo comprendere queste rivelazioni né occuparci di esse, perché Dio ce le comunica? Ho detto che ogni rivelazione verrà compresa nel momento stabilito da colui che l’ha fatta e solo da chi vuole lui; si vedrà allora che era meglio così, perché Dio non fa nulla senza motivo e al di fuori della verità. Occorre, dunque, convincersi che è impossibile comprendere compiutamente il significato delle parole e delle rivelazioni di Dio, né basarsi sulle loro apparenze, senza cadere in gravi errori e in profonda confusione. Lo sapevano molto bene i profeti, che avevano familiarità con la parola di Dio e ai quali procuravano molta difficoltà le profezie riguardanti il popolo. Difatti, come ho detto, gli ebrei non vedevano avverarsi tali profezie alla lettera, secondo quanto era stato annunziato. Per questo motivo deridevano e schernivano i profeti, tanto che Geremia arrivò a dire: Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno; ognuno si fa beffe di me. Poiché da molto tempo, quando parlo, devo gridare, devo proclamare: Violenza! Oppressione! Così la parola del Signore è diventata per me motivo di obbrobrio e di scherno ogni giorno. Mi dicevo: Non penserò più a lui, non parlerò più in suo nome! (Ger 20,7-9). Queste parole, sebbene ci mostrino il santo profeta parlare con rassegnazione e nelle vesti di uomo debole che non può comprendere le vie e i segreti di Dio, tuttavia fanno ben capire la differenza tra il compimento delle parole divine e il senso che comunemente ad esse si annette. Infatti i profeti di Dio passavano per burloni e a causa delle loro profezie soffrivano tanto che lo stesso Geremia, in un altro passo, dice: Formido et laqueus facta est nobis vaticinatio et contritio: Terrore e trabocchetto è divenuta per noi la profezia, e rovina (Lam 3,47).
7. Il motivo per cui Giona fuggì quando Dio lo inviò a predicare la distruzione di Ninive fu proprio questo: sapeva che gli uomini comprendono diversamente le parole di Dio e le loro cause. Così, per non cadere nello scherno se la sua profezia non si fosse realizzata, preferì fuggire piuttosto che profetizzare (Gio 1,1-3). In seguito si pose ad aspettare quaranta giorni fuori della città, per vedere se la profezia si fosse avverata (Gio 4,5). Quando si accorse che non si realizzava, si rattristò tanto da dire al Signore: Obsecro, Domine, numquid non hoc est verbum meum, cum adhuc essem in terra mea? Propter hoc preoccupavi, ut fugerem in Tharsis: Signore, non era forse questo che dicevo quand’ero nel mio paese? Perciò mi affrettai a contraddire e a fuggire a Tarsis. Il santo, amareggiato, s’indispettì e chiese a Dio di togliergli la vita (Gio 4,2-3).
8. Perché, dunque, stupirsi se alcune profezie o rivelazioni che Dio fa alle anime non si verificano nel senso in cui vengono intese? Nel caso infatti che Dio dica a un’anima o le riveli che essa o un’altra riceverà tale o tal altra cosa di bene o di male, qualora ci si basi su determinati atti attraverso cui questa o un’altra anima recano gloria od offesa a Dio, se tali anime perseverano in questo atteggiamento, la profezia si avvererà. Ma non è certo che questa si avvererà, perché non è certo che le anime perseverino. Non dobbiamo quindi fidarci della nostra intelligenza circa le profezie, bensì della nostra fede.
CAPITOLO 33
Ove si comincia a trattare del sesto genere di beni, cioè quelli spirituali, di cui la volontà può gioire. Si dice quali siano e se ne presenta una prima divisione.
1. Lo scopo di quest’opera è quello di condurre lo spirito attraverso i beni spirituali fino all’unione perfetta dell’anima con Dio. Ora che in questo sesto genere dobbiamo trattare dei beni spirituali, i quali meglio contribuiscono alla realizzazione del nostro scopo, sia io sia il lettore dobbiamo riflettere con particolare attenzione su questo argomento. Difatti è cosa certa e frequente che alcuni, per la loro scarsa scienza, si servono delle cose spirituali solo per soddisfare i sensi, lasciando il loro spirito a digiuno. A stento si riuscirà, allora, a trovare qualcuno al quale la soddisfazione dei sensi non abbia causato qualche danno allo spirito, perché l’acqua della grazia è trattenuta nei sensi prima di arrivare allo spirito, lasciato nell’aridità e nel vuoto.
2. Venendo ora al mio argomento, dico che per beni spirituali intendo tutti quelli che ci muovono e ci servono d’aiuto per le cose divine, per i rapporti dell’anima con Dio e per le comunicazioni di Dio con l’anima.
3. Cominciando, quindi, a dividerli nel modo più generale, dico che i beni spirituali sono di due specie: alcuni sono gradevoli, altri sono dolorosi. Ciascuna di queste specie si divide, a sua volta, in due categorie. Difatti, tra i beni gradevoli all’anima ve ne sono alcuni che hanno per oggetto cose chiare che si comprendono distintamente, altri cose che non si capiscono chiaramente e distintamente. Anche quelli dolorosi possono avere per oggetto cose chiare e distinte oppure cose confuse e oscure.
4. Inoltre li possiamo ancora suddividere tutti in base alla distinzione delle potenze dell’anima. Così alcuni sono conoscenze intellettuali e appartengono all’intelletto; altri sono affetti e appartengono alla volontà; altri, infine, sono immaginari e appartengono alla memoria.
5. Lascio da parte, per ora, i beni dolorosi, perché appartengono alla notte passiva, dove ne parlerò, e anche quelli gradevoli relativi a cose confuse e non distinte, per trattarne alla fine, in quanto appartengono alla conoscenza generale, confusa, amorosa, attraverso cui si realizza l’unione dell’anima con Dio; questa è stata riservata all’ultima parte del libro II nella divisione delle diverse concezioni dell’intelletto. Qui, dunque, parlerò dei beni gradevoli che hanno per oggetto cose chiare e distinte.
CAPITOLO 34
Ove si parla dei beni spirituali che possono essere percepiti distintamente dall’intelletto e dalla memoria. Si spiega come deve comportarsi la volontà circa la gioia che ne deriva.
1. Avrei molto da dire a motivo delle tantissime conoscenze che si formano nella memoria e nell’intelletto, se volessi indicare alla volontà come deve comportarsi riguardo alla gioia che questi beni suscitano. Ma ne ho già parlato ampiamente nei libri II e III. Poiché lì ho indicato come debbano comportarsi quelle due potenze rispetto a queste conoscenze onde tendere all’unione divina e, altresì, come la volontà debba comportarsi nei riguardi della gioia che deriva da tali beni, qui non è necessario riparlarne. Basta ricordare che ovunque si affermi che queste potenze devono liberarsi da queste o quelle conoscenze, occorre ugualmente dire che la volontà deve rinunciare alla gioia che da esse deriva. Se è vero che la memoria e l’intelletto devono rimanere distaccate nei confronti di tutte queste conoscenze, così deve fare anche la volontà. Poiché l’intelletto e le altre potenze non possono accettare o negare nulla senza il concorso della volontà, è chiaro che la dottrina riguardante le prime due facoltà riguarda anche la volontà.
2. Si veda lì ciò che è necessario fare ora, perché l’anima cadrà in quegli stessi danni, se in tutte queste conoscenze non saprà elevarsi a Dio.
CAPITOLO 35
Ove si parla dei beni spirituali gradevoli che possono essere l’oggetto distinto della volontà. Si dice di quanti generi siano.
1. Possiamo ridurre a quattro i generi di beni che separatamente possono recare gioia alla volontà, cioè motivi o moventi, provocativi, direttivi e perfettivi. Ne parlerò nell’ordine enunciato, cominciando dai beni che motivano o accendono la devozione, e cioè le immagini e le raffigurazioni dei santi, gli oratori e le cerimonie.
2. Per quanto riguarda le immagini e le raffigurazioni dei santi, può esserci molta vanità e inutile compiacenza. Ciò nonostante, essi sono molto importanti per il culto divino e utili per muovere la volontà a devozione. Prova ne è il fatto che la santa madre Chiesa li approva e ne fa uso. Per questo è sempre utile per noi avvalercene per scuotere la nostra tiepidezza. Purtroppo, però, vi sono molte persone che si compiacciono più dell’espressione pittorica e degli ornamenti di queste immagini che dei soggetti ivi rappresentati.
3. La Chiesa ha prescritto il culto delle immagini principalmente in vista di due scopi, cioè di venerare per mezzo di esse i santi, e muovere la volontà e risvegliare la devozione verso di loro. Ora, in quanto servono a tutto questo, le immagini sono utili e il loro uso necessario. Si devono quindi scegliere quelle più vicine al soggetto rappresentato e che meglio muovono la volontà alla devozione. È qui che dobbiamo fermare la nostra attenzione, più che sul valore delle immagini o sul pregio della loro esecuzione e dei loro ornamenti. Ci sono, ripeto, alcune persone che guardano più alla bellezza delle immagini e al loro valore che a ciò che rappresentano. Riversano sulla bellezza e sugli ornamenti esteriori la devozione interiore, che dovrebbero rivolgere spiritualmente al santo che non vedono, dimenticando subito l’immagine, che è solo un mezzo. In questo modo vengono appagati e solleticati i sensi e là si concentrano l’amore e la gioia della volontà. Tutto questo ostacola completamente la vera devozione, che esige invece la rinuncia alle affezioni verso tutti gli oggetti particolari.
4. Una dimostrazione dell’uso detestabile di tali immagini ce l’offrono oggi alcune persone, le quali, non avendo in orrore le mode profane del mondo, adornano le immagini con i costumi che i mondani periodicamente inventano per i loro svaghi e la soddisfazione delle loro frivolezze. Con i costumi, per i quali quelli stessi vengono biasimati, coprono le immagini, detestate dai santi che esse rappresentano, e a giusto titolo. Così facendo, il demonio e suddette persone cercano di canonizzare le proprie vanità, imponendole ai santi, non senza arrecare loro una grave ingiuria. In questo modo la vera e solida devozione dell’anima, che respinge e rigetta da sé ogni vanità e ogni sua apparenza, si riduce a poco più che un abbellimento di bambole, perché alcuni si servono delle immagini come di idoli in cui ripongono la loro compiacenza. Vedrete, così, persone che non si stancano di aggiungere immagine a immagine; vogliono che queste siano di un determinato tipo e modello e che siano collocate in tale o tal altra maniera, al fine di compiacere i sensi, mentre la devozione del loro cuore è assai scarsa. Sono molto attaccati a queste immagini come lo erano Mica e Labano ai loro idoli. Il primo uscì di casa imprecando contro coloro che glieli avevano portati via; il secondo, dopo aver corso per molto tempo ed essersi adirato a causa degli idoli, mise a soqquadro la tenda di Giacobbe per ritrovarli (Gdc 18,24; Gn 31,34).
5. La persona veramente pia ripone la propria devozione soprattutto nelle cose invisibili, non ha bisogno di molte immagini e ne usa poche. Si serve solo di quelle che le ricordano più il divino che l’umano, e che meglio la orientano alla condizione dell’altra vita che non di quella presente. Si comporta così non soltanto per guardarsi dalle vanità di questo mondo, ma anche per non ricordarsi di esso, quando sotto gli occhi le cade qualcosa che gli assomiglia o gli appartiene. Non attacca il cuore neanche alle immagini che usa, né si addolora molto se le vengono tolte. Cerca dentro di sé, invece, l’immagine viva di Cristo crocifisso, nel quale è contenta che le tolgano tutto e che tutto le manchi. Anche se le tolgono i motivi e i mezzi che più l’avvicinano a Dio, rimane tranquilla. Del resto, l’anima è più progredita se riesce a conservare la pace e la gioia quando è privata di questi mezzi rispetto a quando li possiede con attaccamento e passione. È senz’altro giusto desiderare di avere quelle immagini e quei mezzi che meglio favoriscono la devozione della persona, ragion per cui si devono scegliere sempre quelle che la stimolano di più. Tuttavia non è indice di perfezione esservi troppo attaccati, tanto da tenerle con spirito di possesso e da soffrire se ci vengono tolte.
6. L’anima stia certa che quanto più è forte il suo spirito di possesso nei riguardi dell’immagine o dell’aiuto sensibile, tanto meno la sua devozione e la sua preghiera si eleveranno a Dio. Anche se, in verità, è opportuno affezionarsi alle immagini più adatte a eccitare la devozione, ciò non deve comportare attaccamento e spirito di possesso, come ho detto sopra. In questo caso, infatti, il senso, assorbito interamente nella gioia dei mezzi e dimentico del loro valore soltanto relativo, divora tutto ciò che dovrebbe portare l’anima a prendere il volo verso Dio. Così i mezzi, che dovrebbero essere soltanto un aiuto per l’anima, le divengono motivo d’imperfezione e ostacolo, al pari dell’attaccamento e dello spirito di possesso per qualsiasi altra cosa.
7. Se la questione delle immagini ti suggerisce qualche obiezione, ciò dipende dal fatto che non hai ben compreso lo spogliamento e lo spirito di povertà richiesti dalla perfezione. Riconosci almeno, però, l’imperfezione in cui comunemente si cade riguardo alle corone del rosario; difficilmente troverai qualcuno che non dimostri in esse qualche debolezza: le vogliono così e non cosà; di questo colore e metallo piuttosto che quello; con questo ornamento o con quell’altro. Nulla di tutto questo giova perché Dio ascolti meglio la preghiera fatta con una corona piuttosto che con un’altra: egli ascolta l’anima che prega con cuore sincero e semplice, preoccupata solo di piacergli e non di avere un rosario piuttosto che un altro, a meno che non vi siano legate delle indulgenze.
8. La nostra vana avidità è tale che vuole attaccarsi a tutte le cose. È come il tarlo che rode ciò che è sano e porta a termine il suo lavoro nelle cose buone e cattive. Da che cosa deriva, infatti, che tu voglia avere una corona del rosario con certe caratteristiche, che sia fatta così e non diversamente, se non dal fatto che hai riposto la tua gioia in uno strumento? E perché vuoi scegliere questa immagine piuttosto che un’altra, non tenendo conto se ti risveglia maggiormente l’amore, ma solo se è più preziosa e più bella? Se tu non nutrissi altro desiderio e altra gioia che amare Dio, non ti importerebbe nulla di queste cose. È una pena grande osservare alcune persone spirituali così attaccate alla forma e alla figura di questi oggetti, ai motivi, alla curiosità e alla gioia frivola che ripongono in essi. Non le vedrete mai soddisfatte, passano irrequiete dagli uni agli altri, dimenticando la devozione spirituale a causa di questi oggetti sensibili; vi si attaccano con spirito di possesso, che a volte è simile a quello che nutrono per i beni temporali, da cui ricavano non poco danno.
CAPITOLO 36
Ove si parla delle immagini e dell’ignoranza di certe persone su questo punto.
1. Ci sarebbe molto da dire sull’ignoranza di un gran numero di persone a riguardo delle immagini. L’insensatezza di alcuni arriva a tanto da confidare più in un’immagine che in un’altra, convinte che Dio le ascolterà di più attraverso questa che quella, anche se entrambe rappresentano il medesimo soggetto, come ad esempio due immagini di Cristo o della Madonna. Questo perché sono più affezionati a una figura piuttosto che a un’altra. Tutto ciò rivela una profonda ignoranza nei rapporti con Dio e circa il culto e l’onore dovutogli; in realtà, egli guarda solo alla fede e alla purezza del cuore di colui che prega. Se Dio talvolta accorda più grazie attraverso un’immagine che non un’altra, non è perché la prima abbia maggior potenza della seconda, anche se la loro forma è molto diversa, ma perché la devozione delle persone è maggiormente risvegliata dall’una che dall’altra. Se avessero la medesima devozione per entrambe, o anche senza nessuna delle due, riceverebbero le stesse grazie da Dio.
2. Il motivo, quindi, per cui Dio compie miracoli e accorda grazie tramite alcune immagini piuttosto che altre, non è perché valgano di più, ma per il solo fatto che risvegliano maggiormente nei fedeli la devozione assopita e l’amore alla preghiera. Perciò, come nel tal caso e per mezzo della tale immagine si risveglia la devozione e si intensifica la preghiera, unici motivi per cui Dio ascolta e concede ciò che gli chiediamo, così, per l’orazione e l’amore risvegliati da quell’immagine, Dio continua a effondere grazie e a operare miracoli attraverso di essa. Questa di per sé non è altro che una semplice pittura, ragion per cui Dio agisce in virtù della devozione e della fede che si ha per il santo rappresentato nell’immagine. Pertanto, se tu avessi la stessa devozione e la stessa fede per la Madonna di fronte a una sua immagine piuttosto che a un’altra, o anche senza immagini, riceveresti la stesse grazie. L’esperienza stessa dimostra che se Dio concede grazie e opera miracoli, di solito li fa attraverso immagini non molto ben scolpite o stupendamente dipinte e raffigurate, perché i fedeli non attribuiscano tali grazie alla forma o alla pittura.
3. Molte volte il Signore concede grazie tramite immagini che si trovano in luoghi molto appartati e solitari. Anzitutto perché lo stesso fatto di doversi muovere per andare a vederle accresce la devozione e rende più intenso l’atto. In secondo luogo perché, per pregare, la gente si allontana dal rumore, come faceva il Signore (Mt 14,23; Lc 6,12). Per questo, chi fa un pellegrinaggio, è bene che lo faccia quando non c’è altra gente, anche in tempi straordinari. Quando c’è molta folla non glielo consiglierei mai perché, di solito, si torna più distratti di quando si è partiti. Molti poi lo fanno più per ricreazione che per devozione. Così, dunque, quando c’è devozione e fede, qualsiasi immagine è sufficiente, ma se vengono a mancare l’una e l’altra non sarà sufficiente alcuna immagine. Il Signore era certamente un’immagine viva quando era in questo mondo; tuttavia coloro che non avevano fede, pur andando con lui e vedendo le sue opere meravigliose, non ne traevano alcun profitto. Proprio per questo, come dice l’evangelista (Mt 13,58), non operò molti prodigi nel suo paese.
4. In questa sede voglio parlare anche di alcuni effetti soprannaturali che a volte determinate immagini provocano in certe persone. Ad alcune immagini Dio concede una virtù particolare, per cui rimane fissata nella mente l’immagine e la devozione che ha suscitato nello spirito, come fossero presenti. Ogni volta che uno improvvisamente se ne ricorda, prova lo stesso effetto, più o meno intenso, di quando le vide la prima volta; un’altra immagine, invece, anche se fatta meglio, non produrrà lo stesso effetto.
5. Molte persone, poi, hanno devozione più per le immagini fatte in un modo che in un altro, e in alcuni ciò è solo questione di affetto o gusto naturale. Per esempio, a qualcuno il volto di una persona piace più di un altro, si affeziona naturalmente più ad essa e l’avrà sempre presente nella sua immaginazione, anche se non è bella come le altre, perché ha un’attrazione naturale per quella sorta di forma e di figura. Così alcuni penseranno che l’affetto che nutrono per una determinata immagine sia devozione, mentre forse è solo affetto e gusto naturale. Altre volte accade che, fissando un’immagine, la vedono muoversi, cambiare fisionomia o fare gesti quasi volesse far capire qualcosa e parlare. Questi fatti soprannaturali delle immagini, di cui parliamo, molto spesso sono realmente veri e buoni, perché provocati da Dio o per aumentare la devozione o perché l’anima abbia un sostegno a cui aggrapparsi nella sua debolezza e non perdersi nelle distrazioni. Tuttavia molte volte sono prodotti anche dal demonio per ingannare e nuocere all’anima. Per tutti questi motivi nel capitolo seguente indicherò la linea di condotta da tenere in casi del genere.
CAPITOLO 37
Ove si parla della necessità di indirizzare a Dio la gioia che la volontà ricava dalle immagini, in modo che non cada in errore e non venga ostacolata da esse.
1. Le immagini sono di grande utilità per ricordarsi di Dio e dei santi e muovere la volontà alla devozione, se usate per via ordinaria e correttamente. Al contrario, possono far cadere in gravi errori se, quando accade qualcosa di soprannaturale legato ad esse, l’anima non sapesse comportarsi come deve nel suo itinerario verso Dio. Difatti uno dei mezzi di cui si serve il demonio per ingannare facilmente le anime imprudenti e impedire loro di seguire il cammino della vera vita spirituale, è costituito proprio dai fenomeni soprannaturali e straordinari. Egli li produce sia nelle immagini materiali e corporali in uso nella Chiesa, sia in quelle di un santo o di una sua effigie che egli stesso imprime nella fantasia, mascherandosi da angelo di luce proprio per ingannare (2Cor 11,14). L’astuto demonio adopera gli stessi mezzi che abbiamo come rimedio e sostegno; cerca di occultarsi per sorprenderci quando siamo più incauti. Per questo motivo, l’anima virtuosa deve sempre sospettare di più nel bene che nel male, perché il male reca con sé la testimonianza di quello che è.
2. Pertanto occorre evitare tutti i danni ai quali l’anima è esposta in questi casi. Tali inconvenienti consistono nell’essere impedita di volare verso Dio, nel servirsi in maniera grossolana e con ignoranza delle immagini, nell’essere ingannata naturalmente o soprannaturalmente tramite esse, tutte cose di cui ho parlato prima. Occorre, inoltre, purificare la gioia che la volontà pone in tali immagini, e attraverso di esse elevare l’anima a Dio, perché questo è lo scopo della Chiesa nel raccomandare l’uso delle immagini. Per conseguire questi risultati, intendo dare solo un avvertimento, che sarà sufficiente per tutto, ed è questo: poiché le immagini fungono da mezzi perché ci ricordiamo delle cose invisibili, cercheremo in esse solo il motivo che spinge la volontà ad affezionarsi alla realtà vivente che esse rappresentano e a riporre lì la nostra gioia. Il fedele, quindi, abbia cura di non ricercare la soddisfazione dei sensi quando vede un’immagine, sia corporale che immaginaria, di bella fattura o riccamente adornata, capace di suscitargli una devozione sensitiva o spirituale, anche quando gli lancia dei segni soprannaturali. Non dia la minima importanza a queste cose secondarie. Non si rifugi in tale immagine, ma elevi subito la mente a ciò che essa rappresenta, riponendo in Dio, o nel santo che invoca, la gioia e il compiacimento della sua volontà attraverso la preghiera e la vera devozione. Difatti ciò che vi è di vivente e di spirituale non dev’essere vanificato dalla pittura dell’immagine o dall’impressione sensibile. In questo modo il devoto non sarà ingannato, perché non terrà conto di ciò che l’immagine gli dirà, né impedirà ai sensi o allo spirito di dirigersi liberamente verso Dio, né avrà più fiducia in un’immagine piuttosto che in un’altra. L’immagine che gli susciterà devozione soprannaturalmente, lo farà in modo più abbondante, perché egli si porterà immediatamente a Dio con amore. Del resto, ogni volta che Dio concede queste e altre grazie, le accorda inclinando l’amore e la gioia della volontà verso ciò che è invisibile. Così vuole che facciamo anche noi, annientando la forza e il giogo delle nostre potenze che ci inclinano alle cose visibili e sensibili.
CAPITOLO 38
Ove si continua a parlare dei beni spirituali che accendono la devozione. Si parla degli oratori e dei luoghi consacrati alla preghiera.
1. Credo di aver fatto capire come la persona spirituale che ripone la gioia e il compiacimento nelle cose accessorie delle immagini possa cadere in molte imperfezioni, forse anche più pericolose che se essa si attaccasse agli altri beni corporali e temporali. Dico: forse di più, perché, sostenendo che sono cose sante, si sente più sicura e non ha paura dello spirito di possesso e di attaccamento naturale. Così facendo, si sbaglia profondamente, pensando di essere già colma di devozione, perché prova gusto per queste cose sante, mentre forse è solo una disposizione e una tendenza naturale che inclina verso questi oggetti come verso altri.
2. Parlerò adesso dei luoghi di preghiera, in cui alcune persone non si stancano di appendere sempre nuove immagini. Si compiacciono di disporle con ordine e gusto, perché l’oratorio sia ben decorato e faccia bella figura. Non amano di più Dio a motivo di queste cose, anzi meno, perché, come ho detto, sottraggono alla realtà vivente l’amore che portano ai dipinti e agli ornamenti. Senza dubbio ogni ornamento, ogni addobbo e tutta la venerazione che si può avere per le immagini è poca cosa rispetto a quello che esse meritano. È anche vero che coloro che le trattano con poco decoro e rispetto sono da biasimare, e ugualmente quelli che le fanno così male che, anziché favorire la devozione, la fanno passare; per questo si dovrebbe proibire a certi artigiani l’esercizio di quest’arte, perché, incapaci, lavorano rozzamente. Ma tutto questo cos’ha a che fare con lo spirito di possesso, l’attaccamento e l’affezione che tu hai per questi ornamenti e decorazioni esteriori, se ti assorbono i sensi fino a impedire al tuo cuore di andare a Dio e di amarlo dimenticando tutte le cose per amor suo? Se a causa di quelle cose manchi al tuo dovere, non solo non sarai gradito a Dio, ma egli ti punirà, perché hai cercato in tutte le cose il tuo piacere e non il suo. Tutto questo lo puoi comprendere molto bene se pensi alla festa che fecero al Re divino quando entrò in Gerusalemme. Lo accolsero con canti e rami d’olivo (Mt 21,8-9; Mc 11,8-10; Lc 19,37-38; Gv 12,13), mentre il Signore piangeva (Lc 19,41). Essi, infatti, avendo il cuore lontano da lui, credevano di ripagarlo dei suoi benefici con quelle manifestazioni esteriori. In realtà facevano festa più a se stessi che a Dio. Anche oggi non mancano persone che, quando vi è una festa solenne da qualche parte, si rallegrano, più che per l’onore che ne viene a Dio, per i divertimenti che vi trovano, per la possibilità di ammirare ed essere ammirati, per il mangiare bene e per altre cose di questo genere. Simili inclinazioni o intenzioni non sono affatto gradite a Dio, soprattutto quando gli organizzatori delle feste vi introducono cose ridicole e profane, solo per far ridere la gente, contribuendo così a farla distrarre maggiormente; altri poi organizzano cose che, invece, di suscitare devozione, solleticano il piacere della gente.
3. Cosa dire poi di altri interessi che alcuni hanno nelle feste che celebrano? Essi sanno, e Dio vede, che badano più al guadagno che alla gloria di Dio. In ogni caso, quando accade così, siano pur certi che fanno festa a se stessi, non a Dio. Tutto ciò che fanno per procurare piacere a se stessi o agli altri, Dio non lo considera. Anzi vi sono molti che si rallegreranno con coloro che partecipano alle feste del Signore, mentre Dio si adira con loro, come fece con i figli d’Israele allorché, pensando di festeggiare Dio, ballavano e cantavano davanti al loro idolo: Dio ne fece morire molte migliaia (Es 32,7-28). Anche i sacerdoti Nadab e Abiu, figli di Aronne, furono stroncati da Dio con gli incensieri in mano perché offrivano un fuoco illegittimo (Lv 10,1-2). Allo stesso modo il Signore s’indignò con quel tale che era entrato nella sala del banchetto vestito male, senz’abito nuziale: Il re comandò che fosse gettato nelle tenebre esteriori con le mani e i piedi legati (Mt 22,12-13). Da ciò si vede che Dio non sopporta quelle irriverenze che si commettono nelle feste fatte in suo onore. Quante feste, mio Dio, fanno i figli degli uomini, nelle quali viene onorato il demonio più di te! Al demonio piacciono, perché in esse, come il mercante, trova la sua piazza di mercato. Quante volte, Signore, dirai di esse: Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me, perché mi serve senza motivo! (Mt 15,8-9). Dio, infatti, dev’essere servito solo per quello che è, non frapponendo altri fini; se non lo serviamo solo per quello che è, lo serviamo senza considerarlo come causa ultima.
4. Tornando agli oratori, dico che alcuni li adornano più per la loro personale soddisfazione che per piacere a Dio. Altri, al contrario, si preoccupano talmente poco del rispetto che ad essi è dovuto da non stimarli più dei loro salottini privati, anzi meno, poiché hanno più gusto per le cose profane che per quelle divine.
5. Ma per il momento lascio da parte queste persone e parlo di quelli che si comportano in maniera più sottile, cioè di coloro che si considerano persone devote. Vi sono molti fra costoro che provano una tale attrazione per il loro oratorio e un tale piacere nell’addobbarlo da impiegarvi tutto il tempo che dovrebbero dedicare a pregare Dio e a raccogliersi interiormente. Non si accorgono che se tutto questo non è finalizzato al raccoglimento interiore e alla pace dell’anima, sarà motivo solo di distrazione, come tutto il resto; il loro attaccamento e il loro gusto saranno fonte di continua inquietudine, soprattutto se qualcuno provasse a impedirglielo.
CAPITOLO 39
Ove si parla di come ci si deve servire degli oratori e dei templi, considerandoli mezzi per elevare lo spirito a Dio.
1. Per elevare lo spirito a Dio attraverso gli oggetti di culto è opportuno ricordare che ai principianti è permesso, come del resto è anche utile, provare qualche gusto o piacere sensibile per le immagini, gli oratori e altri oggetti materiali di devozione. Essi, infatti, non hanno ancora perduto il gusto e non sono ancora distaccati dalle cose di questo mondo, così da poterlo sostituire con il gusto dell’altro. Si fa così anche con il bambino, per non farlo piangere: gli si toglie una cosa dalla mano dandogliene subito un’altra. La persona spirituale che vuole progredire deve ugualmente spogliarsi di tutti questi gusti e desideri smodati nei quali la volontà può trovare piacere. L’uomo veramente spirituale si attacca molto poco a tutti questi oggetti, perché è intento solo al raccoglimento interiore e alla conversazione intima con Dio. Se utilizza le immagini e gli oratori, lo fa solo di passaggio e subito fissa il suo spirito in Dio, dimenticando tutto ciò che è sensibile.
2. Pertanto, sebbene sia meglio pregare dove c’è maggior decoro, tuttavia, e malgrado ciò, va scelto il luogo dove i sensi siano meno attratti e lo spirito possa andare meglio a Dio. A questo proposito occorre qui ricordare quanto il Signore rispose alla samaritana, quando gli chiese quale fosse il posto migliore per pregare, se il tempio o il monte. Il Maestro le rispose che la vera preghiera non è legata né al monte né al tempio, ma che i veri adoratori graditi a Dio sono quelli che lo adorano in spirito e verità (Gv 4,23-24). Di conseguenza, se i templi e i luoghi appartati sono dedicati e adatti alla preghiera, perché il tempio non dev’essere usato per altri scopi, tuttavia, quando si tratta di una faccenda tanto intima come quella riguardante il rapporto con Dio, occorre scegliere il luogo che attira e cattura meno i sensi. Non dev’essere un luogo ameno e attraente per i sensi, come vogliono alcuni, perché, invece di raccogliersi in Dio, lo spirito si ferma nel diversivo piacevole e gustoso dei sensi. A tale scopo va bene un luogo solitario e impervio, dove lo spirito possa elevarsi sicuramente e direttamente a Dio, non impedito o trattenuto dalle cose visibili. Alcune volte queste aiutano lo spirito a elevarsi, ma solo quando vengono subito dimenticate per fissarsi in Dio. Per questo motivo il Signore di solito sceglieva luoghi appartati per pregare (Mt 14,23), e luoghi che non attraessero molto i sensi, per darci l’esempio. Preferiva luoghi che elevano l’anima a Dio, come i monti che si elevano da terra, generalmente brulli, senza possibilità di distrazione per i sensi (Lc 6,12).
3. La persona veramente spirituale, dunque, non si preoccupa se il luogo per pregare abbia un aspetto piuttosto che un altro, perché questo vorrebbe dire essere ancora legati ai sensi. Va in cerca solo del raccoglimento interiore, dimentica di tutte le altre cose, scegliendo quindi il luogo più spoglio di oggetti e di attrattive sensibili. Inoltre non presta attenzione alle cose esteriori, onde gustare meglio il suo Dio, lontana da tutte le creature. Desta meraviglia vedere persone spirituali che occupano tutto il loro tempo nell’adornare oratore e preparare angolini adatti al loro temperamento e alla loro inclinazione. Quanto, invece, al raccoglimento interiore, che è la cosa più importante, ne hanno molto poco e ne tengono poco conto; se l’avessero, non proverebbero soddisfazione, anzi si stancherebbero di tutti quegli ornamenti e decorazioni.
CAPITOLO 40
Ove si continua a indirizzare lo spirito verso il raccoglimento interiore attraverso l’uso dei beni di cui si parla.
1. Il motivo per cui alcune persone spirituali non riescono mai ad entrare nella vera gioia dello spirito è perché non si decidono a staccarsi dal godimento che procurano le cose esteriori e visibili. Si ricordino che, se il luogo migliore e più adatto alla preghiera è il tempio o l’oratorio visibile, se l’immagine serve a questo scopo, non necessariamente si deve riservare il piacere e il godimento spirituale al tempio visibile o all’immagine, dimenticando di pregare nel tempio vivo, che è la parte più intima dell’anima. Questo è appunto quanto ci ricorda l’Apostolo quando dice: Non sapete che siete tempio di Dio e lo Spirito Santo abita in voi? (1Cor 3,16). Questa riflessione ci riporta all’affermazione di Cristo, già citata: I veri adoratori devono adorare in spirito e verità (Gv 4,24). A Dio, infatti, interessano poco le tue preghiere e i tuoi luoghi ben adornati se, riponendo in queste cose il tuo piacere e la tua soddisfazione, non sei distaccato interiormente e non hai la povertà spirituale, la quale consiste nella rinuncia a tutte le cose che puoi possedere.
2. Per purificare la volontà dalla gioia e dalla vana soddisfazione che provi in queste cose e indirizzarla a Dio nella tua preghiera, devi fare in modo che la tua coscienza sia pura, la tua volontà sia rivolta interamente a Dio e la tua mente unicamente fissa in lui. Poi, come ho già detto, devi scegliere il luogo più appartato e solitario possibile per mettere tutta la gioia della volontà nel pregare e glorificare Dio. Quanto ai piccoli sentimenti di devozione, non farci caso, anzi cerca di respingerli. Se l’anima, infatti, si abitua al sapore della devozione sensibile, non riuscirà mai a possedere, attraverso il raccoglimento interiore, le forti dolcezze spirituali, che si trovano nella nudità dello spirito.
CAPITOLO 41
Ove si parla di alcuni danni ai quali si espongono coloro che si lasciano andare al gusto delle cose sensibili e dei luoghi di devozione di cui ho parlato.
1. Va incontro a molti inconvenienti, sia interiori che esteriori, la persona spirituale che corre dietro ai gusti sensibili per le cose suddette. Per quanto riguarda lo spazio interiore, l’anima non arriverà mai al raccoglimento dello spirito, che consiste nel fare a meno di tutti questi oggetti, dimenticare tutti i gusti sensibili, rifugiarsi nel suo intimo e acquisire virtù solide. Circa gli inconvenienti esteriori, risulta che non riesce a pregare in tutti i luoghi, ma solo in quelli di suo gusto, e così, molte volte, mancherà alla preghiera, perché, come si dice, sa leggere solo nel suo libro.
2. Oltre a ciò, tale attrazione per i gusti sensibili provoca nelle persone spirituali continui cambiamenti; appartengono a questa categoria di persone coloro che non sanno stare a lungo nello stesso posto e a volte non perseverano nella loro vocazione. Li vedrete oggi qua, domani là; ora scelgono un eremo, ora un altro; ora addobbano un oratorio, ora un altro. Vi sono anche di quelli che passano la vita a cambiare stato e modo di vivere. Conoscono solo quel fervore e quei gusti sensibili per le cose spirituali. Non si sono mai sforzati di arrivare al raccoglimento spirituale attraverso la rinuncia alla loro volontà e l’adattamento ai disagi. Ogni volta che vedono un luogo devoto di loro gradimento, o qualche forma di vita o stato che si addica al loro temperamento o inclinazione, vi corrono subito, abbandonando quello che prima avevano abbracciato. Ma poiché si lasciano muovere dall’attrazione sensibile, ben presto cercano qualcos’altro, perché l’attrazione sensibile non è costante, ma viene meno molto presto.
CAPITOLO 42
Ove si parla di tre diversi luoghi di devozione e come deve comportarsi la volontà nei loro riguardi.
1. Credo che ci siano tre diversi tipi di luoghi per mezzo dei quali Dio è solito indurre la volontà alla devozione. Il primo tipo è caratterizzato dalla conformazione del suolo e della località. Il loro aspetto gradevole, la varietà del terreno e della vegetazione, la tranquilla solitudine risvegliano facilmente la devozione. È bene approfittare di questi luoghi, ma a condizione di dimenticarli subito per elevare la volontà verso Dio, perché chi vuole raggiungere il fine non deve fermarsi ai mezzi e alle cause. Se si cerca in essi un piacere e un profitto per i sensi, si troverà invece solo aridità e distrazione per lo spirito: la soddisfazione e la gioia dello spirito si trovano solo nel raccoglimento interiore.
2. Per questi motivi, quando si è in luogo di tal genere occorre, dimentichi di esso, cercare di stare intimamente con Dio, come se non si fosse in quel luogo. Se ci si ferma alla gioia e al piacere derivante dal luogo, si ricerca una ricreazione per i sensi e uno spazio all’instabilità dello spirito piuttosto che la pace interiore. Così facevano gli anacoreti e i santi eremiti, che nei vastissimi e affascinanti deserti occupavano meno terra possibile per costruirvi celle anguste e grotte dove isolarsi. San Benedetto rimase tre anni in una grotta; un altro, di nome san Simone, si legò con una corda per non andare oltre il limite fissato da questo legame. Così pure fecero molti altri che non finirei di ricordare. Quei santi avevano capito benissimo che se non avessero mortificato le loro tendenze sregolate e la bramosia di gioie e soddisfazioni spirituali, non avrebbero potuto raggiungere le gioie dello spirito né diventare spirituali.
3. Il secondo tipo di luogo che agevola la devozione è molto particolare, perché riguarda alcuni posti, non importa se deserti o meno, nei quali Dio è solito accordare ad alcune persone grazie spirituali assai piacevoli. Così, ordinariamente, accade che il cuore della persona favorita da Dio rimanga legato al luogo dove ha ricevuto la tal grazia e prova spesso il desiderio fortissimo di ritornarvi. Ma quando vi ritorna, non avverte più le stesse sensazioni di prima, perché non dipende da lei ricevere simili favori. È Dio, infatti, che concede queste grazie quando e come vuole, senza essere legato a un determinato luogo o momento e neppure alla volontà di colui al quale le accorda. Tuttavia è bene che la persona ritorni talvolta in quel luogo per pregare, a patto che sia distaccata da ogni cosa, per tre motivi: primo, perché se, come dicevo, Dio non è legato ad alcun luogo, sembra però che abbia voluto legarsi a quello lì per esservi lodato dall’anima alla quale ha concesso quella determinata grazia. Secondo, perché l’anima si dispone meglio a ringraziare Dio per il beneficio che ha ricevuto in quel luogo. Terzo, perché lì la devozione si risveglia di più, grazie al ricordo.
4. Questi sono i motivi per cui è bene che la persona ritorni in quel luogo, non ritenendo, però, che Dio sia obbligato a concederle favori proprio lì e non altrove. L’anima, infatti, è il posto più adatto a Dio di qualsiasi altro luogo terreno. Leggiamo nella sacra Scrittura che Abramo innalzò un altare dove Dio gli era apparso e lì invocò il suo nome; in seguito, di ritorno dall’Egitto, ripercorse la stessa strada, ritornò dove gli era apparso Dio e lo invocò di nuovo sullo stesso altare che aveva edificato (Gn 12,8; 13,4). Anche Giacobbe contrassegnò il luogo dove gli era apparso Dio in cima alla scala, elevandovi un pietra cosparsa di olio (Gn 28,13-18). E Agar, apprezzando molto il luogo dove le era apparso l’angelo, gli diede un nome dicendo: Qui dunque sono riuscita ancora a vedere, dopo la mia visione? (Gn 16,13).
5. Il terzo tipo di luogo che stimola la devozione è quello che Dio sceglie in particolar modo per esservi invocato, come il monte Sinai, dove diede la legge a Mosè (Es 24,12), o il luogo che indicò ad Abramo per sacrificarvi suo figlio (Gn 22,2). È altresì il monte Oreb, dove apparve al nostro padre Elia (1Re 19,8), e il monte Gargano – scelto da Dio per il suo servizio – dedicato a san Michele, che apparve al vescovo di Siponto, al quale rivelò di essere lui il custode di quel luogo e comandò di erigervi un oratorio in memoria degli angeli. Anche la gloriosa Vergine scelse a Roma, per mezzo del prodigio della neve, il luogo dove chiese a Patrizio di erigerle un tempio.
6. Solo Dio conosce il motivo per cui sceglie questi luoghi, invece di altri, per esservi lodato. A noi basti sapere che servono al nostro profitto spirituale e che Dio ascolta le nostre preghiere lì e ovunque lo preghiamo con fede viva. Tuttavia i luoghi consacrati al suo servizio sono un’occasione più propizia per essere esauditi, perché la Chiesa li ha segnalati e riservati a questo scopo.
CAPITOLO 43
Ove si parla dei mezzi, costituiti da una grande varietà di cerimonie, a cui molte persone ricorrono per pregare.
1. Le gioie inutili e lo spirito imperfetto di attaccamento che molti nutrono per le cose di cui ho parlato, forse sono in parte tollerabili perché coltivati con una certa ingenuità. Quanto, invece, al forte attaccamento che alcuni mostrano per molte cerimonie introdotte da gente poco illuminata e priva della semplicità della fede, bisogna dire che esso è insopportabile. Lascio da parte, per ora, le pratiche di pietà ridondanti di paroloni o termini che non significano nulla e altre cose non sacre che persone ignoranti, grossolane e sospette sono solite mescolare alle loro preghiere. Qui non ne parlo perché sono chiaramente cattive ed è peccato servirsene; addirittura, in molti casi nascondono un patto occulto con il demonio. Così, anziché attirare la misericordia di Dio, suscitano la sua ira.
2. Qui voglio parlare solo di quelle pratiche che, pur essendo prive di ogni superstizione, vengono oggi usate da molte persone dalla devozione indiscreta. Esse credono ciecamente all’efficacia delle loro particolari devozioni e preghiere, sino a pensare che, se in esse manca qualcosa o non sono eseguite alla perfezione, non valgono nulla e Dio non le gradisce. In realtà ripongono più fiducia nelle loro pratiche e cerimonie che nella sostanza della preghiera, e ciò non senza irriverenza e offesa per il Signore. Così, per esempio, pretendono che la messa venga celebrata con un certo numero di candele, non di più né di meno; che il sacerdote la celebri in un modo ben preciso, a una determinata ora, né prima né dopo, in quel dato giorno e non prima; che le preghiere e le stazioni siano tante e tali e in giorni ben precisi e condotte con quelle specifiche cerimonie e non in altro modo; che la persona che le compie abbia determinate doti e caratteristiche. E sono convinti che, se manca qualcosa di quello che hanno deciso, non si fa nulla, e mille altre cose che si usano e si vedono fare.
3. Ma ciò che è peggio e intollerabile, è che alcuni vogliono provare in sé qualche effetto di quelle pratiche, veder realizzato ciò che chiedono, o sapere che lo scopo di quelle loro preghiere piene di cerimonie venga raggiunto. Tutto ciò equivale a tentare Dio e a dispiacergli profondamente. Così, spesso, Dio permette al demonio di trarre in inganno queste persone, di far loro sentire e conoscere cose molto opposte al profitto della loro anima. Meritano questo trattamento per lo spirito di attaccamento che mostrano nei riguardi delle loro pratiche di pietà: desiderano che si realizzi più quello che pretendono loro che quello che vuole Dio. Poiché non ripongono tutta la loro fiducia in Dio, non traggono mai alcun vantaggio da queste loro pratiche.
CAPITOLO 44
Ove si dice quanto sia necessario attraverso queste devozioni indirizzare a Dio la gioia e la forza della volontà.
1. Le persone di cui sto parlando devono sapere che quanto più importanza annettono a queste cose e cerimonie, tanta minor fiducia hanno in Dio; così non otterranno mai da lui quanto desiderano. Alcune pregano più per conseguire quanto vogliono loro che per onorare Dio. Senza dubbio sanno che, se Dio vorrà, sicuramente concederà quella grazia che chiedono, altrimenti non la concederà; tuttavia per l’attaccamento alla loro volontà e la gioia vana che mostrano in tutto questo, moltiplicano troppo le preghiere per raggiungere il loro scopo. Forse sarebbe meglio se indirizzassero tali preghiere a cose più importanti, come ad esempio una vera purezza della loro coscienza, un impegno concreto per quanto riguarda la loro salvezza e la relativizzazione di tutto ciò che non tende a questo scopo primario. In questo modo otterranno non solo quanto è più importante per loro, ma sarà accordato anche tutto ciò che è utile. Pur senza chiederlo, otterranno quanto domandano molto meglio e di più che se avessero impiegato tutta la loro devozione.
2. Ciò è quanto il Signore promette allorché afferma nel vangelo: Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta (Mt 6,33). Questo è il desiderio, questa è la domanda che gli piace di più. Per ottenere le richieste che abbiamo nel nostro cuore non c’è mezzo migliore che riporre la forza della nostra preghiera in quelle cose che piacciono di più a Dio; in tal caso, infatti, ci concederà non solo ciò che chiediamo, cioè la salvezza, ma anche ciò che secondo lui è utile e buono per noi, anche se non glielo chiediamo. Ciò è quanto fa chiaramente capire Davide in un salmo, quando dice: Il Signore è vicino a quanto lo invocano con sincerità, che chiedono cose elevatissime, come quelle della salvezza eterna; di essi dice subito dopo: Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva. Il Signore protegge quanti lo amano (Sal 144,18-20). Quando Davide dice che Dio è vicino, vuol significare che egli tiene ad esaudire i loro desideri e concedere anche ciò che essi non pensano di chiedere. Leggiamo nella Scrittura che, avendo Salomone chiesto a Dio una cosa che gli era gradita, cioè la sapienza per governare il suo popolo nella giustizia, Dio gli rispose: Poiché ti sta a cuore una cosa simile e poiché non hai domandato né ricchezze né beni né gloria né la vita dei tuoi nemici e neppure una lunga vita, ma hai domandato piuttosto saggezza e scienza per governare il mio popolo, su cui ti ho costituito re, saggezza e scienza ti saranno concesse. Inoltre io ti darò ricchezze, beni e gloria, quali non ebbero mai i re tuoi predecessori e non avranno mai i tuoi successori (2Cr 1,11-12). Dio mantenne la promessa. Difatti stabilì la pace tra lui e i suoi nemici, obbligandoli a pagargli il tributo e a non infastidirlo più. Un altro episodio simile lo troviamo nel libro della Genesi. Avendo Dio promesso ad Abramo di moltiplicare la discendenza del figlio legittimo come le stelle del cielo, come gli aveva chiesto, aggiunse: Moltiplicherò anche quella del figlio della schiava, perché è tuo figlio (Gn 21,13).
3. Tutto questo spiega perché, quando preghiamo, dobbiamo indirizzare a Dio tutta l’energia e la gioia della nostra volontà, senza andare in cerca di cerimonie nuove, non approvate né usate dalla Chiesa cattolica. Si lasci al sacerdote celebrare la messa secondo il rito proprio della Chiesa del luogo, perché da essa egli prende gli ordini e riceve i riti che deve seguire. Non si cerchi d’introdurre nuovi riti, quasi che si sappia più dello Spirito Santo e della sua Chiesa. Se Dio non esaudisce quando lo si prega in tutta semplicità, non si pensi che lo faccia davanti a tutte le nostre invenzioni! Dio, infatti, è tale che chi lo prende con le buone e alla sua maniera, ottiene da lui tutto ciò che vuole, ma se uno va a lui per interesse, allora è meglio che non gli parli nemmeno.
4. Quanto alle altre cerimonie riguardanti la preghiera o certe devozioni, non ci si attacchi a riti o modi di pregare diversi da quelli che ci ha insegnato Cristo (cfr. Lc 11,1-2). È fuori dubbio che, quando i discepoli chiesero al Signore che insegnasse loro a pregare, egli rivelò loro tutto quanto occorreva perché fossero ascoltati dal Padre eterno, di cui conosceva molto bene la volontà. In quell’occasione insegnò loro solo le sette domande del Padre nostro, che comprendono tutte le nostre necessità spirituali e temporali, e non già tantissime altre preghiere e cerimonie. Anzi, in un’altra circostanza, disse loro che, quando pregavano, non dovevano parlare molto, perché il Padre celeste sa molto bene ciò di cui hanno bisogno (Mt 6,7-8); soltanto raccomandò loro, insistentemente, di perseverare nella preghiera, cioè nel Padre nostro, dicendo che è necessario pregare sempre, senza stancarsi (Lc 18,1). Non insegnò molte formule di domanda, ma raccomandò di ripetere spesso quelle sette, con fervore e attenzione; in esse, infatti, è racchiusa tutta la volontà di Dio e ciò che conviene a noi. Per questo, quando nostro Signore si rivolse tre volte al Padre eterno, sempre pregò con le stesse parole del Padre nostro, come osservano gli evangelisti: Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu! (Mt 26,39). Quanto alle condizioni da seguire nella preghiera, si possono ridurre all’una o all’altra di queste due seguenti: o isolarsi nel nascondimento della propria stanza, ove, lontani da ogni rumore e senza render conto a nessuno, possiamo pregare con tutta la purezza del cuore, come il Signore stesso ci raccomandò dicendo: Quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto (Mt 6,7); oppure rifugiarsi in luoghi solitari, come faceva lui, per pregare nel tempo migliore e più silenzioso della notte (Lc 6,12). Non è quindi il caso di fissare tempi precisi in giorni precisi, né stabilire alcuni giorni più che altri per le nostre devozioni. Non dobbiamo neppure andare in cerca di formule, giochi di parole od orazioni diverse da quelle usati dalla Chiesa e secondo il rito di cui essa si serve, perché tutte le preghiere si riducono a quelle contenute nel Padre nostro.
5. Con questo non intendo condannare – anzi approvo – quei giorni che alcune persone stabiliscono per fare le loro devozioni, come novene, digiuni o cose del genere. Ciò che condanno, invece, è l’attaccamento a tale o tal altro esercizio di pietà o cerimonia determinata. A questo proposito si noti ciò che fece Giuditta. Rimproverò gli abitanti di Betulia perché avevano stabilito a Dio un tempo limitato entro cui si attendevano la sua misericordia, dicendo loro: Non pretendete di impegnare i piani del Signore. No, fratelli, non vogliate irritare il Signore nostro Dio (Gdt 8,11-12).
CAPITOLO 45
Ove si tratta del secondo genere di beni distinti, cioè quelli provocativi, di cui la volontà può compiacersi inutilmente.
1. Il secondo genere di beni particolari e piacevoli, dei quali la volontà può vanamente godere, sono quelli che invitano o spingono a servire Dio: li chiamo provocativi. Tali sono le predicazioni, che possiamo considerare sotto due aspetti, cioè quello che riguarda gli stessi predicatori e quello che riguarda gli ascoltatori. Non è superfluo, infatti, dare dei consiglio agli uni e agli altri sul modo di elevare a Dio la gioia della loro volontà nel compimento di questa pratica.
2. Per quanto riguarda il primo, cioè il predicatore, per essere di giovamento ai fedeli e non lasciarsi andare a una vana compiacenza o alla presunzione, deve ricordare che la predicazione è un esercizio più spirituale che vocale. La forza e l’efficacia di persuasione dipendono unicamente dallo spirito interiore, anche se vanno espresse con le parole. Quindi, per quanto alta sia la dottrina predicata, brillante l’esposizione e sublime lo stile con cui la si porge, di solito produce un risultato proporzionato allo spirito interiore del predicatore. Sebbene, infatti, sia vero che la parola di Dio è di per se stessa efficace – come dice Davide: Egli tuona con voce potente (Sal 67,34) – tuttavia occorre anche ricordare che il fuoco ha la proprietà di bruciare, ma brucia solo quando il soggetto è in condizioni di ardere.
3. Ora, perché la predicazione produca il suo effetto, si devono realizzare due condizioni: una da parte di chi predica, e l’altra da parte di chi ascolta; ma abitualmente l’effetto desiderato dipende dalla disposizione di colui che predica. Per questo si dice: quale il maestro, tale il discepolo. Negli Atti degli Apostoli leggiamo che quando i sette figli di un sommo sacerdote giudeo presero a scongiurare i demoni con la stessa formula di san Paolo, il demonio s’infuriò contro di loro, esclamando: Conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? (At 19,15). E scagliatosi contro di loro, li denudò e li coprì di botte. Questo accadde non perché Cristo non volesse che cacciassero i demoni in nome suo, ma perché essi non avevano le qualità richieste. Difatti nella Scrittura leggiamo che una volta gli apostoli trovarono un tale che, pur non essendo discepolo di Cristo, cacciava un demonio in suo nome. Intervennero per impedirglielo, ma il Signore li rimproverò dicendo: Non glielo proibite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me (Mc 9,38). Il Signore si adira piuttosto con coloro che insegnano la legge di Dio e non la praticano, predicano la virtù ma non la posseggono. Per questo san Paolo dice: Come mai tu, che insegni agli altri, non insegni a te stesso? Tu che predichi di non rubare, rubi? (Rm 2,21). E lo Spirito Santo dice per bocca di Davide: All’empio dice Dio: Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che detesti la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle? (Sal 49,16-17). Questo c’insegna che il Signore non darà a tali persone i doni necessari per fare del bene.
4. Ordinariamente vediamo che, per quanto se ne può giudicare quaggiù, quanto più è santa la vita del predicatore, tanto più abbondante è il frutto che produce, anche se il suo stile è umile, la sua oratoria scarsa e la sua dottrina comune. Lo spirito di vita da cui è animato comunica fervore. Un altro, invece, darà poco frutto, nonostante che il suo stile e la sua dottrina siano elevati. È proprio vero che un buono stile, dei bei gesti, una dottrina solida e una perfetta esposizione toccano e fanno più effetto se accompagnati da una vita virtuosa. Senza questa, invece, anche se il sermone solletica i sensi e l’intelligenza, poco o niente giova alla volontà, che ordinariamente rimane molto fiacca e debole nella pratica della virtù, com’era prima. Sebbene il predicatore abbia detto cose meravigliose, meravigliosamente esposte, essere servono solo all’udito, come una musica armoniosa o il suono di campane. Ma l’anima non esce dal suo solco, si ritrova al punto di prima, poiché la voce non ha la virtù di risuscitare i morti e farli uscire dal loro sepolcro.
5. Poco importa udire una parola più bella di un’altra se non mi spinge alla pratica della virtù. Sebbene siano stato dette cose meravigliose, vengono subito dimenticate, perché non hanno acceso la volontà. Infatti, oltre a non produrre di per sé grande frutto, quell’impressione gradevole lasciata nei sensi da tali parole impedisce all’insegnamento di arrivare allo spirito. Ci si limita, così, solo all’apprezzamento della forma e delle cose secondarie di cui è rivestita la predicazione. Si loda tale o tal altra qualità del predicatore, seguendolo più per questi motivi che per la correzione che si ricava dalle sue prediche. Tale è la dottrina che san Paolo spiega con chiarezza ai corinzi, quando scrive: Anch’io, fratelli, quando sono venuto tra voi, non mi sono presentato ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza… e la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza (1Cor 2,1-4). Certamente non è intenzione dell’Apostolo né mia condannare lo stile elegante, l’eloquenza e il linguaggio forbito, ché anzi sono molto utili alla predicazione, come a ogni altra funzione; una buona esposizione e uno stile avvincente, infatti, sollevano e guadagnano anche le cause perse o disperate, mentre un linguaggio non appropriato rovina e fa perdere anche quelle giuste.
APPENDICE
CAPITOLO 46
Ove si tratta della prima affezione della volontà e si dice che nulla di quello che tocca l’appetito può essere mezzo proporzionato perché l’anima si unisca a Dio secondo la volontà.
1. La prima delle passioni dell’anima e degli affetti della volontà è la gioia. La volontà la provoca sempre nell’anima quando gli oggetti le si presentano come buoni, convenienti, amabili e gradevoli oppure perché sembrano belli, piacevoli e preziosi, ecc. Per questo motivo la volontà si porta verso di essi, li desidera, vi ripone la sua compiacenza quando li possiede, ha paura di perderli e soffre quando li perde, ecc. Così, dunque, l’anima si agita e s’inquieta secondo la passione della gioia.
2. Per frenare questa passione e liberarla da tutto ciò che non è Dio, occorre sapere che tutto quello di cui la volontà può godere in modo particolare, come ho detto, è per essa soave e piacevole, ma nessuna cosa soave e piacevole che essa possa gustare è Dio. Infatti, ripeto, Dio non può essere percepito da nessuna delle altre potenze, né tanto meno dalle tendenze e dai gusti della volontà. In questa vita, dunque, l’anima non può gustare Dio essenzialmente, e tutta la soavità e le delizie che eventualmente prova, per quanto elevate siano, non possono mai essere Dio. Anche tutto ciò che la volontà può gustare e desiderare in modo particolare è quello che l’intelletto conosce come suo oggetto specifico. Ora, non avendo la volontà assaporato mai Dio com’egli è né avendolo conosciuto attraverso qualche percezione delle sue potenze, non può sapere come sia né come gustarlo. Le sue potenze non possono gustare e desiderare Dio, che è al di sopra di ogni sua capacità.
3. È quindi chiaro che nessuna cosa particolare, fra tutte quelle di cui può godere la volontà, è Dio. Per giungere all’unione con Dio deve, quindi, fare il vuoto nelle sue potenze e distaccarsi da tutte le gioie particolari, per quanto soavi e piacevoli appaiano, indipendentemente dal fatto che siano terrene o celesti. Se in qualche modo la volontà può comprendere Dio e unirsi a lui, ciò avviene non attraverso qualche mezzo percepibile delle sue potenze, ma tramite l’amore. Se un diletto o una soavità o qualsiasi altra gioia provata dalla volontà non è amore, ne risulta chiaramente che nessuno di questi sentimenti piacevoli può essere mezzo adeguato per l’unione dell’anima con Dio. Occorre a tale scopo l’operazione della volontà, operazione molto diversa dal suo sentimento. Tramite l’operazione essa si unisce a Dio e si realizza in lui che è amore, non attraverso il sentimento o la percezione dei suoi appetiti, che si conclude nell’anima come fine e termine ultimo.
4. I sentimenti possono fungere solo da motivo o movente per amare – se la volontà vuole passare oltre – e niente più. Così, i sentimenti piacevoli, per loro natura, non indirizzano l’anima a Dio, ma piuttosto la fanno ripiegare su se stessa. Solo l’operazione della volontà, che è amore per Dio, colloca l’anima in Dio, lasciando dietro di sé tutte le cose create, così che essa ama Dio al di sopra di tutto. Di conseguenza, quando una persona si decide ad amare Dio non a motivo del piacere che prova, subito lascia dietro di sé la soavità che sente e ripone il suo amore in Dio che non sente. Se invece riponesse il suo amore nella soavità e nel gusto che prova, limitandosi ad essi, ciò significherebbe fermarsi alle creature o a ciò che le riguarda, facendo del mezzo un fine e un termine ultimo, e così l’opera della volontà sarebbe viziata. Poiché Dio è incomprensibile e inaccessibile, la volontà, onde mettere la sua operazione di amore in Dio, non deve fissarla su ciò che può toccare e percepire, ma in ciò che non può comprendere né raggiungere con l’appetito. In questo modo l’anima amerà sul serio proprio come vuole la fede, anche nel vuoto e nel buio dei suoi sentimenti, soprattutto quelli che essa può percepire attraverso le capacità della sua mente, credendo al di sopra di ciò che può comprendere.
CAPITOLO 47
Ove si prosegue dicendo che per giungere all’unione con Dio è necessario che la volontà si spogli dei suoi appetiti naturali.
1. Avendo dimostrato che né la soavità né il piacere, ecc., che la volontà può provare in questa vita è Dio, sarebbe sciocco colui che, non provando soavità e delizie spirituali, pensasse per questo di non possedere Dio, oppure provandole si rallegrasse pensando per questo di possedere Dio. Costui sarebbe ancora più sciocco se cercasse queste soavità in Dio e si compiacesse in esse, perché non andrebbe in cerca del Dio inaccessibile con una volontà fondata nel vuoto della fede, ma sul gusto spirituale, cioè su qualcosa di creato, assecondando così i suoi appetiti. In questo modo egli non amerebbe in purezza di fede e sopra ogni cosa Dio, cioè riponendo in lui tutta la forza della volontà. Difatti, quando con i suoi desideri sregolati si attacca alle cose create, non si eleva al di sopra di esse per arrivare a Dio, che è inaccessibile. È impossibile che la volontà possa arrivare alle soavità e alle delizie della sublime unione con Dio, senza liberarsi da tutti gli appetiti per i piaceri particolari.
