Il prodigio dell'Ostia

Prodigio dell’Ostia che si solleva dalla patena
e rimane sospesa in aria per diversi minuti
<<l’Eucarestia è un mistero così grande>>, dice Allegri <<che confonde e spaventa la mente umana. Il Catechismo della Chiesa Cattolica insegna che nel Santissimo Sacramento dell’Eucarestia “è contenuto veramente, realmente, sostanzialmente il Corpo e il Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, con l’anima e la divinità, e, quindi, il Cristo tutto intero”. Quei tre termini “veramente, realmente, sostanzialmente” fanno tremare chiunque si soffermi a meditarli. Infatti, lungo il corso dei secoli, molti teologi, incapaci di credere a un mistero così grande, hanno cercato di dare spiegazioni più accettabili per la mente umana, allontanandosi però dalla sublime realtà insegnata da Gesù. La Chiesa è sempre intervenuta, fin dai primi tempi del Cristianesimo, condannando queste erronee interpretazioni che sono note con il termine di eresie. Ma anche la Provvidenza è intervenuta con “fatti prodigiosi” per richiamare l’attenzione degli uomini sulla reale presenza di Cristo nell’Eucarestia. Quei fatti sono i “Miracoli Eucaristici”. Il 7 novembre 1999 nella Basilica inferiore di Lourdes si teneva una Messa solenne.
Era celebrata dall'arcivescovo di Lione e con lui concelebravano l’allora arcivescovo di Parigi, cardinale Jean-Marie Lustiger, molti vescovi francesi, molti sacerdoti e tutti i superiori dei monasteri trappisti del mondo. La cerimonia era trasmessa in diretta dalla televisione francese.
I celebrante aveva sull’altare per la Consacrazione due ostie molto più grandi di quelle che usano i sacerdoti italiani, come del resto è consuetudine in Francia. All'inizio della messa, le due ostie appaiono nel filmato appoggiate l’una sull’altra formando un corpo unico, tanto che non ci si accorge neppure che sono due e non una sola. Sono poste sulla patena, una specie di vassoio, e vi aderiscono perfettamente. Nel filmato ci sono diverse inquadrature che le riprendono in quella posizione e non ci sono dubbi che le due ostie siano fisicamente appoggiate l’una sull’altra e aderiscano alla patena. Al momento dell’ “epiclesi”, cioè quando i sacerdoti stendono le mani invocando lo Spirito Santo, si verifica il fenomeno.
Si vede l’ostia superiore che si stacca dalla sottostante e si solleva. Il movimento è impressionante: l' ostia si alza come se sotto di essa fosse scattata una molla e oscilla tre, quattro volte nell' aria prima di prendere una posizione fissa, orizzontale, a circa un centimetro dalla sottostante, e rimane poi in quella posizione fino alla fine del canone.
La ripresa televisiva mette in evidenza vari momenti della cerimonia, durante i quali il celebrante si muove, si sposta, ed è così possibile vedere, attraverso le due ostie, una sollevata nell’aria e l’altra aderente alla patena, il colore dei paramenti indossati dal celebrante. Poichè il filmato con queste immagini è abbastanza lungo e ricco di primi piani, si ha la possibilità di acquisire, con ragionevole certezza, che non si tratta assolutamente di illusione ottica o di inganno di prospettiva. Esperti del settore, dopo attento esame del filmato, hanno escluso nel modo assoluto una manipolazione tecnica delle immagini.
Miracolo? Come già detto, le autorità ecclesiastiche, interpellate varie volte, hanno scelto di non fare commenti ufficiali. Però, chiunque vede quel filmato prova un’emozione indescrivibile perchè assiste con i propri occhi al verificarsi di un qualche cosa che razionalmente non ha spiegazioni.

"La verità non è qualcosa che si possiede, un oggetto di cui si possa disporre. La verità è qualcuno da cui lasciarti possedere. Forse - ecco, diciamo anche - un mistero più grande a cui consegnarti. E allora io non dispongo della verità, io osservo la verità. E servire la verità è, mi sembra, l'atto più onesto che la nostra intelligenza, la nostra ragione possa compiere, perché significa corrispondervi, non dominarla, e significa restare in un atteggiamento di stupore e di umiltà davanti agli altri, davanti alla vita. La verità è l'inquietudine permanente del cuore in ricerca ed è la possibilità del mistero, che accoglie questa inquietudine. In questo senso è per me credente, il Dio vivente, quel Dio che si è rivelato in Cristo, che si è fatto anche lui nella storia pellegrino, anche lui ha consumato delle scarpe."
"Dove il Cristianesimo non rinasce marcisce",scrive Pasolini.
Mi sembra che queste parole di Pasolini siano di una straordinaria forza e forza di verità. Il Cristianesimo, se non è un possesso ideologico della verità, ma è un servire la verità dell'altro che viene a te, ogni giorno ha bisogno di rinnovarsi in questa ricerca della verità. Ecco perché ho parlato del pellegrinaggio della ricerca, le scarpe.
L'ESODO DA SE' SENZA RITORNO
Qualche amico, qualcuno dei pensatori, a volte afferma che senza Dio diventa impossibile fondare un'etica, dunque che la verità sarebbe soltanto possibile se c'è un fondamento ultimo. Ecco io non arrivo a dire questo, perché dire questo significherebbe escludere la possibilità che tanti cercatori del mistero con onestà si aprono agli altri. Io però dico una cosa - e su questo sono veramente convinto - che non si va verso la verità, se non uscendo da se stessi, in un movimento di autotrascendenza. Insomma non c'è verità senza l'incontro con l'altro. Questo incontro con l'altro può aprirti come traccia un più profondo mistero dell'altro, che ti porta anche al mistero di Dio. Cristo, invitandoci a seguirlo soprattutto nella via dell'amore e nel compromettere la nostra vita per gli altri, ci ha fatto capire che la verità tu la trovi soltanto quando vivi questo esodo da te senza ritorno. Allora mi chiedi: come cercare la verità? La mia risposta è questa: con tutta la passione di un'intelligenza che pone domande, anche con tutta la forza di un cuore che accetta di compromettersi realmente per gli altri, soprattutto per i più piccoli e i poveri della storia. Su questa strada cercherai. E io penso che la verità non potrà non venirti incontro.
Agostino, che è stato un grande cercatore della verità scrive ne Le confessioni : " Quando vuoi cercare la verità non uscire fuori, entra in te stesso. Nell'interno, nel profondo dell'uomo troverai". Con questo Agostino non vuol dire che la verità è semplicemente un pezzo del tuo cuore, una dimensione del soggetto. Vuol dire però che noi dimoriamo nel mistero più grande. E allora, scendendo in profondo nel nostro esistere, pensando - perché questo è pensare, è superare l'evidenza, il paradosso dell'evidenza e scendere nel profondo del mistero dell'esistere, bene, lì la verità t'aspetta e t'accoglie come l'altro che parla al cuore del tuo cuore. Dunque non è una soggettivizzazione della verità l'invito a partire dalla coscienza della persona, ma è, direi, l'unico luogo dove l'uomo può incontrare la verità, è anzi tutto la propria coscienza, il proprio pensare, perché è lì che si compiono anche le grandi scelte della sua vita. E questo naturalmente nel rapporto con gli altri, in quell'esodo da sé senza ritorno, di cui prima avevamo detto qualcosa.A questa verità io mi sono arreso, ma questo mi ha reso, non meno, ma ancor più cercatore di essa. Questa è la verità di Dio, coma la fede, mi sembra, la proponga, almeno la fede cristiana, di cui in qualche modo io sono, con tutte le mie inquietudini, un testimone, perché credo che la verità si sia detta in Gesù Cristo e si sia detta sull'albero della croce del risorto.
FONTE: Intervista a Don Bruno Forte


PRESENTATORE: Il credente è pensoso. Pellegrino nella notte della fede, non dovrebbe mai dimenticare che ha a che fare con il Dio vivo. L'oggetto del suo indagare, prima di essere qualcosa, deve essere riconosciuto come qualcuno, che, rivelandosi, non si è soltanto detto, ma si è più altamente taciuto. Rivelandosi Dio si vela, comunicandosi si nasconde. Lottare con questo Dio è, al tempo stesso, la debolezza e la forza del credente, dove Dio inquieta, come l'assalitore notturno dell'esperienza di Giacobbe al guado, lì l'uomo è veramente interrogante e vivo nella sfida. Lungi dall'essere un'ideologia rassicurante, la fede è un continuo convertirsi a Dio, un continuo consegnargli il cuore, cominciando, ogni giorno, in modo nuovo, a vivere la fatica di credere, di sperare, di amare e proprio per questo di esistere per gli altri. Si può allora affermare che il credente non è che un ateo che ogni giorno si sforza di cominciare a credere. E non sarà anche l'ateo un credente che ogni giorno vive la lotta inversa di cominciare a non credere? Non certo l'ateo banale, volgare, ma chi vive la lotta vera con coscienza retta, chi, avendo cercato e non avendo trovato, patisce l'infinito dolore dell'assenza di Dio, non sarà l'altra parte di chi crede? E se c'è una differenza da marcare, non sarà dunque quella tra credenti e non credenti, ma l'altra, tra pensanti e non pensanti, tra uomini e donne che hanno il coraggio di vivere la sofferenza del pensiero, di continuare a cercare per credere, sperare ed amare e uomini e donne che hanno rinunciato alla lotta, che sembrano essersi accontentate dell'orizzonte penultimo e non sanno più accendersi di desiderio e di nostalgia, al pensiero dell'ultimo orizzonte e dell'ultima patria. Qualunque atto, anche il più costoso, è degno di essere vissuto per riaccendere in noi il desiderio della verità e il coraggio di tendere ad essa fino alla fine, oltre la fine.
Forte: Sì, sono pienamente d'accordo che il credente è un ateo, che ogni giorno si sforza di cominciare a credere. Se così non fosse, la fede sarebbe qualcosa di scontato, un riposo tranquillo, una morta ideologia. Ma sono anche convinto che l'ateo - non il volgare ateo, che in maniera disimpegnata e con nonchalance dice di non credere in Dio -, ma l'ateo che vive la passione della lotta, l'ateo che pensa fino in fondo il dramma della fede, è in qualche modo un credente, che si sforza di cominciare a non credere. Perciò credo che, credenti e non credenti, pensosi, siano infinitamente più vicini di quanto si possa normalmente ritenere. L'uno è parte viva dell'altro. Ecco perché ciò di cui parliamo oggi, ci tocca tutti, ci riguarda tutti. Si tratta di mettere in discussione noi stessi nel più profondo del nostro cuore, delle nostre inquietudini, delle domande che, almeno una volta nella vita, necessariamente ognuno si pone. Sono queste le domande su cui si gioca il dialogo fra cristianesimo e ateismo, più in generale fra fede e non fede, fra "credere"- secondo una curiosa etimologia latina "credere" significa "cordare", dunque compromettersi totalmente per l'altro misterioso e assoluto - e non fede, non credere, resistere in questa lotta dove, se la resistenza è frutto di una intelligenza viva e appassionata, credo che abbia tutto una enorme dignità. Ecco sono i temi su cui oggi ci incontriamo e ci incontriamo a partire dalle vostre domande, non certo dalle mie risposte. Cominciamo.

STUDENTESSA Io volevo farLe una domanda.
Come ti chiami?
STUDENTESSA: Marta. Qual è la differenza tra ateo e agnostico?
Ma di per sé l'agnostico è colui che ritiene di non poter conoscere, quindi di non poter nulla dire sull'ultimo mistero, sull'ultimo silenzio. Di per sé l'ateismo implica una negazione più radicale. Ecco perché io credo che l'ateismo, nel senso rigoroso del termine, non possa esistere, perché l'ateismo implica una presunzione di totalità, che solo i mondi delle ideologie, i grandi racconti delle ideologie potevano sognare di avere. Oggi in un'epoca di pensiero debole, di ragione ferita, di "crisi delle ideologie", come si dice, io credo che nessuno, seriamente pensante, oserebbe fare l'affermazione così totale e universale, che Dio non c'è. Dunque credo che oggi la passione, la fatica sia piuttosto quella dell'agnosticismo, cioè della fatica di conoscerlo, della fatica di aprirsi alla sfida del mistero. Ma anche il credente in qualche modo è un agnostico, nel senso che anche nel credente c'è un dimensione profonda di oscurità e di mistero. Guai se il credente pensasse di avere tutto chiaro e di avere la risposta pronta per tutto. E allora ancora una volta le carte si rimescolano, le nostre sicurezze si smobilitano, i bastioni cadono. Siamo tutti nella stessa barca, siamo tutti in ricerca, avventurieri del pensiero, ma al tempo stesso navigatori verso un mistero che ci sorpasssa. Un grande storico, Hans Blumenberg, definisce questa condizione nostra, di donne e uomini del post-moderno, come si dice, "naufragio con spettatore". Sì tutti abbiamo fatto naufragio rispetto ai grandi racconti delle ideologie, tutti siamo più poveri, tutti siamo in ricerca. In tutti noi c'è una dimensione di agnosticismo, ma, grazie a Dio, tutti oggi possiamo con libertà dire che di ateismo non se ne parla neanche, se si intende con ciò la banale negazione di Dio. Non so se ti ho in qualche modo risposto, ma è quello che la tua domanda, Marta, suscitava in me, come immediata reazione. Vediamo, c'è qualche altro?

STUDENTESSA: Buongiorno.
Ciao, tu sei?
STUDENTESSA: Mi chiamo Flavia e volevo chiederLe
come si spiega il fenomeno dei credenti non praticanti e dei credenti praticanti, ma passivi?
Ma io credo che, quando si ha a che fare col mistero, tutti quanti noi abbiamo una reazione abbastanza istintiva di difesa. Le cose che si vedono, le cose che si toccano sono sempre più rassicuranti. Vi siete mai chiesti, ragazzi, perché le ideologie hanno fatta tanta presa, per esempio, sulle donne e gli uomini del nostro secolo, il cosiddetto "secolo breve"? Perché le ideologie rendono un gran servizio agli uomini. Non li fanno pensare. C'è un altro che pensa per te, il capo, comunque questo capo si chiami. Il nostro secolo viene chiamato ormai il "secolo breve" per questo motivo, perché si è svolto, fra il 1914, lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, e il 1989, con una enorme rapidità, ma questa rapidità era dovuta esattamente al fatto che il secolo XX° è stato il secolo del grande trionfo dei miti ideologici, ma anche della loro crisi, di tutti i miti ideologici, di destra e di sinistra, qui non facciamo questione di una ideologia. Ora anche il credente spesso tende a rassicurarsi in una ideologia. Allora l'ideologia ti fa comodo, ti tranquillizza, ti fa vivere la cosiddetta appartenenza parziale, cioè io accetto della fede, tutto sommato, ciò che mi sta bene, ciò che non mi compromette veramente. Io credo invece che, quando si ha a che fare con Dio, si ha a che fare col fuoco. Dio ti prende tutto, ti brucia tutto, se no non lo hai veramente incontrato. Allora quello che tu dicevi, riguardo ai credenti, diciamo, a mezzo impegno, credo che sia veramente il segno di una resistenza ideologica, che tutti ci portiamo dentro. Io credo che come nell'amore, così nella fede, la totalità, la radicalità della passione sia l'unica degna di essere vissuta in una enorme paura, non di chi rifiuta Dio, ma di chi, nella indifferenza e nella mediocrità del non pensare, credente o non credente che sia, non lo cerca con tutta la passione della sua vita.

STUDENTE: Mi chiamo Davide. Volevo porre una domanda anche in base alla scheda che abbiamo appena visto:
dunque l'ateismo può essere considerato come una fede rovesciata?
Ma guarda, in un certo senso sì, lì dove è vissuta con grande serietà e passione. Cioè chi si dice "non credente" e lo fa, non per una ragione di comodo, ma per la fatica di riconoscere il mistero più grande, di un Dio che si rivela nella storia, fa anche lui, anche lei un grande atto di fede, la fede, come dire, nell'orizzonte penultimo. E io mi sento di rispettare questo atto di fede enormemente, anche perché chi veramente è pensante, non può vivere la condizione di non credenza come una condizione tranquilla. In altre parole: chi non crede sente l'infinito dolore dell'assenza, se la sua non credenza non è un comodo bagaglio ideologico. Per esempio, che ne è del senso della vita, che ne della morte, che ne è delle ultime cose? Io credo che queste son domande che dobbiamo riprendere tutti e non importa il fatto che queste domande sono una sorta di "pudendum", di qualcosa di cui quasi ci si vergogna. Soprattutto quando si parla coi giovani, non si vuol parlare di questi grandi temi, come la morte, il senso della vita. C'è una sorta di indifferenza, che è quasi una sorta di parlare in maniera political corrected, come oggi si dice, quella correttezza del parlare. No, noi dobbiamo trasgredire queste forme. E io credo che il non credente, a suo modo credente, è colui che accetta questa trasgressione.

STUDENTE: Scusi professore, ma di chi ha cercato e non ha trovato?
C'è una frase drammatica nella Bibbia, che si ripete nell'Antico e nel Nuovo Patto. Vedete là c'è il Libro delle Scritture - in ebraico e in greco, che sono i testi originali -, ebbene tanto nell'Antico che nel Nuovo Testamento, c'è una frase che dice: "Ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù". E' una frase sconcertante. Perché? Perché da una parte Giacobbe e Esaù sono come noi, uomini in ricerca. Ogni uomo è in ricerca. Qua c'è un altro segno che vorrei mostrarvi. C'è un quaderno - non so se tutti potete vederlo - con una penna. Che cosa significa il quaderno con la penna? A me sembra che possa significare questo: il gesto col quale l'uomo esce da sé, si oggettivizza in una scrittura. Ecco l'atto della scrittura è un atto di trasgressione del tuo mondo assoluto. Tu ti esili da te, ti oggettivizzi e diventi fruibile per tanti. Questo è segno - l'atto semplice dello scrivere -, è segno del fatto che noi siamo tutti dei pellegrini in ricerca. Ora perché ad alcuni quei libri parlano come rivelazione di Dio e ad altri no? Certo ci possono essere delle ragioni di nostra resistenza, di nostro non ascolto, ci possiamo stordire anche nella superficialità, però è vero - sarebbe disonesto dire che non è così -, che ci sono persone disposte radicalmente a lasciarsi mettere in questione, ma che dicono: io non sono stato raggiunto, toccato dalla grazia. Che dire? Questo è un grande mistero anche per me credente. E' una domanda che, tante volte, io, credente pensante, pongo al mio Dio. E come vedi, pur essendo credente e teologo, per giunta, io non sono l'uomo che ha le risposte pronte su tutto. Ecco io rispetto il mistero di questo enigma, come lo ha rispettato Paolo nella Lettera ai Romani. In altre parole io penso che, pur amando Dio tutti e ciascuno, ha tempi e momenti diversi. Allora ciò che conta è non essere pigri nella ricerca e non mascherarsi dietro presunte, false sicurezze, essere dei pellegrini della vita del pensiero, che cercano. Poi, per alcuni verrà prima, per altri dopo, per altri misteriosamente, non sappiamo quando, questo incontro che ti cambia il cuore e la vita. Questa è la grazia, che io riconosco di averla ricevuta, ma nello stesso tempo capisco il dramma di chi dice: "Ma io non sono stato toccato". E allora l'unica cosa che posso chiedergli: "Sei un cercatore vero, uno che non si maschera? Se sei tale, credo che questo, davanti a Dio, sia la dignità più alta". Lo dico in una battuta: io credo che, quando andremo davanti a lui, lui il Dio vivente in cui io credo, non ci chiederà conto di averlo trovato, ci chiederà conto di averlo cercato. Poi, per molti, spero per tutti, ci sia anche la gioia di averlo trovato.

STUDENTESSA: Sono Veronica. Le volevo chiedere:
ma chi allora può essere considerato il vero credente e quale cammino deve fare per essere considerato tale, cioè credente?
Mi hai posto una domanda, coerente col tuo nome. Veronica è la "vera icona". Tu cerchi la "vera icona", la "vera immagine" del lottatore con Dio. Bene, io credo che il credente è esattamente Giacobbe, che lotta nella notte. Il credente non è chi vive della fede come di un possesso scontato. La verità della fede non è qualcosa che si possiede, ma qualcuno che ci possiede. Pensa che in ebraico, la lingua dell'Antico Testamento - perciò ho voluto portare i testi originali - "verità", come parola, in un certo senso non esiste. "Verità" si dice "emet", che significa "fedeltà". Cioè la verità per l'ebreo, per il mondo della Bibbia non è un oggetto che si vede, come in greco, aletheia, tolgo il velo e vedo, posseggo. Verità è un patto, un rapporto. Dunque il vero credente, la vera icona del credente è quella di chi è in continuo rapporto dialettico di lotta, d'amore, di resa, d'abbandono, di conquista con il suo Dio, non certamente di chi riposa sugli allori di certezze comode e scontate. Io vorrei, è questa la passione che ho nel cuore, non tanto dare a voi delle risposte, quanto accendere in me e in voi delle domande che ci facciano cercatori del Volto, cercatori di quell'icona vera, del lottatore con Dio, dove - questo sì l'aggiungo da credente -, alla fine l'importante non è che vinca tu, ma che vinca l'altro. Vince chi perde, cioè vince chi si arrende al mistero più grande. Ecco questo mi sembra il vero credente, e in questo senso il non credente pensante è vicino a lui, come prima Davide con la sua domanda in qualche modo ci faceva pensare.

STUDENTESSA: Padre, scusi, io sono Stefania. A questo punto però io continuo a chiedermi se anche l'ateismo, come abbiamo detto, è una credenza, una credenza rovesciata, ecco. Allora come definire l'ateo proprio?
Ma guarda, tutto sta a capire quell’alfa privativa, che è davanti alla parola Dio. Se per ateo si intende colui che presuntuosamente nega Dio, dice: "Dio non c'è", - beh, la Bibbia ne ha dato la definizione - "è solo lo stolto che dice così". In altre parole è un'affermazione di troppo grande presunzione questa, per dire: "Io conosco talmente il tutto da poter dire che in questo tutto non c'è spazio per l'alterità assoluta, la trascendenza assoluta". Chi di noi, in un'epoca di ragione critica, può fare un'affermazione del genere? Allora l'idea di ateo, che dobbiamo assumere e che mi sembra anche la più rispettosa per la dignità del cosiddetto ateo, è l'idea di uno che non è che neghi Dio con sua presunzione, ma che sperimenta dolorosamente perfino l'assenza di Dio. Cioè è il senza Dio non perché lui l'ha negato, ma perché lui non si sente raggiunto, toccato, amato da quest'esperienza dell'altro, che gli cambia il cuore e la vita. Paradossalmente l'ateo è colui che soffre l'assenza di Dio più del credente e se non è così, la sua è un'ideologia volgare, a buon mercato, che non dice nulla alla vita. Ecco io ho paura non dell'ateo vero, dell'ateo che soffre l'assenza di Dio. Io ho paura dell'indifferente e,devo dirlo però, indifferente può essere anche un credente non pensante, che dorme sugli allori di una fede scontata, di una fede ideologica. Io credo che la grande provocazione è di essere tutti pensanti. La frase che sentivamo nel filmato, mi sembra che sia in origine di Bobbio, il quale dice che la grande differenza forse, oggi, non è fra credenti e non credenti, ma fra pensanti e non pensanti. Che cosa vuol dire lui? Non che non ci sia una differenza nel credere o non credere, ma che all'interno del credere o non credere ci sono due possibili radicali atteggiamenti, cioè quello di chi pensa, di chi pone domande vere e vive la sofferenza della ricerca e c'è quello di chi non pensa più. Ecco io credo che dobbiamo incontrarci nel pensare. Io penserò la mia fede, penserò il mio Dio, quel Dio che mi ha rapito il cuore e la vita e che nella sua parola si è pronunciato. Ecco, la mia ricerca, il quaderno, si è incontrato con la sua parola. E allora il vero problema diventa, la vera grande domanda: ma dove questo incontro si compie?

STUDENTESSA: Ma allora il non pensante, quello che non pensa più, non pensa per motivi, ad esempio, per dolori che gli sono capitati? Allora come può ritornare al pensare?
Ma Veronica, la tua domanda è molto bella, perché, in realtà, mi spiazza su un piano decisivo. Cioè tu mi dici: "Ma non ti sembra che quello che stai dicendo è un po' troppo teorico? Cioè non ti sembra che tanta gente non pensa non perché non voglia pensare, ma perché pensare fa soffrire?". E' vero. Lo dicevo prima. La grande comodità delle ideologie è che ti tolgono la fatica del pensare, ti fa essere come un cane che sta al guinzaglio del suo padrone. Ma la fede non può essere così. La fede non può essere l'ideologia di un cane al guinzaglio. La fede deve essere ricerca e anche la fede di chi non crede, io credo, debba essere ricerca. Per cui ancora una volta è questa forte provocazione alla ricerca del volto, alla ricerca dell'incontro. Io ho voluto altri due segni, vedete qui: uno è molto noto, è l'immagine di Madre Teresa, e l'altro è un segno che nella tradizione cristiana è pieno di significato simbolico: un pane spezzato e un calice di vino. Sapete che è il simbolo, nella tradizione biblica, ebraica della vita condivisa. Il pane spezzato e mangiato insieme è la vita condivisa, il calice è il simbolo del destino sofferente, quindi chi beve allo stesso calice soffre insieme. Sapete che il Gesù di Nazareth, il profeta galileo, il figlio di Dio, nel quale io credo come cristiano, ha scelto questi due segni per il gesto supremo del suo amore, l'Eucarestia. Il pane spezzato e il calice del vino sono diventati nell'Eucarestia il simbolo reale, efficace di una sua condivisione con noi. Cioè noi condividiamo la vita e il dolore col nostro Dio. Ecco allora due grandi simboli. Dove si incontra il Dio vivente con l'uomo vivente? Nella carità, cioè nel destinare la propria vita all'altro, nel vivere questo esodo da sé senza ritorno, che è l'amore, e in quel pane e in quel vino in cui Dio si compromette per noi. In America Latina mi hanno insegnato un proverbio meraviglioso, che dice: "Colui che ama si sporca le mani fino in fondo". Bene, questo pane spezzato, questo vino simbolo della condivisione, della compromissione di Dio nel pane e nel vino dell'Eucarestia, ci dicono chi è il nostro Dio. Ecco è il luogo dell'incontro, il vero, la vera sfida, il vero inquietante problema di chi sta cercando il volto dell'altro.

STUDENTESSA: Professore l'ateo può diventare credente. Ma è possibile che si verifichi il passaggio inverso, cioè che il credente diventi ateo?
Certamente. Nessuno è garantito in maniera scontata nella sua fede. Ma cerchiamo di capire i due passaggi. Quand'è che l'ateo diventa credente? Quando, nella sua lotta con Dio, quella definizione alta dell'ateo come chi "lotta con Dio", accetta di arrendersi all'amore dell'altro, più violento del fuoco della morte. E' quanto avviene nella scena di Giacobbe. Deunamuno diceva: "La mia religione è lottare con Dio", dall'aurora fino al cadere delle stelle, fino al cadere della notte. Dunque l'ateo che accetta questa capitolazione allora diventa credente. E quand'è che il credente diventa ateo? Quando trasforma la sua fede in una comoda ideologia, con la cui comincia a giudicare gli altri, quando non vive più la passione e l'inquietudine sofferta, appassionata di una ricerca, di una lotta con Dio, che diventa esodo da sé, uscita da sé nell'amore per gli altri, quando non si sporca più le mani per compromettere la sua vita, destinandosi a Dio, destinandosi al prossimo. E' allora che, anche se non lo dicesse con le parole, con i fatti, con il cuore egli diventa un ateo volgare, un lontano da Dio. Bene, io credo che il dramma si può sempre giocare. Ecco perché, credenti e non credenti, siamo sempre sulla soglia. Ma questo rende la nostra vita bella; degna di essere vissuta. Ci rende appassionati, ci rende, vorrei dire, giovani dentro. Si può esser giovani a ottant'anni e vecchi a diciotto. Dipende dalla passione con cui tu cerchi il senso e il volto dell'altro nella tua vita.

STUDENTESSA: Ma l'istituzione ecclesiastica, la Chiesa, aiuta realmente i credenti nel cammino verso Dio, verso la verità insomma?
Ma dipende, nel senso che certamente per incontrare Dio non si può essere soli, perché Dio ti proietta fuori di te. Dunque importante è che ci siano gli altri. Ma naturalmente questi altri possono essere, al tempo stesso, quelli che ti testimoniano lui o quelli che in qualche modo te lo nascondo. Certo, in ogni caso, nella comunità dei credenti si ha la parola di Dio, si hanno quegli eventi della carità e dell'incontro con lui, che aiutano a cercarlo. In questo senso io credo di averne profondamente bisogno. Ma ecco è un'esperienza da fare vivendola, in qualche modo scoprendo, al di là anche dell'apparenza esterna, che qualche volta può essere anche un po' imponente, la semplicità di un rapporto umano e fraterno, fra quelli che credono. No?
STUDENTESSA: Mi scusi padre, secondo Lei la fede non è un aggrapparsi a un vincolo, tramite il quale è possibile darsi delle risposte, che poi con la ragione non è possibile arrivarci, quindi un cullarsi su questo?
Ma può essere anche questo, qualche volta la fede può essere alienazione. Ma normalmente è così quando tu pensi di avere risposte solari, luminose, dove tutto sia scontato. C'è, mi sembra, un filmato che è stato preparato, di un uomo, di cui ero profondamente amico, Sergio Quinzio, che mi sembra che ci testimoni esattamente l'opposto di questo, cioè che la fede non è appunto un riposo scontato e tranquillo, ma l'incontro con Dio è sempre un incontro con un mistero che ti inquieta, che ti provoca. Proviamo ad ascoltarlo, poi caso mai lo commentiamo, se è possibile.
-Si visiona il filmato:
QUINZIO: Io continuo a dire che è continuamente prevalente nell'orizzonte ebraico cristiano quest'idea del Dio, che come appunto, è stato scritto di Dio non si parla. Non c'è, non c'è discorso tematico su Dio, perché, o Dio parla e ci rivela la sua volontà e ci dà i suoi ordini, oppure a Dio si parla per pregarlo, per chiedergli qualcosa, per adorarlo. Al di fuori di questo non c'è, non c'è nessuna possibilità. Ora questo, insomma diciamo è un ruolo che ci apre sempre nei libri sapienzali dell'Antico Testamento. Anche nei libri sapienziali si accoglie questa sapienza naturale. C'è il Libro dei Proverbi: comportati, sta attento a non dispiacere il potente, perché il potente ti potrà minacciare, guardati dalla pigrizia. Cioè c'è tutta un'area in cui vengono assunte delle esperienze comunemente umane, tra le quali entrano appunto anche queste, per esempio di dire: "Ma vi rendete pur conto che c'è un universo". Le cose ci sono, ci sarà un creatore, ci sarà un'origine, però non direi che questo viene mai imposto al centro, perché poi nell'orizzonte biblico prevale enormemente la parola di Dio, anche quando contraddice totalmente tutte le regole che si possono dedurre da un ordine naturale, diciamo così. Allora, perché in effetti, quando, quando Dio ordina ad Abramo di uccidere il figlio, evidentemente va totalmente in una direzione opposta, ma insomma totalmente opposta a quella che è la leggenda, tra virgolette, "naturale", e va quando gli promette un figlio dal grembo sterile di Sara, essendo lui centenario, eccetera. Cioè in definitiva prevale sempre l'aspetto paradossale.
Questi aspetti coesistono, cioè un aspetto in cui certi valori naturali sono riconoscibili e possono avvicinarci a Dio, però è anche vero che Dio, quando parla, trascende di gran lunga, spezza questa logica naturale, questa logica mondana, per darci una verità che sta al di là di quella. E mi pare questo molto più decisivo di quell'altro.
-Fine del filmato.
Forte: Quello che è molto bello in Sergio Quinzio, come avete ascoltato, ed è stato il leit motif di tutta la sua vita è che lui non è un credente che riposa nello scontato - dunque la fede quasi come rassicurazione o alienazione -, ma che vive anzi il tormento, la passione dell'incontro con Dio. Ecco questa è la risposta forse più evidente, più forte alla tua domanda. Una fede che sia rassicurazione è una maschera; la fede è comunque e sempre inquietudine e passione, com'è l'amore, com'è l'amore.

STUDENTE: Scusi professore, mi chiamo Luigi. Vorrei sapere: non pensa che il contesto sociale, soprattutto con la presenza del papato, finisca per condizionare l'espressione del non credente?
Cioè non pensa che il non credente si senta come un peccatore e venga considerato tale?
Ma dunque, che venga considerato tale io penso proprio di no, perché, se no, insomma, non ci sarebbe anche tanta e diffusa professione di agnosticismo, di dubbio, di insicurezza. Anzi, in qualche modo mi sembra che, in certi momenti, oggi è più difficile dirsi credenti e testimoniare una fede convinta che non il contrario. Convengo che i condizionamenti culturali e storici nel nostro paese certamente ci sono, direi, come in ogni cultura e in ogni contesto. Naturalmente questo non è un vantaggio per il cristianesimo. Cioè il cristianesimo ha bisogno di grande libertà e qualche volta il fatto di essere un paese tradizionalmente cattolico, potrebbe dar per scontato in qualche coscienza debole l'appartenenza cristiana. Ecco mi sembra che però l'inquietudine su questo punto deve essere certa, deve essere chiara, una fede comoda scontata, di appartenenza tranquilla. Non è la fede del Dio biblico, non è la libertà a cui Gesù ci ha chiamato.

STUDENTE: Professore, scusi, volevo spostare l'ambito della discussione su un altro tema. Volevo, chiederLe: ma un cristiano come deve porsi rispetto ad altre religioni? Deve cercare di convertire, accettare?
Ma, Davide, io sono convinto che chi crede sul serio nel Dio vivente sa che Dio è comunque più grande di tutte le rappresentazioni che noi possiamo farci di lui. E allora nel credente si combinano due atteggiamenti fondamentali - almeno mi sembra -: da una parte quello di una profonda fede nel suo Dio, nel Dio vivo, che per un lato è in Cristo nel credente cristiano, per cui lui sarà il testimone e l'annunciatore di questo Dio, però anche il profondo rispetto dell'altro, nella convinzione che ci sono vie misteriose e spesso attraverso queste vie Dio raggiunge il cuore dell'uomo. Dunque vorrei dire: al tempo stesso testimonianza, ma anche dialogo, rispetto. E coniugare questi due atteggiamenti non è facile. Un credente che lo voglia fare - e lo voglia fare sul serio - spesso vive delle tensioni e delle lacerazioni che sono molto grandi e che sono sempre più frequenti in un contesto multietnico e multiculturale, come il nostro. Ma bisogna vivere questa strada piuttosto che quella comoda di chiudersi nella sicurezza oppure di aprirsi ad un relativismo, direi perfino ingenuo.
STUDENTE: Quindi Dio ha parlato a tutti praticamente.
Ma io credo che Dio cerca le strade del cuore di tutti, del cuore di tutti. Come credente cristiano penso che abbia parlato a noi, in modo molto forte e pieno, in Gesù di Nazareth, Signore e Cristo. Ma proprio questa convinzione di un Dio che è amore, quale è quello che Dio mi ha rivelato in Gesù, mi fa pensare che anche altri, che tutti anzi, sono in qualche modo amati da lui e raggiunti per vie misteriose, anche se, anche se, ecco, cercare di capire queste vie, di rispettarle, è una fatica sempre aperta. Non lo nascondo.

STUDENTESSA: Senta, padre, ma che cosa dovremmo pensare di Dio, cioè come un qualcosa di giusto, di buono, oppure come un'entità crudele, come, per esempio, è stato interpretato precedentemente da persone che, comunque, in nome di Dio, uccidevano gli eretici.
Quindi che cos'è Dio, un’interpretazione? cioè come un uomo vede Dio allora quello è?
Già il fatto che tu sia aperta alle possibilità, diverse dalla risposta, dà una risposta. Cioè è chiaro che c'è un' interpretazione, cioè è chiaro che ognuno di noi sia prossimo al mistero di Dio con delle sue domande, che in qualche modo orientano la sua ricerca. L'importante allora è anche cercare dei riferimenti oggettivi, che vanno al di là della ricerca soggettiva. Per il credente cristiano questi riferimenti sono la rivelazione di Dio, cioè appunto quella parola dell'Antico, del Nuovo Patto, dove Dio si rivolge agli uomini, fino alla piena comunicazione, nell'amore del Cristo, nella sua croce. Ecco, io credo che noi dobbiamo misurarci, per sapere chi è Dio, non sui nostri desideri o sulle nostre proiezioni, ma forse proprio su quei parametri oggettivi che molte volte ci turbano, ci inquietano, ma proprio per questo sono salutari. Dobbiamo metterci in ascolto dell'altro, non voler catturare l'altro. Perciò, vedi, il cristianesimo è una fede che rende pensanti, che non ti addormenta, perché Dio ha parlato in modo tale da provocarti continuamente a trasgredire, a violare la sua parola, per entrare in essa e oltre essa, verso l'abisso.

STUDENTESSA: Mi scusi, padre, ma allora un buon cristiano deve tener conto della fede o della ragione o in tutte e due le cose insieme?
Se fede e ragione vengono intese come due mondi totali non sono conciliabili. Ma se la fede è indagante e la fede è una domanda aperta e non la presunzione di capire tutto, non c'è nulla di più razionale che la fede, non c'è nulla di più credente che la ragione. Vorrei dire si abitano l'una nell'altra. E in questo senso non si fanno concorrenza. "Credo ut intelligam et intelligo ut credam". "Credo per pensare e penso per credere". Ed è questo che rende possibile il dialogo fra tutti coloro che, credenti o non credenti, sono però pensanti, come stiamo facendo noi in questo momento. No?
STUDENTESSA: Volevo domandarLe, ma che differenza c'è tra un Dio della religione, per esempio cattolica e un Dio della religione buddista. Cioè, non pensa che magari un buddista chiama il proprio Dio Buddha e invece noi lo chiamiamo Dio? Però poi è unico? Ciò che fa il nostro Dio, in effetti lo fa anche Buddha, soltanto che viene semplicemente chiamato in altri modi.
Quello che tu dici ha una parte di verità, certamente, perché ognuno di noi proietta nella sua esperienza di fede, in qualche modo, l'immagine che ha di Dio. Però se fosse solo questo, se fosse solo questo, credere sarebbe semplicemente il prodotto di una azione umana, di un orizzonte umano di senso. Io credo invece che credere è realmente il frutto di un incontro fra questa ricerca dell'uomo, di cui è metafora e simbolo il quaderno e la penna, questa parola di Dio di cui è simbolo e metafora la parola rivelata nella fede ebraico-cristiana, che devono però intrecciarsi, incontrarsi. E ancora una volta il problema grande è se ci sono dei luoghi oggettivi di questo incontro e in che misura anche le varie religioni storiche realizzano questi luoghi. Per esempio la carità. C'è differenza o no nel vivere la testimonianza dell'amore fra i modelli delle grandi religioni storiche? Per esempio, questa forte compromissione di Dio, che nel cristianesimo ci viene indicata addirittura nei segni dei sacramenti. Il pane e il vino sono consacrati nell'Eucarestia, sono la compromissione di Dio con la carne, la storia del mondo. Insomma ci sono dei riferimenti oggettivi su cui è possibile stabilire un confronto e un dialogo; non per reciprocamente negarsi, ma per riconoscersi nella verità reciproca e nella verità che ci trascende tutti. Dunque non un tutto va bene, ma un cercare con passione la verità che ci trascende e che in qualche modo viene verso di noi. Mi sembra che questa sia la fatica a cui tutti siamo chiamati. E non è facile.

STUDENTE: Professore il quesito che da sempre mi attanaglia, che molte persone mi hanno chiesto, ma io non ho saputo dare risposta: "Ma il Dio cristiano è un Dio punitore?"
Tu che immagine hai di lui?
STUDENTE: Io credo che sia un Dio donatore, perché dona; cioè da come un uomo si comporta nella vita, gli spetta qualcosa, diciamo, nel Regno dei Cieli. Ecco Dio gli dona ciò che gli spetta.
Ma guarda un Dio contabile non mi piace molto, a dire la verità, preferisco perfino un Dio giudice al Dio contabile. Cioè al Dio che ti sta quasi a misurare il bene e il male che hai fatto, per ricompensarti in rapporto a questo, io preferisco il Dio che ti scruta fino in fondo e che ti dice veramente tu chi sei. In altre parole anche qui è faticoso, ma credo che sia necessario, richiamare l'immagine di un Dio scomodo, cioè di un Dio che non si adatta a quelle che potrebbero essere le nostre, le nostre attese, ma che le sconvolge, le sovverte. Non lo so, ecco, un Dio che ci rende tutti inquieti.

STUDENTE: Professore io Le volevo fare una domanda che poi riguarda un altro ambito, insomma: quali sono i limiti del Cristianesimo, secondo Lei, nella civiltà odierna? Ad esempio il confronto che c'è tra scienza e religione rivelata, Lei come lo vede?
Ma anzi tutto la domanda sui limiti del Cristianesimo, direi soprattutto i limiti che i Cristiani hanno espresso nella storia, sono tanti. Mi sembra anzi importantissimo per chi crede non negarli, riconoscerli, perché chi crede si senta in qualche modo solidale con un popolo che è in cammino nel tempo. E quindi i limiti e le colpe dei padri sono un po' anche le sue. Quindi la prima cosa è riconoscere che il fatto di credere non ti esime dalla colpa del limite. Tutt'altro, molte volte te ne fa avere anzi una maggiore coscienza. Per quello che riguarda invece il dialogo con la scienza, ma io credo che una scienza che presuma di rispondere a tutto sia una falsa scienza. E questo modello scientifico, per molto tempo, si è imposto alla cultura dell'Occidente. Il positivismo per dirla in termini molto, molto correnti. Ecco, io credo che una scienza che sia tale ha anche il senso del suo limite, i limiti della propria potenza, della propria capacità, quei limiti che la tecnica continuamente ci fa sperimentare o che, per esempio, la crisi ecologica ha messo in luce in maniera molto evidente. E allora vedi la tua domanda ci porta su grandi orizzonti: gli orizzonti della sfida della tecnica, gli orizzonti della sfida di questa società che abbiamo costruito partendo da una ragione strumentale, sicura di sé. Noi vogliamo tutti una società più umana, ma questa società più umana non si costruisce sulla base delle nostre pretese, delle nostre presunzioni ideologiche, si costruisce se tutti, credenti e non credenti, riusciamo a essere forse più umili, più modesti, più in ascolto dell'altro. E in questo senso la Bibbia, questo Parola dove l'altro ci ha raggiunto, ci ha parlato può essere per tutti un segnale forte, credenti e non credenti, a riconoscere che noi non siamo tutto, che tutti abbiamo bisogno degli altri, che tutti abbiamo bisogno del mistero più grande e quindi a costruire una società più rispettosa del diverso e dell'altro. Voi siete studenti di una delle nostre scuole. Ecco io profitto qui per fare una denuncia ben precisa: ritengo scandaloso che i nostri studenti possano conoscere tutto, o quasi tutto, dei classici greci o anche dei grandi testi della nostra letteratura, il che naturalmente va fatto, ma non conoscere, per esempio, uscire da liceo senza conoscere quasi nulla del mondo della Bibbia, che è alla base della nostra storia, della nostra identità, della nostra cultura. E questo non per una sorta di perversità ideologica, ma per un'apertura a questa radice inquietante e sempre viva che è e resta la tradizione biblica nella storia dell'Occidente e non solo dell'Occidente.

STUDENTESSA: Professore, ma secondo Lei, perché coloro che credono in Dio sono molto meno osservanti di un musulmano ad esempio? Cioè la religione cristiana, anzi i cristiani non osservano tutte le regole, che magari dovrebbero osservare.
Ma probabilmente perché il cristianesimo sottolinea molto la necessità della convinzione interiore da cui le scelte devono partire. Gesù è stato molto duro contro il formalismo, l'apparenza esteriore. Allora qualche volta nel cristianesimo si è talmente accentuata l'importanza dell'interiorità da trascurare persino dei segni dell'esteriorità. Io credo che l'importante sia capire che ogni segno esteriore ha valore in quanto esprima una scelta profonda del cuore e come tale chi ama veramente non può non porre dei segni e dei gesti, chi crede veramente ha bisogno anche di questi segni e di questi gesti. Per cui si tratta di ripensare in radice il tuo modo di credere e di essere impegnato o impegnata per l'altro, per l'io e per gli altri. Ecco mi sembra che i segni della carità, i segni della compromissione, i segni della fede, sono il linguaggio attraverso cui il credente può raccontare nella storia che il Dio che lui ha incontrato non è una evasione o una fuga, ma è il Dio che gli ha cambiato la vita, gli ha dato senso, gli ha dato un qualcosa, un messaggio, un dono, che lui sente il bisogno di trasmettere agli altri.."
La Santa Croce

"Non temere, Io ti farò soffrire, ma te ne darò anche la forza - mi va ripetendo Gesù - desidero che l'anima tua con quotidiano ed occulto martirio, sia purificata e provata; non ti spaventare se Io permetto al demonio di tormentarti, al mondo di disgustarti, alle persone a te più care di affliggerti, perché niente prevarrà contro coloro che gemono sotto la croce per Amore Mio, e che Io mi sono adoperato per proteggerli.
Quante volte - mi ha detto Gesù poc'anzi - mi avresti abbandonato, figlio Mio, se non ti avessi crocifisso. Sotto la croce si impara ad amare, ed Io non la do a tutti, ma solo a quelle anime che mi sono più care".
Gesù a Padre Pio da Pietrelcina - 13 febbraio 1913
"Chi dice la gente che io sia?"
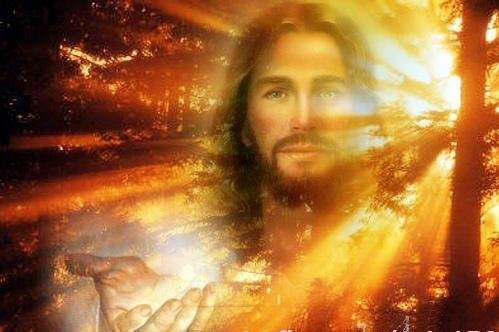
Una domanda.
Una domanda. Quando qualcuno pone una domanda a qualcun altro, indubbiamente, necessariamente, quel qualcuno ha bisogno di una risposta. Un uomo che domanda, normalmente, domanda perché non conosce. Ma quando a domandare è Dio? Dio che domanda ad un uomo... Dio che pone una domanda ed aspetta una risposta... un Dio che conosce alla perfezione la risposta, prima che venga espressa verbalmente, che la conosce nel momento stesso in cui la si pensa. La risposta.
Immagino la scena: Gesù, ci ricorda l'evangelista Marco, "Poi partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo". Interessante. Non tanto la direzione ed il luogo quanto quel "Poi..." con il quale inizia la frase. Vi è sempre un poi con Gesù perché vi è sempre un prima. Gesù è un avvenimento dinamico, non statico. La Sua vita pubblica è stata sempre un'azione, un agire continuo, un'attività quasi frenetica. La Parola doveva farsi conoscere, il Verbo doveva parlare. Quella era la principale priorità. Dall'inizio della Storia, Dio aveva parlato, facendosi presente in maniera particolare, a pochi eletti, a parte le parole dettate alle coscienze di tutti gli uomini in tutti i tempi; ora, in quel tempo della Sua venuta, Dio doveva parlare a tutti. Era giunto il tempo del Verbo.
All'inizio della Storia, Dio si lasciava intravedere; ora, in quel tempo, si lasciava indagare e scrutare.
"Poi...". Gesù non si ferma neanche un istante, non ha il tempo per poterlo fare. Colui che ha creato il Tempo, non può permettersi di perderlo. Conosce il futuro e comprende che ogni istante della Sua vita terrena deve essere sfruttato, ogni secondo deve divenire un seme gettato nel solco della Storia per fruttificare. La fretta di Gesù è una fretta santa e santificante, è la fretta di Colui che vuole Redimere il mondo; non agogna la Croce ma comprende che solo attraverso la Croce potrà salvare l'umanità intera. Tutta la strada che Cristo percorre è una strada, consapevole, verso la Croce. Una Croce che lo terrorizzerà, perché nessun uomo potrebbe rimanere inerte di fronte alla consapevolezza di tale tortura, e Gesù è anche uomo; ma la prova viene superata rimettendo tutto alla volontà del Padre. E corre verso la Croce... perché anche la Passione sarà intessuta dalla fretta: hanno fretta i romani per evitare sommosse popolari, ha fretta il Sinedrio per evitare che la situazione possa sfuggire di mano e perché Gesù era un ebreo scomodo... ha fretta il popolo per vedere Barabba liberato. Paradossalmente anche Cristo, durante la Passione, ha fretta... perché "tutto sia compiuto" al più presto.
"Dove sei?"
Gesù quindi parte e si reca in vari villaggi a predicare con i suoi discepoli. Siamo lontani da Gerusalemme, quella Gerusalemme che lo avrebbe visto denudato e posto in mezzo ad altre due croci. Lungo la strada, polverosa come tutte le strade della Palestina, come tutte le strade del mondo, Gesù pone una domanda. Dio che domanda...;Dio che chiede...:e per via interrogava i suoi discepoli dicendo:"Chi dice la gente che io sia"?.
Sembra un paradosso. Dio che conosce tutte le cose, che non avrebbe motivo di chiedere nulla a nessuno, che conosce prima ancora di chiedere... ogni nostro pensiero... ogni nostro impulso... domanda. Ricordo la prima domanda di Dio agli uomini: "Dove sei?" (Genesi 2,9). Siamo nel giardino dell'Eden immediatamente dopo il Peccato; Adamo si nasconde alla vista di Dio e Dio stesso domanda. Dio chiederà sempre all'uomo "dove sei?", in ogni tempo ed in ogni luogo. Senza il Peccato non avrebbe mai posto questa domanda a nessuno, non avrebbe avuto senso perché l'uomo non si sarebbe mai nascosto, vergognandosi, agli occhi di Dio; da allora sarà il filo conduttore di tutta la preoccupazione di Dio per la Sua creatura: "Dove sei Figlio mio? Perché ti sei allontanato da Me? Perché ti nascondi ai Miei occhi? Perché...?". Povero Padre. Abbandonato e scansato, ignorato e rigettato. Un Padre che, nonostante il Peccato, nonostante la fuga dei figli, nonostante la loro riluttanza a farsi Amare... continua a chiedere. Sapendo tutto. Conoscendo tutto. E Dio continua:"Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?". Povero Padre. Certo che lo sai, sai tutto. Ma domandi... sperando che la Tua domanda possa, in qualche modo, stimolare l'uomo a chiedere perdono. Ma niente. Nessuna richiesta di perdono da offrire a Dio:"La donna che tu mi hai posta accanto...". Il resto lo conosciamo. Adamo scarica subito la patata bollente su Eva. E Dio incalza: "Che hai fatto?". Domanda ancora... nonostante conosca ogni minimo particolare.
Dovremmo soffermarci molto di più, io credo, sulla teologia della domanda da parte di Dio. Ci sarebbe molto da imparare per tutti noi che non ci domandiamo, oramai, più nulla. Dio insisterà sempre con le domande, più avanti chiederà:"Dov'è Abele, tuo fratello?", interrogando Caino. Quasi che la domanda avesse potuto lenire il dolore di Dio per il Peccato dell'uomo, quasi che la domanda avesse potuto, una speranza nascosta, fare in modo che si potesse in qualche modo tornare indietro ed evitare il Peccato che grida dal suolo. Ma Dio sa che non è così. Non si torna indietro... non si può, per Giustizia e non per Onnipotenza, tornare indietro.
La Chiesa è per via.
"...e per via interrogava i suoi discepoli". La Chiesa è nata per via. La Chiesa è per via. Se la Chiesa non fosse per via perderebbe il suo significato e la sua essenza più intrinseca, perché la Chiesa non può permettersi di lasciare la via e fermarsi in un luogo ad attendere. La Chiesa non prende, bensì porta. Porta la parola di Dio agli uomini e per farlo deve essere incamminata per le strade del mondo, insieme a tutti gli uomini che sono per via. E chi sono gli uomini per via? Quelli che camminano alla ricerca della Verità, alla ricerca di Dio. Capita spesso che molti di questi uomini prendano, spesso inconsapevolmente, strade sbagliate. Verità sbagliate. Come potrebbe la Chiesa aiutarli se non fosse per via anch'essa? Una Chiesa che non fosse per via non sarebbe Chiesa. Ed una Chiesa che, mentre è per via, non interroga non sarebbe di aiuto a nessuno. La Chiesa è un incontro di coscienze che si interrogano. Gesù è per via... perché l'Amore non riposa mai, riposa solo nei cuori che l'amano; Gesù è in cammino e la casa che cerca, la vera casa che cerca, sono i cuori che lo amano.
"...e per via interrogava i suoi discepoli". Cristo che scruta i cuori dei Suoi discepoli ed interroga le loro anime, conoscendo in anticipo le risposte. I discepoli hanno seguito Cristo perché erano in cerca della Verità, ma questa Verità, spesso, li tormenta: troppe domande e troppi interrogativi nelle loro anime. A volte sono domande ed interrogativi così profondi che quasi si vergognano di parlarne tra di loro. E Dio li interroga per tirare fuori, per aiutarli a tirare fuori, per insegnarli a tirare fuori questi interrogativi:"Chi dice la gente che io sia"?. Io penso che questa sia la Domanda per eccellenza che Dio, nel Suo Verbo incarnato, abbia mai posto all'uomo.
Se questa domanda fosse stata posta da un qualsiasi uomo della terra, avremmo potuto pensare che quest'uomo era interessato, effettivamente, a sapere cosa pensava la gente di lui... ma sappiamo che a Gesù questo non interessa. Gesù non si pone il problema di cosa pensi la gente per sapere se è bene accetto oppure no; Gesù lo sa che non può essere bene accetto. Gesù lo sa che Egli non può essere ben voluto e che non può essere bene amato. Lo sa perché Egli non è del mondo e non parla come il mondo: Egli è del Cielo e parla come e per il Cielo. Una persona qualsiasi si porrebbe, e porrebbe agli altri, il quesito su cosa pensi la gente nei suoi riguardi, per sapere se è bene accetto e magari cambiare atteggiamento, magari anche contro voglia e contro la propria natura, magari anche contro la propria morale... ma l'importante è che la gente pensi bene. l'importante è essere accettato dalla gente... essere accettato dal mondo. No... Gesù non pone una domanda del genere per pura curiosità, per sapere se la gente lo approva. Egli è a conoscenza di ogni pensiero, di ogni sussurro, di ogni sillaba che viene proferita nei Suoi confronti; non avrebbe nessun interesse a chiederlo ai Suoi. Ma se lo fa, allora, vi è una ragione molto più importante e più profonda. Una ragione che, a seconda della risposta, servirà ai Suoi stessi discepoli.
"Chi dice la gente...".
"Chi dice la gente...". La gente. Gesù parlando della gente vede già la folla, la gente, che lo acclama durante l'ingresso pasquale a Gerusalemme. La stessa gente che avrebbe, qualche ora più tardi, urlato sotto le finestre di Pilato per far liberare Barabba. Gesù conosce bene la gente. La gente è una massa informe ed influenzabile, un'umanità che si lascia attrarre e respingere, e che respinge essa stessa, con la stessa facilità. Gesù Cristo parlava alle masse, ma le Sue parole erano dirette ad ogni singolo cuore. Ad ogni singola anima. Con le masse ha sempre dovuto faticare parecchio... a questo proposito ricordiamo un passo del Vangelo di Luca, in 12,1: "Nel frattempo, radunatesi migliaia di persone che si calpestavano a vicenda...". Vedete la gente... non si può assolutamente dire che Gesù sia stato ignorato dai suoi contemporanei, anzi. Migliaia di persone, ci riferisce San Luca, si accalcavano e si calpestavano a vicenda per ascoltare la parola di Gesù. E vedo questa massa informe di persone, perché la massa è sempre informe, sempre senza nome; e vedo Gesù che vede. Gesù che guarda questa massa, queste persone che si calpestavano a vicenda e prova un senso di angoscia. Quante di quelle persone si calpestavano perché Lo amavano? Quante di quelle persone lo cercavano con vero spirito di Verità? Quella Verità che Dio ha infuso in ogni singola coscienza? Gesù sapeva quante... e gli dispiaceva che ci fossero disordini, gli dispiaceva che la gente, invece che accostarsi a Lui con ordine e tranquillità, si affrettasse e si accalcasse rischiando anche la propria vita. A noi non risulta che sia mai morto nessuno schiacciato dalle folle che seguivano Gesù, ma se ciò è avvenuto è stato solo e soltanto per una volontà divina. Non si poteva permettere che qualcuno morisse per andare a vedere Gesù Cristo parlare, predicare e... fare Miracolo. Dio non lo avrebbe mai permesso. Ma tra il perdere la vita schiacciati ed il farsi male, forse anche seriamente, vi è una netta distinzione. Assolutamente non credo che nessuno, mai, si sia fatto male nella ressa che seguiva alle apparizioni pubbliche di Cristo; ed è lo stesso San Luca a ricordarcelo:"...migliaia di persone che si calpestavano a vicenda...". Stiamo parlando di migliaia... non di decine o centinaia di persone seduti in prati aperti o su dolci colline al fresco degli alberi in fiore. Stiamo parlando di migliaia di persone che stringevano d'assedio Cristo ed i Suoi, da ogni lato e da ogni parte, anche nei villaggi più dimenticati. Era una vera bolgia dove vi era di tutto: uomini, donne, bambini, malati, spie, soldati, indemoniati... ed ognuno di loro, a parte gli indemoniati, voleva vedere, toccare e, possibilmente, parlare con Gesù. Ognuno per un motivo diverso ma ugualmente, per la propria causa, importante. Gli apostoli, datemi retta, avevano un bel da fare per evitare che si facessero male loro stessi, figuriamoci se potevano creare un servizio d'ordine efficiente. Non ci riusciamo, in alcune occasioni, neanche noi oggi; nonostante le attrezzature di cui disponiamo e le capacità tecniche. Dicevamo quindi che se mai nessuno è perito in quelle resse, lo si deve solo ed unicamente alla Onnipotenza di Dio Padre che, in quelle masse, vedeva i Suoi figli dispersi.
Ma i Suoi apostoli non erano una massa. I suoi apostoli erano i pilastri della nuova Chiesa nascente, gli araldi del Nuovo patto che Dio stava suggellando e sigillando con il mondo. E domanda loro..."Chi dice la gente che io sia"?. Vuole spronarli a confidarsi, vuole insegnare loro a diventare più attenti alla loro coscienza lasciando stare cosa dice la gente. Lasciando stare cosa dice il mondo. Per un cristiano è fondamentale rimanere in ascolto della propria coscienza, senza lasciarsi sopraffare dalle voci della gente e del mondo. In fondo, se questa mattina uscendo di casa mi si fosse affiancato Gesù (per fare un pezzo di strada con me), penso che la prima domanda (semmai me ne avesse fatta una...) che mi avrebbe posto sarebbe stata proprio questa: "Chi dice la gente che io sia"?. Perché oggi come allora, il mondo dice tante cose di Cristo: per un ebreo, Cristo era (ed è) un esaltato ed un bestemmiatore; per un musulmano, Cristo era (ed è) un profeta che avrebbe spianato la strada a Maometto; per un protestante, Cristo era (ed è) Cristo ma con altri fratelli e sorelle...; per un Testimone di Geova, Cristo era (ed è) l'incarnazione di un arcangelo; per le altre religioni, Cristo era un fallito; per chi non Lo ha mai sentito nominare, non è nessuno; infine per i cristiani cattolici, chissà se Cristo è, ancora, o almeno per tutti, ritenuto veramente Dio.... ed infatti Gesù, dopo aver sentito, dalla risposta dei Suoi, che alcuni lo indicavano come il Battista, altri come Elia, altri ancora come uno dei tanti profeti dei tempi antichi, chiede: "E voi chi dite che io sia?".
Gesù pellegrino per le strade del mondo.
Gesù li spiazza e li provoca. Gesù chiede alla Chiesa, perché in quel momento erano già Chiesa, anche se latente, cosa la Chiesa pellegrina (in fondo erano o non erano per via? Erano o non erano in perenne pellegrinaggio?) pensasse di Lui. Etimologicamente la parola pellegrinaggio deriva dal latino peregrinatio: viaggio in terra straniera. Bellissimo... le parole hanno sempre un significato molto più profondo di quello che, superficialmente, sembrano dire. Ogni pellegrino compie un viaggio in terra straniera alla ricerca della propria identità: in ogni religione esistono i pellegrinaggi verso i propri luoghi sacri. Gesù cristo viene in terra straniera a cercare delle anime da Amare e da cui ricevere amore. Il pellegrinaggio di Dio, in questo senso del termine, non avrà mai fine perché l'Amore non conosce pause, l'Amore non conosce soste. Il Pellegrino che mentre passa sana le infermità degli uomini, ad un tratto, proprio ai suoi più stretti collaboratori, lo abbiamo visto, pone una domanda precisa e spiazzante. E pretende una risposta.
Gesù ancora oggi chiede alla Chiesa pellegrina sulla terra cosa pensiamo di Lui; Chiesa formata da un capo, Cristo, e dalle Sue membra, i cristiani. Ad ognuno di noi, Gesù chiede ogni giorno, cosa pensiamo di Lui. E se questa domanda venne posta, e viene posta ancora oggi, significa che è veramente una domanda importante. Anzi: che la risposta è importante. Tutto il cristianesimo non avrebbe senso se, ogni giorno, quotidianamente, la Chiesa non avesse ben chiaro chi sia Cristo. La Chiesa da duemila anni, in quanto Istituzione, diffonde la Verità sulla persona di Cristo; ma la Chiesa è anche fatta da milioni di uomini battezzati, i quali non sempre si pongono queste domande e non sempre sono interessati a fornire le risposte alla coscienza che chiede. A Dio che interroga... Gesù provoca perché senza la provocazione il cristianesimo non si comprenderebbe nel suo vero significato: tutto il cristianesimo è una provocazione, sia tacita che esplicita. Un Dio che si incarna, che pretende di liberare l'umanità ma non con la forza delle armi; un Dio che si dichiara Onnipotente e che si lascia uccidere in Croce; un Dio che si pronunzia Re ed è un morto di fame... un pezzente al punto tale da non avere un luogo dove posare il capo. Un Dio che si rende presente... nel Pane e nel Vino. Se non sono provocazioni queste.... un Dio che ti promette la Vita Eterna e... che muore! Sarebbe interessante affrontare anche uno studio sulla teologia della provocazione da parte di Dio.
Cristo ha voluto saggiare la fede del mondo in questo modo, e quotidianamente continua a farlo. Basta pensare a quanto sia difficile e controcorrente essere cristiani oggi... a quanto sia provocante quell'Uomo in Croce. A quanto sia combattuto e vilipeso, a quanto sia odiato e bestemmiato più che sotto la Croce sul Golgota. Molto di più. Con una perfidia ancora maggiore e con un odio sempre più devastante. Odiato Lui, odiati noi. Se siamo per strada insieme a Gesù, se siamo veramente per strada, allora non possono che odiarci. Chi? Ma è ovvio: la gente.
"Tu sei il Cristo".
"E voi chi dite che io sia?". Mi immagino il volto di Gesù che, fermo in mezzo alla strada polverosa, in un momento in cui la gente si era eclissata, fissa negli occhi i Suoi e li scruta uno ad uno... ed ascolta i loro pensieri... i loro moti più intimi dello spirito... le loro paure... i loro dubbi. Ma Gesù non li guarda aspramente, non li guarda con il volto di Giudice, non li guarda facendo intendere che a risposta sbagliata avrebbero ricevuto una punizione adeguata. No. Questo sguardo sarebbe stato, forse, dell'uomo che avevamo preso prima ad esempio. L'uomo come me, come te, l'uomo comune. L'uomo che chiede ed interroga gli altri per sapere cosa la gente pensi di lui. Cosa la gente pensi di noi, di te, di me. Egli, invece, il Cristo, li guarda con Amore. Come sempre. Li guarda con immenso Amore. L'evangelista non ci indica per quanto tempo, non ci dice se la risposta sia giunta subito oppure se abbia dovuto attendere qualche istante; ci dice, però, che Pietro gli rispose:"Tu sei il Cristo".
Pietro risponde. Perché Pietro? E perché solo Pietro? Perché nessun'altro disse niente? Nessuno la pensava come Pietro, allora? Non credo... non tutti almeno... ma, allora, perché non rispose nessun tra coloro che la pensavano come Pietro? Io penso che non avevano il coraggio per rispondere, non ancora. Gesù insegna che non è importante solo il conoscere chi sia Lui, ma che bisogna anche avere il coraggio di affermarlo. Sono esistite tante persone che sapevano e credevano in Gesù, in chi era Lui, ma che poi non hanno avuto il coraggio di affermarlo. E tante ne esisteranno ancora... Gesù chiede di non vergognarsi di Lui, di non vergognarsi se la gente la pensa diversamente rispetto a come la pensiamo noi. Perché se sappiamo che come la pensiamo noi è un pensare retto e giusto, in piena coscienza, allora non dobbiamo vergognarci di nulla. Chi si vergognerà di Cristo davanti agli uomini, Cristo si vergognerà di lui davanti al padre Suo che è nell'alto dei Cieli.
Duemila anni fa Gesù disse loro, dopo la coraggiosa risposta di Pietro, di non parlarne con nessuno. Oggi la situazione è mutata, e di molto anche. Quel non parlare con nessuno valeva per loro, e solo per loro, in quel preciso istante della Storia, perché la missione di Cristo doveva ancora essere compiuta. Gesù era attento a fare in modo che la gente non lo seguisse per pura curiosità, per sollazzo e per divertimento. Per vedere il miracolo... non vuole e non si può permettere che la Sua missione pubblica prenda la piega, sbagliata, di un'apparizione "circense". Non può permettersi di vedere la Sua missione osteggiata ed ostacolata più di quello che già era, più di quello che sarebbe, da lì a poco, veramente stata. Inoltre abbiamo anche visto, e non è di secondaria importanza, che Dio aveva a cuore che non si facesse male nessuno nel seguire Gesù.
Gli apostoli non dovevano parlare, ancora, con nessuno di quella particolare Verità. Verità particolare ma allo stesso tempo estremamente centrale. Sarebbe poi giunto, per loro e per noi, il tempo in cui quella Verità sarebbe stata proclamata sui tetti del mondo a tutte le genti perché Egli è veramente il Verbo, Egli è veramente Colui che Redime con le Sue Sante Piaghe, Egli è veramente la Luce del mondo.
Egli è veramente il Cristo.
Che la Pace di Cristo sia con tutti voi.
Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo: e per via interrogava i suoi discepoli dicendo: "Chi dice la gente che io sia?". Ed essi gli risposero: "Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti". Ma egli replicò: "E voi chi dite che io sia?". Pietro gli rispose:"Tu sei il Cristo". E impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno.
(Vangelo di Marco 8,27-30)
Inchiesta sulla nascita di Gesù: le ultime scoperte rivelano che…
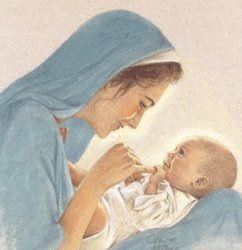
Era lì dunque la registrazione anagrafica della nascita – fatta da due giovani ebrei – di un bambino chiamato Yehòshua’, Gesù, che significava “Dio salvatore”. Incendi e distruzioni hanno perduto quei documenti. Sempre lì dovette trovarsi anche la relazione a Tiberio che Ponzio Pilato scrisse verso il 35 d.C. per giustificare processo ed esecuzione dello stesso Gesù. Da cui venne la proposta di Tiberio al Senato di riconoscere quel Gesù come Dio, ossia di legittimare il culto di Cristo che si stava diffondendo. Il Senato rispose di no. La notizia è contenuta in un passo dell’Apologetico (V,2) di Tertulliano ed è stata recentemente dimostrata attendibile da un’autorevole storica, Marta Sordi.
Ma torniamo a quel censimento. Negli studi della “Scuola di Madrid” – sintetizzati nel libro “La vita di Gesù” di Josè Miguel Garcia - trova soluzione anche il problema cronologico del censimento che finora non si sapeva quando collocare e pareva storicamente dubbio.
Perché Giuseppe e Maria devono andare a Betlemme il cui nome, beth-lehem, in ebraico significa “città del pane”? Perché Erode, per conto dei romani, ha imposto un giuramento-censimento. Le autorità di Betlemme pretendono che della famiglia di Davide non manchi nessuno: Giuseppe è un discendente dell’antico casato reale che è tenuto particolarmente d’occhio. Soprattutto in questi anni nei quali – a causa di alcune profezie e di alcuni segni - si è fatta fortissima l’idea che il Messia stia per arrivare. Si sa infatti che il “liberatore” che gli ebrei aspettano è di sangue reale. E dunque quelli della famiglia di Re David sono tutti “sospetti”.
E’ per queste origini che la famiglia di Gesù, pur essendo diventata modesta e umile, custodisce gelosamente le genealogie che non a caso si trovano riportate nei vangeli. Genealogie che raccontano storie terribili, su cui i vangeli non sorvolano affatto. Tanto da stupire quel poeta cattolico che fu Charles Péguy:
“...bisogna riconoscerlo, la genealogia carnale di Gesù è spaventosa… E’ in parte ciò che dà al mistero dell’Incarnazione tutto il suo valore, tutta la sua profondità, tutto il suo impeto, il suo carico di umanità. Di carnale”.
Secondo uno studio recente nelle origini familiari di Gesù troviamo la stessa tribù discendente da Caino, il primo omicida della storia. In Numeri 24, 21 si dice che i Qeniti sono i discendenti di Caino, verranno assorbiti dal popolo ebraico e la loro terra è dove poi sorgerà Betlemme. In un passo successivo (34,19) con Giosuè sono raccolti, per la spartizione della terra conquistata, i capi delle dodici tribù d’Israele. A capo della tribù di Giuda sta Kaleb detto il Qenizita, a cui Giosuè assegna una porzione della terra di Giuda. I Qeniti, spiega Tommaso Federici, sono dunque “una sottotribù di Giuda, la loro terra sta nella ‘parte montagnosa’, con capitale Hebron. Essa comprendeva la Betlemme di Kaleb, attraverso la sua sposa Efrata”. Dunque “i Davididi sono i Qeniti o Cainiti”. Ecco – commenta Federici “sopra quale abisso è disceso l’Immortale Eterno per assumere la carne dei peccatori. Cristo Signore così riassume in sé ogni Caino d’ogni tempo, per salvarlo”. Gesù dunque è “il segno” che Dio aveva posto sopra Caino “per cui questi ha salva la vita”.
Nel profeta Isaia leggiamo infatti:
“Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori… è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti”.
Nello stesso ceppo familiare di Gesù sono riassunti “sia Israele, sia Giuda, sia i pagani ed i peccatori più lontani. Di fatto” spiega Federici “a Betlemme, Booz, antenato di David, sposando Rut la Moabita, dunque pagana e idolatra, l’inserisce a pieno titolo nel popolo di Dio, tanto che diventa antenata di David”.
La predilezione di Dio non è caduta sui migliori, ma su dei peccatori. Fra i figli di Giacobbe viene scelto Giuda, il quartogenito, uno dei fratelli che avevano venduto Giuseppe. Uno la cui moralità crolla platealmente nell’unione con la nuora, Tamar, unione da cui discende legalmente Gesù. Della sua genealogia fanno parte poi dei re idolatri, immorali e qualcuno criminale. Lo stesso Davide, il più grande dei re e il più amato da Dio, commette peccati e delitti spaventosi. Le donne della genealogia di Gesù scriveva il cardinale Van Thuan “colpiscono per le loro storie, sono donne che si trovano tutte in una situazione irregolare e di disordine morale: Tamar è una peccatrice, che con l’inganno ha avuto una unione incestuosa col suocero Giuda; Raab è la prostituta di Gerico che accoglie e nasconde le due spie israelite inviate da Giosuè e viene ammessa nel popolo ebraico; Rut è una straniera; della quarta donna… ‘quella che era stata moglie di Urìa’, si tratta di Betsabea, la compagna di adulterio di David”.
Sembra una storia terribile, eppure è la storia della salvezza. La storia da cui è nato Gesù che ha voluto riservarsi – totalmente puri e santi – solo gli ultimi rampolli di quei clan familiari: Maria e Giuseppe. Che dunque arrivano a Betlemme dove nasce Gesù. A lungo si è ritenuto che il 25 dicembre fosse una data convenzionale, scelta per contrastare le feste pagane del Natale Solis invicti (da identificare forse con Mitra, forse con l’imperatore romano). Ma recentemente una scoperta archeologica fatta tra i papiri di Qumran ha clamorosamente suggerito la possibile esattezza di quella data. Dal “Libro dei Giubilei” uno studioso israeliano, Shemarjahu Talmon ha ricostruito la successione dei 24 turni sacerdotali relativi al servizio nel Tempio di Gerusalemme e ha scoperto che “il turno di Abia” corrispondeva all’ultima settimana di settembre.
Notizia importante perché si lega a una informazione cronologica del Vangelo di Luca (1,5) secondo cui Zaccaria, il padre di Giovanni Battista e marito di Elisabetta, appartenente alla tribù sacerdotale di Abia, vide l’Angelo, che annunciava il concepimento di Giovanni, proprio mentre “officiava davanti al Signore nel turno della sua classe”. Quindi a fine settembre.
Il rito bizantino che da secoli fa memoria dell’annuncio a Zaccaria il 23 settembre deriva dunque da un’antica memoria, forse una tradizione orale. La Chiesa tutta poi celebra nove mesi dopo la nascita del Battista e tutta la liturgia cristiana è impostata su questa data giacché Luca (1, 26) spiega che l’annuncio a Maria avviene quando Elisabetta era al sesto mese di gravidanza. In effetti la Chiesa celebra l’Annunciazione il 25 marzo e il Natale del Signore nove mesi dopo, il 25 dicembre (lo attesta già un calendario liturgico del 326 d.C.). Ne discende che se ha fondatezza storica l’annuncio a Zaccaria il 23 settembre, a catena – come ha dimostrato Antonio Ammassari - acquisiscono storicità anche la data dell’Annunciazione e quella del Natale.
Dal recente libro di Garcia si apprende pure la verità sul luogo della nascita di Gesù. Il contesto deve essere non una grotta, ma la grande casa paterna di Giuseppe a Betlemme. “Tali case erano costituite da un’unica grande stanza, dove le persone occupavano una specie di piattaforma rialzata, mentre in un’estremità si trovavano gli animali di cui la famiglia aveva bisogno per lavorare. E per questi animali era ovvio che ci fosse una mangiatoia”.
Probabilmente Giuseppe e la giovane partoriente, per avere un po’ di riservatezza e più caldo, furono alloggiati in questa parte della casa e il bambino fu posto in quella mangiatoia. E’ con una storia così ordinaria, così normale, che Dio – per i cristiani – è venuto nel mondo. E con lui la bellezza, la bontà e la salvezza. Incontrarlo è il senso della vita. Scrive Péguy: “Felici coloro che bevevano lo sguardo dei tuoi occhi”.
* * *
Così dormiva il bambino il suo primo sonno profondo.
Stava per cominciare l’immenso evento.
Stava per cominciare l’immenso avvento.
L’avvento dell’ordine e della salvezza dell’uomo.
Assorto, il bambino dormiva un sonno profondo.
Stava per cominciare il grande comando.
Stava per cominciare il grande avvento,
l’avvento di Dio nel cuore dell’uomo.
Charles Péguy
